Uomo del mio tempo (1945) di Salvatore Quasimodo, fenomenale poesia contro la guerra
Scopri il significato di “Uomo del mio tempo” di Salvatore Quasimodo, la poesia contro la guerra e che apre alla speranza delle nuove generazioni.
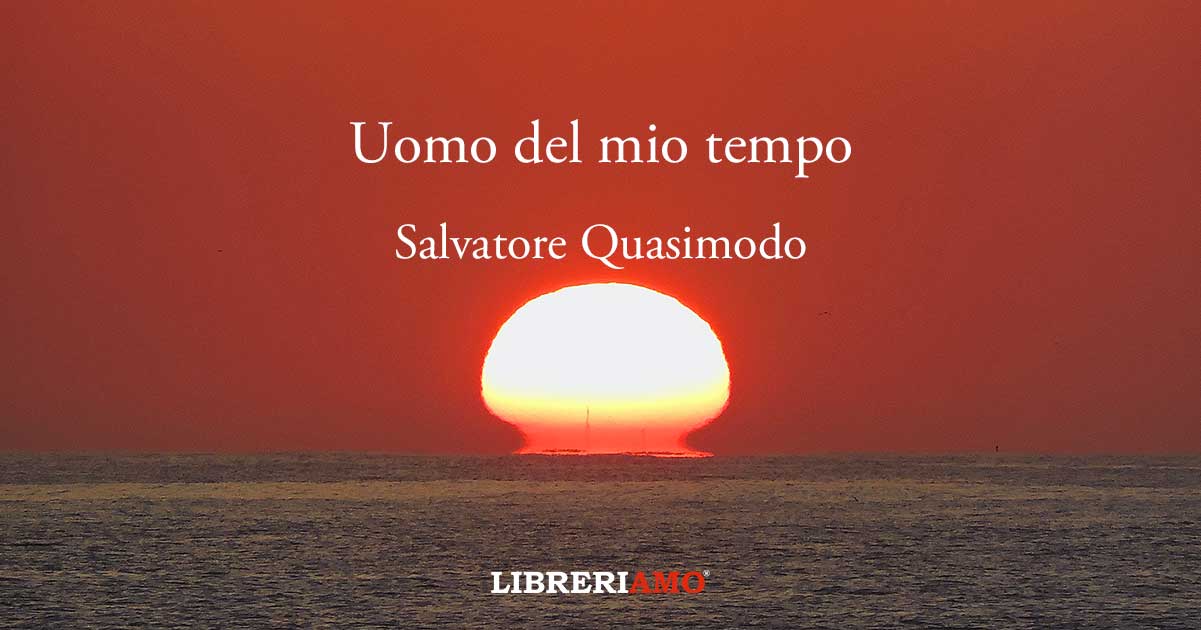
Ci sono poesie che sembrano scritte per un’epoca precisa e che, invece, continuano a parlarci con una forza disarmante. Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo è una di queste. Nata dalle macerie morali e materiali della Seconda guerra mondiale, questa poesia non è soltanto un atto d’accusa: è un grido disperato contro la follia umana, contro chi non ha ancora compreso il pericolo della guerra, delle armi, del nucleare.
È il monito di un poeta che, pur immerso nella sfiducia, riesce a donare un segno di speranza. Perché, se l’uomo continua a ripetere gli errori del passato, l’unica possibilità di salvezza è riposta nelle nuove generazioni.
Uomo del mio tempo rivela una geniale contemporaneità. Siamo ancora oggi sull’orlo del baratro, dove gli uomini sembrano orientati all’auto distruzione. La poesia fu scritta nel 1945 e compare come ultimo componimento nella raccolta Giorno dopo giorno di Salvatore Quasimodo pubblicata per la prima volta nel 1947.
Leggiamo la poesia di Salvatore Quasimodo per coglierne e sposarne il messaggio.
Uomo del mio tempo di Salvatore Quasimodo
Sei ancora quello della pietra e della fionda,
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello:
«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
Salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
L’uomo non è mai cambiato: da Caino ad oggi la violenza resta il suo marchio
Il tema centrale di Uomo del mio tempo è il fatto che la natura umana sia rimasta, nonostante millenni di evoluzione, la stessa di quella dell’uomo della pietra. L’egoismo e le pulsioni distruttive sono la chiave del modo di agire che spinge l’uomo alla guerra. Sembriamo non renderci conto di cosa possa comportare.
L’uomo utilizza la propria conoscenza per distruggere. L’evoluzione della scienza che dovrebbe essere totalmente al servizio dell’Umanità e del Pianeta, viene sempre più utilizzata per generare macchine e dispositivi in grado di generare morte.
Non impariamo niente dagli errori del passato. Tutta sembra sfumare davanti alla forza egoistica degli umani. L’”uomo del mio tempo” per Salvatore Quasimodo ha perso ogni tipo di considerazione per i suoi simili. Solidarietà, fratellanza, religione sono valori utopici. la violenza sembra essere l’unica spinta evolutiva degli esseri umani.
Siamo come Caino e Abele
Caino e Abele sono l’eterna certezza dell’animo e della psiche umana. Quasimodo, quindi con la poesia lancia un appello di speranza. Le nuove generazioni devono discostarsi di ciò che hanno fatto i loro predecessori, i quali è tangibile hanno la ferocia degli avvoltoi nel cuore, alla ricerca di cadaveri da generare..
La crudeltà umana nei secoli è sempre la se stessa: l’uomo era e rimane primitivo. L’orrore e la sfiducia negli umani di Salvatore Quasimodo è presente anche in altri suoi componimenti come Alle fronde dei salici e Ed è subito sera.
Ciò che di positivo trasmette la poesia è la speranza e la fiducia nelle nuove generazioni: perché quanto accaduto possa, finalmente, non ripetersi.
Il grido profondo di un uomo che scorge l’eterno primato della violenza
In Uomo del mio tempo, Quasimodo ci spinge a guardarci allo specchio. Il soggetto, l’“uomo del mio tempo”, è il lettore stesso: inizia come un’intimazione, quasi un rimprovero. Siamo ancora “quello della pietra e della fionda” nonostante le armature tecnologiche. L’autore denuncia una verità scomoda: l’essenza immutata dell’umanità, capace di restare primitiva anche nell’era dei bombardieri e dei carri armati.
Le immagini delle “ali maligne”, delle “meridiane di morte”, del “carro di fuoco” refittamente evocano strumenti tecnologici trasformati in veicoli di terrore. L’ingegno umano, intriso di precisione, si piega alla logica dello sterminio: la scienza esatta, razionale è “persuasa allo sterminio”, senza amore, senza Cristo. In questi versi, Quasimodo condanna un sapere privo di etica e accorato dall’“assenza di pietà”
“Come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali…”. Questa simmetria tragica ci pone nel continuum del delitto fratricida che affonda fin nella preistoria. E l’eco di Caino che dice ad Abele “Andiamo ai campi” è viva, ancora “fredda, tenace”, si insinua dentro la nostra giornata. L’uomo evolve nelle armi, non nel cuore.
Da una parte l’accusa, dall’altra un appello forte e urgente: i versi finali rivolgono la parola ai figli, cioè alle future generazioni. “Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue… dimenticate i padri” diventa un imperativo morale. La poesia, fredda nel descrivere l’orrore, si riscalda nella speranza. La cenere, gli uccelli neri, il vento coprono il cuore dei padri, ma i figli possono risorgere, cancellare queste tracce di dolore e costruire una nuova umanità libera dalla violenza ereditaria
Uomo del mio tempo scuote le coscienze e ricorda che la violenza non è superata, anzi è raffinata. La scienza diventa crudeltà. Ma in questo pessimismo si apre un barlume di possibilità. Le nuove generazioni possono interrompere il ciclo. Salvatore Quasimodo spinge gli umani guardare con occhi nuovi, o forse meglio antichi, per capire la nostra responsabilità verso il futuro.
Senza fratellanza l’uomo resta primitivo, anche nell’era del progresso
La grandezza di Uomo del mio tempo sta nel suo essere non solo una poesia, ma un’analisi sociologica travestita da canto lirico. Quasimodo ci mostra che la storia dell’umanità non è una linea ascendente di progresso, ma una spirale che rischia sempre di tornare al punto di partenza: la violenza primordiale.
La scienza, il potere, l’ingegno tecnico non bastano a garantire un’evoluzione vera se non sono accompagnati da valori etici e da un senso di comunità.
Siamo ancora uomini della pietra e della fionda perché non abbiamo imparato a gestire i conflitti se non con la sopraffazione. L’umanità, nell’interpretazione di Quasimodo, vive di continuità con Caino, segnata dal sangue del fratello. È qui che la poesia diventa sociologia: mette in luce il fallimento delle istituzioni, delle culture e delle religioni nel costruire una coscienza collettiva capace di fermare la guerra.
Eppure, la forza dell’ultimo verso ribalta il pessimismo. L’appello ai figli non è solo letterario, ma è un invito sociologico e politico: spezzare la catena della violenza significa riscrivere le regole del vivere insieme, fondare nuove relazioni sociali, costruire un’umanità più consapevole.
In questo senso, la poesia di Quasimodo continua a parlarci come un manifesto universale: ci ricorda che la civiltà non è un dato acquisito, ma una scelta quotidiana. E che la vera evoluzione non è nelle macchine, ma nella capacità di riconoscersi fratelli.