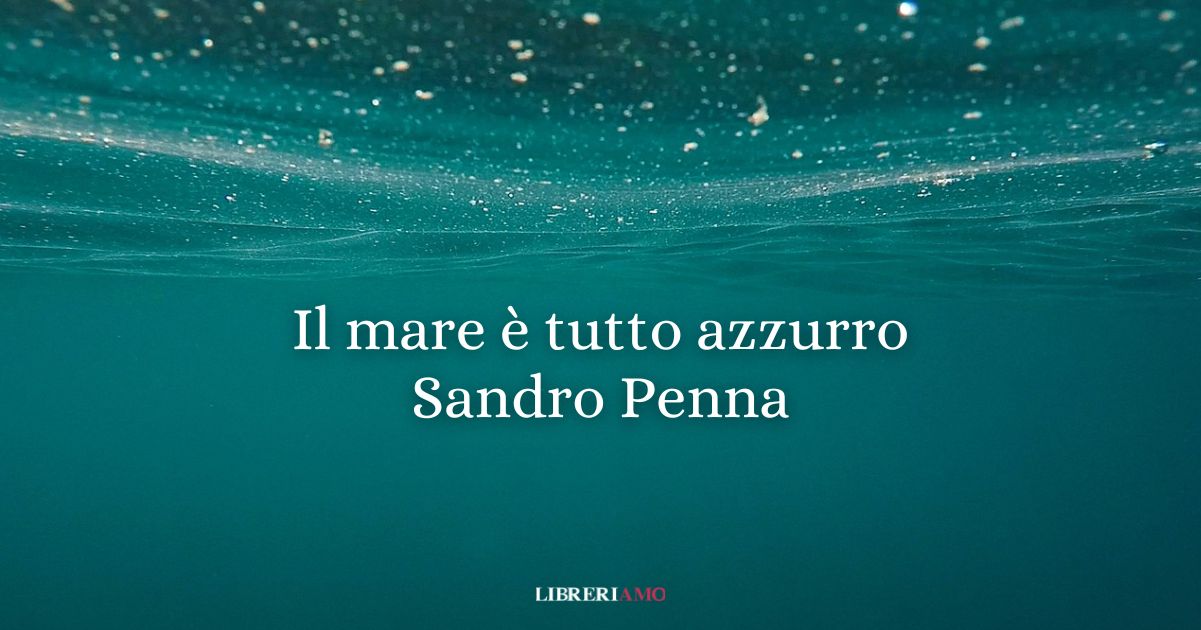La vita non è fatta solo di successi: sarà capitano anche a voi di “fare una Caporetto”. Non avete mai sentito questo modo di dire? Sicuramente, conoscerete però l’aneddoto storico legato a questa espressione. Ma procediamo con ordine e scopriamo origine e significato di questo modo di dire.
Il significato di “fare una Caporetto”
L’espressione “fare una Caporetto”, o anche soltanto il termine “Caporetto”, è utilizzata in italiano come sostantivo femminile e ha il significato figurato di “disfatta ingloriosa”, “sconfitta pesantissima”, “fallimento assoluto”, “sciagura enorme”.
Risulta frequentissimo il suo uso in ambito sia politico sia sportivo. Ma perché si dice “una caporetto” per indicare una sconfitta pesante?
L’origine del modo di dire
L’espressione fa direttamente riferimento alla battaglia di Caporetto, o dodicesima battaglia dell’Isonzo: si tratta di uno scontro combattuto durante la prima guerra mondiale tra le forze congiunte degli eserciti austro-ungarico e tedesco, contro il Regio Esercito italiano. L’attacco, cominciato alle ore 2:00 del 24 ottobre 1917, portò alla più grave disfatta nella storia dell’esercito italiano, tanto che ancora oggi il termine Caporetto è utilizzato come sinonimo di sconfitta disastrosa (e non solo nella lingua italiana).
La battaglia di Caporetto
Il contesto è quello della Prima Guerra Mondiale, la guerra di logoramento per eccellenza. Sul fronte italiano, inoltre, la guerra era combattuta in luoghi impervi e spesso inaccessibili. L’esercito italiano, indebolito da una serie di lunghe battaglie in zona e colto impreparato a causa di una mancata organizzazione e difficoltà di comunicazione da parte dei piani alti, non ressero l’impatto dell’attacco di un esercito austro-ungarico altresì. L’esercito italiano pagò un prezzo altissimo: almeno 10000 morti, 30000 feriti e poco meno di 300000 prigionieri, oltre a un milione di profughi italiani che furono costretti a scappare.
Altri modi di dire provenienti dal linguaggio militare
“Caporetto” non è l’unico modo di dire proveniente dal linguaggio militare: esistono diverse altre espressioni ancora usate come “terra di nessuno” (indica un territorio non rivendicato da nessuno stato o autorità che nasce durante la prima guerra mondiale per indicare l’area situata tra due trincee nemiche in cui nessuna delle due parti voleva muoversi apertamente o che nessuno voleva prendere per paura di essere attaccato dal nemico durante l’azione); “franco tiratore” (si riferisce oggi a chi, in politica, sfruttando il voto segreto non segue le indicazioni del proprio partito, espressione che ha origine durante la guerra franco-prussiana del 1870 per descrivere chi si opponeva all’occupazione o all’evacuazione di città).
Molte espressioni di origine “bellica” traggono origine dalla posizione che i soldati avevano in guerra, come “essere in trincea” (significa essere in una situazione molto difficile da gestire o di opposizione che trae origine dal fossato difensivo usato in guerra), “essere in prima linea” (significa essere in prima fila, cioè al fronte, a contatto con la minaccia o il pericolo) e “stare nelle retrovie” (in riferimento alla zona arretrata di un gruppo di soldati dove si raccoglie e si ordina tutto ciò che serve ad alimentare l’attività nell’area di combattimento). Abbiamo infine altre espressioni morte, come “scemo di guerra”, “mutilato nel cervello”.
Perché diciamo così
Questa e altre espressioni idiomatiche sono protagoniste all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.
Un “libro di società” perché permette di essere condiviso e di “giocare” da soli o in compagnia alla scoperta dell’origine e dell’uso corretto dei modi di dire che tutti i giorni utilizziamo. Un volume leggero che vuole sottolineare l’importanza delle espressioni idiomatiche. Molte di esse sono cadute nel dimenticatoio a causa del sempre più frequente utilizzo di espressioni straniere e anglicismi.