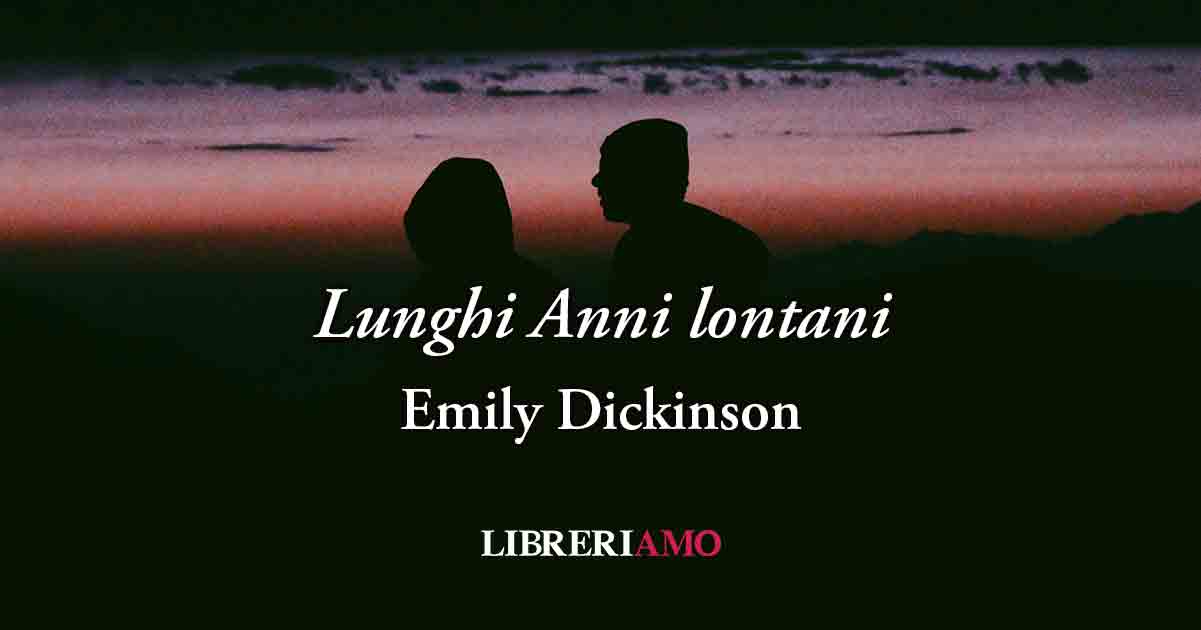Il 27 ottobre 1932 nasceva Sylvia Plath, l’autrice che più ha contribuito allo sviluppo del genere della poesia confessionale in America, iniziato da Robert Lowell e William De Witt Snodgrass. Nei versi di Lady Lazarus, poesia contenuta nella raccolta postuma Ariel, la poetessa americana sembrava addirittura già preannunciare la sua morte. In questo articolo, scopriamo alcune fra le sue poesie più significative.
Le poesie più celebri di Sylvia Plath
Io sono verticale (1961)
Ma preferirei essere orizzontale.
Non sono un albero con radici nel suolo
succhiante minerali e amore materno
così da poter brillare di foglie a ogni marzo,
né sono la beltà di un’aiuola
ultradipinta che susciti grida di meraviglia,
senza sapere che presto dovrò perdere i miei petali.
Confronto a me, un albero è immortale
e la cima di un fiore, non alta, ma più clamorosa:
dell’uno la lunga vita, dell’altra mi manca l’audacia.Stasera, all’infinitesimo lume delle stelle,
alberi e fiori hanno sparso i loro freddi profumi.
Ci passo in mezzo ma nessuno di loro ne fa caso.
A volte io penso che mentre dormo
forse assomiglio a loro nel modo piu’ perfetto –
con i miei pensieri andati in nebbia.
Stare sdraiata è per me piu’ naturale.
Allora il cielo ed io siamo in aperto colloquio,
e sarò utile il giorno che resto sdraiata per sempre:
finalmente gli alberi mi toccheranno, i fiori avranno tempo per me.
Limite (Febbraio 1963, scritta poco prima di morire)
La donna ora è perfetta
Il suo corpo
morto ha il sorriso della compiutezza,
l’illusione di una necessità greca
fluisce nei volumi della sua toga,
i suoi piedi
nudi sembrano dire:
Siamo arrivati fin qui, è finita.
I bambini morti si sono acciambellati,
ciascuno, bianco serpente,
presso la sua piccola brocca di latte, ora vuota.
Lei li ha raccolti
di nuovo nel suo corpo come i petali
di una rosa si chiudono quando il giardino
s’irrigidisce e sanguinano i profumi
dalle dolci gole profonde del fiore notturno.
La luna, spettatrice nel suo cappuccio d’osso,
non ha motivo di essere triste.
E’ abituata a queste cose.
I suoi neri crepitano e tirano.
Monologo delle 3 del mattino
È meglio che ogni fibra si spezzi
e vinca la furia,
e il sangue vivo inzuppi
divano, tappeto, pavimento
e l’almanacco decorato con serpenti
testimone che tu sei
a un milione di verdi contee da qui,
che sedere muti, con questi spasmi
sotto stelle pungenti,
maledicendo, l’occhio sbarrato
annerendo il momento
che gli addii vennero detti, e si lasciarono partire i treni,
ed io, gran magnanimo imbecille, così strappato
dal mio solo regno.
Orlo
La donna è compiuta.
Il suo corpomorto ha il sorriso della perfezione.
L’illusione di una necessità grecascorre nelle volute della sua toga,
i suoi nudipiedi sembrano dire:
siam giunti fino a qui, ora è finita.Ogni bambino morto rannicchiato,
serpente bianco, accanto alla sua piccolabrocca di latte, adesso vuota.
Li ha ella ripiegatidi nuovo nel suo corpo come petali
di rosa che si chiudono, se l’ortosi irrigidisce e sanguinano odori
dalle dolci, profonde gole del fiore notturno.La luna non ha nulla da esser triste,
guardando giù dal suo cappuccio d’osso.Conosce bene tutte queste cose.
Le sue macchie nere frusciano e si stirano.
Papaveri a luglio
Piccoli papaveri, piccole fiamme d’inferno,
Non fate male?
Guizzate qua e là. Non vi posso toccare.
Metto le mani tra le fiamme. Ma non bruciano.
E mi estenua il guardarvi così guizzanti,
Rosso grinzoso e vivo, come la pelle di una bocca.
Una bocca da poco insanguinata.
Piccole maledette gonne!
Ci sono fumi che non posso toccare.
Dove sono le vostre schifose capsule oppiate?
Ah se potessi sanguinare, o dormire! –
Potesse la mia bocca sposarsi a una ferità così!
O a me in questa capsula di vetro filtrasse il vostro liquore,
Stordente e riposante. Ma senza, senza colore.
Ariel
Stasi nel buio. Poi
l’insostanziale azzurro
versarsi di vette e distanze.
Leonessa di Dio,
come in una ci evolviamo,
perno di calcagni e ginocchi! –
La ruga
s’incide e si cancella, sorella
al bruno arco
del collo che non posso serrare,
bacche
occhiodimoro oscuri
lanciano ami –
Boccate di un nero dolce sangue,
ombre.
Qualcos’altro
mi tira su nell’aria –
cosce, capelli;
dai miei calcagni si squama.
Bianca
godiva, mi spoglio –
morte mani, morte stringenze.
E adesso io
spumeggio al grano, scintillio di mari.
Il pianto del bambino
nel muro si liquefà.
E io
sono la freccia,
la rugiada che vola
suicida, in una con la spinta
dentro il rosso
occhio cratere del mattino.
Lady Lazarus
L’ho rifatto.
Un anno ogni dieci
Ci riesco –Una specie di miracolo ambulante, la mia pelle
Splendente come un paralume nazi,
Un fermacarte il mioPiede destro,
La mia faccia un anonimo, perfetto
Lino ebraicoVia il drappo
O mio nemico!
Faccio forse paura?Il naso, le occhiaie, la chiostra dei denti?
Il fiato puzzolente
In un giorno svanirà.Presto, ben presto la carne
Che il sepolcro ha mangiato si sarà
Abituata a meE io sarò una donna che sorride.
Non ho che trent’anni.
E come il gatto ho nove vite da morire.Questa è la Numero Tre.
Quale ciarpame
Da far fuori a ogni decennio.Che miriade di filamenti.
La folla sgranocchiante noccioline
Si accalca per vedereChe mi sbendano mano e piede –
Il grande spogliarello.
Signori e Signore, ecco quiLe mie mani,
I miei ginocchi,
Sarò anche pelle e ossa.Ma pure sono la stessa, identica donna.
La prima volta successe che avevo dieci anni.
Fu un incidente.Ma la seconda volta ero decisa
A insistere, a non eccedere assolutamente.
Mi dondolavo chiusaCome conchiglia.
Dovettero chiamare e chiamare
E staccarmi via i vermi come perle appiccicose.Morire
È un’arte, come ogni altra cosa.
Io lo faccio in modo eccezionale.Io lo faccio che sembra come inferno.
Io lo faccio che sembra reale.
Ammetterete che ho la vocazione.È facile abbastanza da farlo in una cella.
È facile abbastanza da farlo e starsene lì.
È il teatraleRitorno in pieno giorno
A un posto uguale, uguale viso, uguale
Urlo divertito e animale:“Miracolo!”
È questo che mi ammazza,
C’è un prezzo da pagarePer spiare
Le mie cicatrici, per auscultare
Il mio cuore. Eh sì, batte.E c’è un prezzo, un prezzo molto caro,
Per una toccatina, una parola,
O un po’ del mio sangueO di capelli o un filo dei miei vestiti.
Eh sì, Herr Doktor
Eh sì, Herr Nemico.Sono il vostro opus magnum.
Sono il vostro gioiello,
Creatura d’oro puroChe a uno strillo si liquefà.
Io mi rigiro e brucio.
Non crediate che io sottovaluti le vostre ansietà.Cenere, cenere –
Voi attizzate e frugate.
Carne, ossa, non ne trovate –Un pezzo di sapone,
Una fede nuziale,
Una protesi dentale.Herr Dio, Herr Lucifero,
Attento,
Attento.Dalla cenere io rinvengo
Con le mie rosse chiome
E mangio uomini come aria di vento.
Donna sterile
Vuota, rimando l’eco di ogni minimo passo,
museo senza statue, grandioso di colonne, porticati,
rotonde.
Nel mio cortile una fontana balza e riaffonda dentro di sé,
un cuore monacale, cieca al mondo. Gigli di marmo
esalano il loro pallore come profumo.Mi immagino con un grande pubblico,
madre di una bianca Nike e di molti Apolli dagli occhi
vuoti.
Invece i morti feriscono con loro attenzioni, e non
Può accadere nulla.
La luna mi posa una mano sulla fronte,
senza espressione e muta come un’infermiera.
Papà
Non servi, non servi più,
O nera scarpa, tu
In cui trent’anni ho vissuto
Come un piede, grama e bianca,
Trattenendo fiato e starnuto.Papà, ammazzarti avrei dovuto.
Ma sei morto prima che io
Ci riuscissi, tu greve marmo, sacco pieno di Dio,
Statua orrenda dal grigio alluce
Grosso come una foca di FriscoE un capo nell’Atlantico estroso
Al largo di Nauset laggiù
Dove da verde diventa blu.
Un tempo io pregavo per riaverti.
Ach, du.In tedesco, in un paese
Di Polonia al suolo spianato
Da guerre, guerre, guerre.
Ma il paese ha un nome molto usato.
Un amico mio polaccoMi dice che ce n’è un sacco.
Così non ho mai saputo
Dov’eri passato o cresciuto.
Mai parlarti ho potuto.
Mi s’incollava la lingua al palato.Mi s’incollava a un filo spinato.
Ich, ich, ich, ich,
Non riuscivo a dir di più di così.
Per me ogni tedesco era te.
E quell’idioma oscenoEra un treno, un treno che
Ciuff-ciuff come un ebreo portava via me.
A Dachau, Auschwitz, Belsen.
Da ebrea mi mettevo a parlare,
E lo sono proprio, magari.Le nevi del Tirolo, la birra chiara di Vienna
Non son molto pure o sincere.
Per la mia ava zingara e fortunosi sbocchi
E il mio mazzo di tarocchi e il mio mazzo di tarocchi
Qualcosa di ebreo potrei avere.Ho avuto sempre terrore di te,
Con la tua Luftwaffe, il tuo gregregrè.
E il tuo baffo ben curato
E l’occhio ariano d’un bel blu.
Uomo-panzer, panzer, O tu –Non un Dio ma svastica nera
Che nessun cielo ci trapela.
Ogni donna adora un fascista,
La scarpa in faccia, il brutale
Cuore di un bruto a te ugualeTu stai alla lavagna, papà,
Nella foto che ho di te,
Biforcuto nel mento anziché
Nel piede, ma diavolo sempre,
Sempre uomo nero cheCon un morso il cuore mi fende.
Avevo dieci anni che seppellirono te.
A venti cercai di morire
E tornare, tornare a te.
Anche le ossa mi potevano servire.Ma mi tirarono via dal sacco,
Mi rincollarono i pezzetti.
E il da farsi così io seppi.
Fabbricai un modello di te,
Uomo in nero dall’aria Meinkampf,E con il gusto di torchiare.
E io che dicevo sì, sì.
Papà, eccomi al finale.
Tagliati i fili del nero telefono
Le voci più non ci possono miagolare.Se ho ucciso un uomo, due ne ho uccisi –
Il vampiro che diceva essere te
E un anno il mio sangue bevé,
Anzi sette, se tu
Vuoi saperlo. Papà, puoi star giù.Nel tuo cuore c’è un palo conficcato.
Mai i paesani ti hanno amato.
Ballano e pestano su di te.
Che eri tu l’hanno sempre capito.
Papà, carogna, ho finito.
Chi è Silvia Plath
La sua vita è durata solo 30 anni. Anche se Sylvia Plath grazie alle sue stupende poesie vivrà per sempre. Sylvia Plath ha avuto una vita tormentata, che come abbiamo potute leggere prima, ha sempre manifestato nelle sue opere.
Sylvia Plath, chiamata familiarmente Sivvy nacque il il 27 ottobre 1932 a Boston, nel Massachusetts.
Era figlia di due insegnanti: Otto Emil Plath, professore universitario di tedesco e biologia all’Università di Boston (specialista delle api), e Aurelia Schober, insegnante di inglese e tedesco. Entrambi erano di origine tedesca.
Sylvia Plath ha iniziato a scrivere poesie da bambina all’età di 8 anni.
Da subito emerge tutta la sua insicurezza. Era fragile e molto sensibile. Tutto si amplifica con la morte del padre a causa del diabete. La poesia Dad (Papà) è il manifesto del suo dolore.
Scatta la depressione e tenta il suicidio durante il periodo in cui frequentava lo Smith College di Northhampton (1950-55).
Grazie ad una borsa di studio, si trasferì in Inghilterra per frequentare l’Università di Cambridge, una delle più prestigiose al mondo.
Nel 1956 incontra Ted Hughes. Lui è un poeta già conosciuto, lei si reca appositamente a una festa per conoscerlo e complimentarsi con lui.
Nasce l’amore tra i due e dopo appena quattro mesi si sposarono.
Se la relazione non sarà delle più felici, servirà però a innescare l’alchimia con cui danno vita entrambi alla loro produzione migliore.
Ted Hughes e Sylvia Plath ebbero 2 figli: Frieda, nata nel 1960, e Nicholas, nato nel 1962.
L’11 febbraio del 1963 Sylvia Plath decise di togliersi la vita a Londra.