“Solitudini” (1930), la poesia di Salvatore Quasimodo sulla condizione umana
Da “Solitudini”, Salvatore Quasimodo estrapola i versi finali divenuti poi celebri con il titolo “Ed è subito sera”.
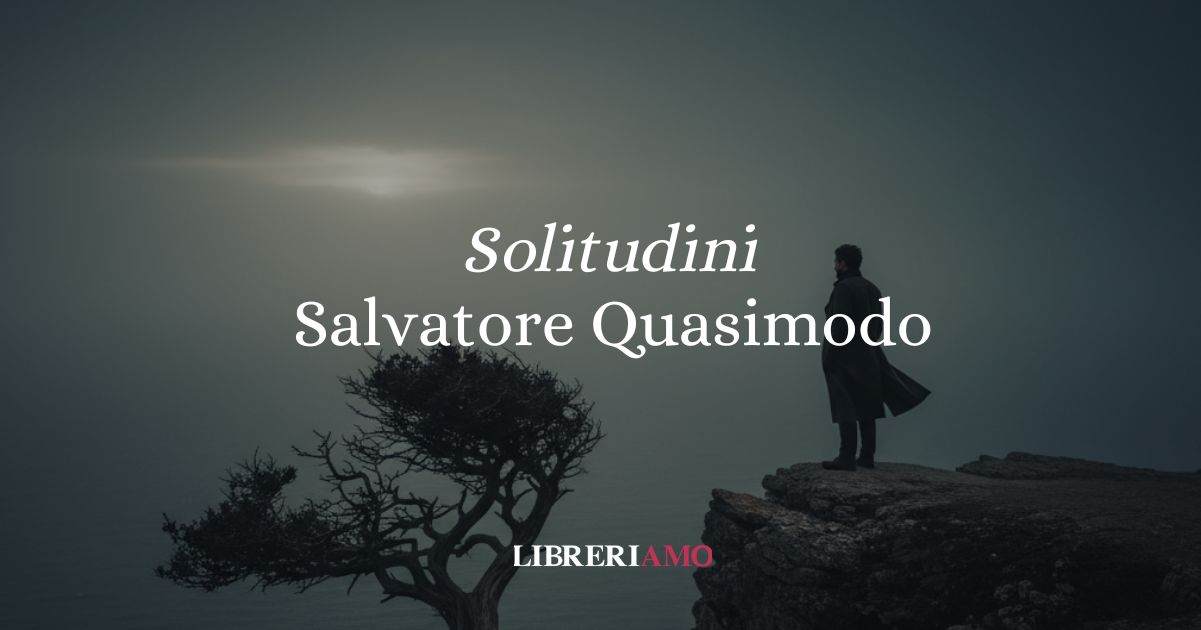
Solitudini di Salvatore Quasimodo è una poesia sul distacco da ciò che sia ama, da ciò che si desidera, da ciò che dona il senso di casa.
Il distacco lascia sempre un tocco di malinconia, un briciolo di amarezza dentro il cuore, un pungiglione che si insinua dentro l’anima segnando una ferita insanabile.
Solitudini fa parte della raccolta Acque e terre di Salvatore Quasimodo e la poesia nasconde un piccolo segreto: contiene il testo di un’altra poesia, fra le più celebri dell’autore esponente dell’Ermetismo, che si può facilmente scoprire leggendola.
Solitudini di Salvatore Quasimodo
Una sera: nebbia, vento,
mi pensai solo: io e il buio.Né donne; e quella
che sola poteva donarmi
senza prendere che altro silenzio,
era già senza viso
come ogni cosa ch’è morta
e non si può ricomporre.Lontana la casa,
ogni casa che ha lumi di veglia
e spole che picchiano all’alba
quadrelli di rozzi tinelli.Da allora
ascolto canzoni di ultima volta.
Qualcuno è tornato, è partito distratto
lasciandomi occhi di bimbi stranieri,
alberi morti su prode di strade
che non m’è dato d’amare.Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
La solitudine da personale a universale
Leggendo le prime quattro strofe della poesia ci immergiamo nell’universo narrativo di Salvatore Quasimodo che, con i suoi versi, esprime e racconta se stesso.
La poesia si apre con un’atmosfera notturna e cupa:
Una sera: nebbia, vento, mi pensai solo: io e il buio.
Questa cornice di nebbia e vento riflette lo stato d’animo del poeta, che si ritrova in una condizione di assoluta solitudine.
Il poeta avverte l’assenza di un affetto vitale, simboleggiato da una donna amata che
era già senza viso, / come ogni cosa ch’è morta / e non si può ricomporre.
Questa figura femminile è la sola che avrebbe potuto offrire conforto (“donarmi / senza prendere che altro silenzio”), ma la sua perdita o distanza risulta irreversibile, portando a un senso di vuoto difficile da colmare.
L’autore concepisce come irraggiungibile anche la dimensione domestica e rassicurante della casa, con i suoi “lumi di veglia” e i rumori del mattino (“spole che picchiano all’alba”). Questa lontananza dalla vita semplice e operosa accentua il suo esilio interiore.
Nella proseguo della poesia, Quasimodo esprime una rassegnazione dolorosa. L’ascolto di “canzoni di ultima volta” e l’immagine di qualcuno che “è tornato, è partito distratto” suggeriscono una serie di esperienze che si sono chiuse senza lasciare tracce positive. L’immagine degli “alberi morti su prode di strade” simboleggia infine la presenza di una natura inospitale e arida.
Ed è subito sera
Con l’ultima strofa, Solitudini cambia: l’esperienza del dolore, della nostalgia, dell’irreversibile incomunicabilità che prima era stata del poeta, diventa universale. È avvenuta la magia, proprio alla fine del componimento: ciascuno di noi riesce a sentirsi partecipe di quei tre brevissimi versi.
Come se il poeta li avesse scritti per noi. Come se avesse cavato fuori dalle nostre viscere qualcosa che non saremmo mai riusciti a spiegare, e che tuttavia riesce misteriosamente a prendere forma grazie a questi tre semplici ma intesi versi:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera.
Col primo verso, Quasimodo afferma che la solitudine rappresenta la condizione ontologica di ogni essere umano. Ognuno si trova al “cuor della terra”, ovvero al centro dell’esistenza, ma in un isolamento irrimediabile.
Il secondo verso è una potente analogia tipica dell’Ermetismo; il raggio di sole, simbolo della vita, della luce, o di un fugace momento di felicità, non illumina né scalda, ma trafigge, causando dolore. La vita stessa, nella sua bellezza, è intrinsecamente sofferenza. È una ferita luminosa.
L’iconico terzo verso, “ed è subito sera,” è una metafora della morte che arriva veloce e irreversibile. La vita umana, come un giorno che volge velocemente al tramonto, è breve e si conclude in un attimo, annullando ogni illusione o dolore. L’uso dell’avverbio “subito” rende il senso di rapidità e inaspettato della fine.
Proprio questi finali sono stati scorporati da “Solitudini” e resi dall’autore un testo poetico a se stante: da “Ed è subito sera” Salvatore Quasimodo ha tratto nucleo dell’omonima celebre poesia e i temi per la raccolta pubblicata nel 1942.
L’isolamento dell’uomo
Dopo aver letto Solitudini ci immaginiamo il paesaggio che ha prodotto questo componimento: è un paesaggio personale, impastato di dolore e nostalgia.
C’è il senso del distacco della sua terra, di quel mondo che ha donato tutte le cose più belle della giovinezza. C’è tutto là, il primo amore, i luoghi delle trasgressioni e dei giochi. C’è la vita immaginata, la vita che si può sognare.
E il distacco rende manifesta la sera che cala grave sul mondo, la morte della madre, assenza irreversibile, la perdita di contatto con i luoghi familiari, che si appannano sempre di più, come inghiottiti da una coltre di nebbia.
Cominciata come un lamento personale e amaro per l’assenza e l’isolamento, la poesia “Solitudini” si trasforma negli ultimi versi e diventa così una sentenza universale sulla condizione umana: la vita non è altro che una breve, dolorosa e solitaria esperienza.