L’”uomo di poche parole” per Emily Dickinson è quello che merita rispetto
L’uomo da temere non è quello che parla troppo: nei versi di Emily Dickinson il vero rispetto va a chi sa misurare le parole e ha la forza del silenzio.
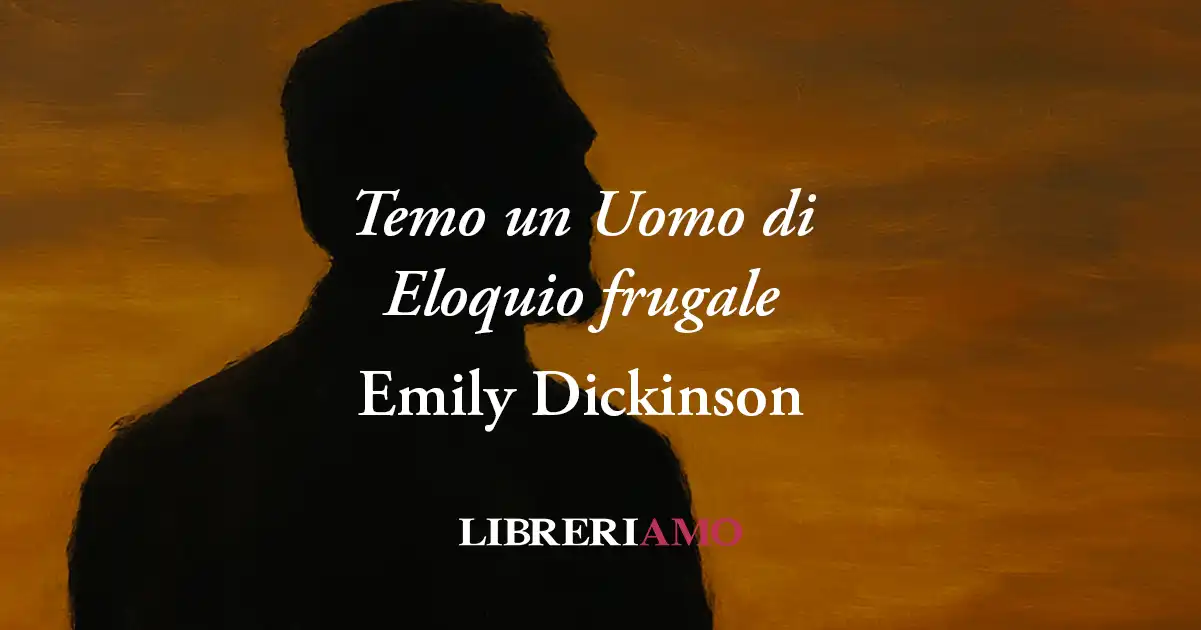
C’è una saggezza antica nel silenzio, una forma di autorità che non ha bisogno di alzare la voce. Emily Dickinson lo sapeva bene. In una breve poesia, quasi un lampo, la poetessa americana ribalta un luogo comune che attraversa i secoli: non è l’uomo eloquente a imporsi, né il chiacchierone a dominare la scena. È l’uomo che parla poco, quello che osserva, che pesa ogni parola mentre gli altri si affannano a spenderle tutte.
Dickinson lo confessa con una franchezza disarmante: è questo uomo il più temibile, il più grande, forse il più vero. Un elogio del silenzio che diventa anche un monito: chi non si rivela completamente custodisce un potere che può sorprendere, affascinare, spaventare.
Temo un Uomo di Eloquio frugale questo il titolo della poesia di Emily Dickinson contenuta nella raccolta di poesie Poems of Emily Dickinson, Second Series, il secondo volume della storica trilogia che portò per la prima volta l’opera della poetessa al pubblico. Curato da Mabel Loomis Todd e Thomas Wentworth Higginson, fu pubblicato nel 1891, cinque anni dopo la morte della poetessa.
Poiché Emily Dickinson non pubblicò quasi nulla durante la sua vita, furono proprio questi tre volumi postumi, usciti tra il 1890 e il 1896, a rivelare al mondo la sua voce, organizzando e dando forma a centinaia di componimenti rimasti fino ad allora nascosti nei suoi fascicoli privati. La raccolta contribuì in modo decisivo a consolidare la fama di Dickinson come una delle voci più originali e rivoluzionarie della poesia americana.
Leggiamo qiesta breve poesia di Emily Dickinson per condividere il profondo significato dei suoi versi.
Temo un Uomo di Eloquio frugale di Emily Dickinson
Temo un Uomo Eloquio frugale –
Temo un Uomo Silenzioso –
Un Oratore – posso sovrastarlo –
O un Chiacchierone – intrattenerlo –Ma Colui che pondera – Mentre gli Altri –
Spendono fino all’ultimo centesimo –
Di quest’Uomo – sono diffidente –
Temo che Egli sia Grande.
I fear a Man of frugal Speech, Emily Dickinson
I fear a Man of frugal Speech –
I fear a Silent Man –
Haranguer – I can overtake –
Or Babbler – entertain –But He who weigheth – While the Rest –
Expend their furthest pound –
Of this Man – I am wary –
I fear that He is Grand –
L’uomo vero e quello di poche parole
Temo un Uomo di Eloquio frugale è la poesia di Emily Dickinson che rovescia un’idea comune. Non è chi parla a lungo o con sicurezza a possedere la vera autorevolezza, ma chi sa trattenere le parole, pesarle, custodirle.
In un mondo in cui l’esibizione verbale è spesso scambiata per intelligenza, la poetessa celebra l’uomo che tace, che osserva, che non spreca energie in chiacchiere. Un uomo così non appare debole, ma si presenta grande. La sua forza sta nella misura, nella ponderazione, nella profondità che il silenzio porta con sé.
L’uomo che tace mentre gli altri parlano
Nel primo verso Emily Dickinson mette subito al centro la figura che la inquieta: l’uomo che parla poco. Non è una semplice nota di carattere, ma un dettaglio psicologico che la poetessa legge come segno di profondità. L’uomo silenzioso non riempie il vuoto, non teme lo spazio tra le parole. Sta in ascolto, valuta, misura. È una presenza che non ha bisogno di esporsi per affermarsi.
Il confronto con gli altri uomini è evidente: l’oratore è prevedibile, il chiacchierone è innocuo. Chi parla molto si lascia decifrare. È nel flusso delle parole che emergono limiti, opinioni, fragilità. L’uomo silenzioso invece sfugge. Non concede abbastanza per essere compreso, e proprio per questo appare più forte, più saldo, più capace di custodire qualcosa che agli altri sfugge.
Dickinson osserva come, mentre “gli altri spendono fino all’ultimo centesimo”, questo uomo trattenga tutto ciò che gli altri disperdono. È un’immagine economica che diventa metafora esistenziale: chi parla troppo investe male, chi parla poco protegge il proprio capitale interiore.
Per la poetessa questo gesto di ponderazione diventa segno di grandezza. L’uomo silenzioso non è timido né remissivo: è sovrano di sé stesso. Ha una forma di potere che nasce dalla capacità di non consumarsi, di non sciogliersi nel chiacchiericcio del mondo. È per questo che Dickinson dice di temerlo. Perché riconosce in lui una superiorità che non ha bisogno di essere dichiarata.
Il silenzio, nella sua lettura, è una forza che non si vede ma si sente. Una grandezza che non reclama attenzione ma la ottiene. Un mistero che non si risolve con le parole, ma che alle parole sopravvive.
La vera grandezza è misurare le parole e gustare il silenzio
Nel cuore della poesia, Dickinson non mette solo un carattere umano, ma un modo di stare nel mondo. L’uomo silenzioso non è semplicemente uno che parla poco: è qualcuno che si sottrae al rumore, che trattiene ciò che gli altri disperdono, che considera il linguaggio una responsabilità e non un espediente per riempire il tempo.
Per la poetessa, il silenzio di quest’uomo non è vuoto ma densità. È uno spazio interiore che non si lascia violare, un territorio protetto in cui le parole entrano solo quando hanno un peso reale. Mentre gli altri si affrettano a dire, a spiegare, a convincere, lui osserva. E in quell’osservazione c’è già una forma di potere: la capacità di leggere il mondo senza lasciarsi trascinare dal suo ritmo convulso.
Dickinson contrappone questo atteggiamento alla dissipazione verbale degli altri uomini. «Spendono fino all’ultimo centesimo», scrive, suggerendo che ogni parola è un investimento. Chi parla troppo impoverisce la propria autorità; chi parla poco la rafforza. Non perché il silenzio sia una posa, ma perché custodisce un’energia che gli altri consumano nel tentativo di definirsi continuamente.
L’uomo ponderato, invece, si definisce proprio attraverso ciò che trattiene. La sua grandezza sta nel non lasciarsi catturare dalle urgenze altrui, nell’agire solo quando la parola è necessaria, nella consapevolezza che ciò che non si dice spesso vale più di ciò che si proclama. Per questo Dickinson lo teme: perché intuisce che una persona così non è manipolabile, non è prevedibile, non è leggibile. È un individuo che non si consegna al giudizio immediato, e la sua opacità diventa una forma di splendore.
Nel mondo di Emily Dickinson, come come anche in quello attuale, chi parla troppo rischia di perdersi; chi tace nel momento giusto resta integro. La poetessa riconosce in questo silenzio scelto non un difetto, ma una forza morale. Una grandezza che non si esibisce, ma si impone.