E quando nacque la mia gioia (1918) di Khalil Gibran, poesia che svela il segreto della felicità
Scopri tutta la magia dei versi di “E quando nacque la mia gioia”, parabola-poesia sull’indifferenza, l’egoismo e la fragilità umana.
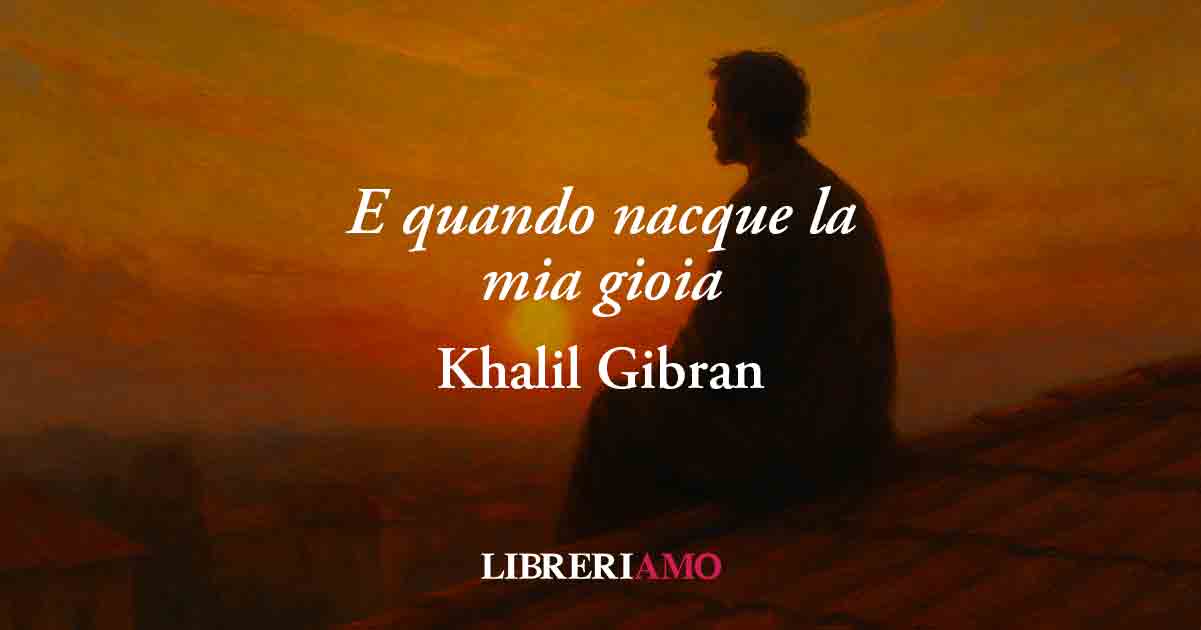
E quando nacque la mia gioia di Khalil Gibran è una delle poesie più belle della letteratura mondiale, capace di raccontare in pochi versi la solitudine dell’individuo di fronte all’indifferenza della società e la dolorosa consapevolezza che le esperienze più profonde, se non condivise, sono destinate a svanire.
La parabola di Gibran offre una profonda riflessione sulla felicità, mostrandola come una creatura fragile, che, quando arriva, se ignorata da chi sta accanto, finisce inevitabilmente per dissipare i suoi effetti e fuggire via. Ma, tutto ciò è inevitabile, perché l’indifferenza e l’invidia umana fanno parte del vivere.
E quando nacque la mia gioia fa parte della raccolta di poesie The Madman (Il folle) di Khalil Gibran, pubblicata per la prima volta a New York (Stati Uniti) da Alfred A. Knopf nel 1918, con illustrazioni riprodotte dai disegni originali dell’autore. Fu il primo libro di Gibran in inglese ad essere pubblicato, segnando anche l’inizio della seconda fase della carriera di Gibran.
Leggiamo questa meravigliosa poesia di Khalil Gibran per vivere la bellezza dei versi e scoprire il profondo significato.
E quando nacque la mia gioia di Khalil Gibran
E quando nacque la mia gioia E quando nacque la mia gioia, la strinsi tra le braccia e salii sul tetto di casa a gridare, «Venite, miei vicini, venite a vedete, poiché in questo giorno per me è nata la gioia. Venite a vedere questa creatura felice, che ride nel sole».
Ma nessuno dei miei vicini venne a vedere la mia gioia, e fu grande il mio stupore.
E ogni giorno per sette lune stetti a proclamare la mia gioia dal tetto di casa – e tuttavia nessuno mi badava. E la mia gioia ed io eravamo soli, senza che nessuno venisse mai a cercarci o a farci visita.
Allora la mia gioia diventò pallida e fragile, perché nessun altro cuore, tranne il mio, era investito della sua amabile grazia e nessun’altra bocca baciava la sua bocca.
E la mia gioia morì di solitudine.
E ora sto a ricordare la mia morta gioia solo ricordando il mio morto dolore. Ma il ricordo è una foglia d’autunno che mormora per qualche istante nel vento e poi non si ode più.
And when my Joy was born, Khalil Gibran
And when my Joy was born, I held it in my arms and stood on the house-top shouting, “Come ye, my neighbours, come and see, for Joy this day is born unto me. Come and behold this gladsome thing that laugheth in the sun.”
But none of my neighbours came to look upon my Joy, and great was my astonishment.
And every day for seven moons I proclaimed my Joy from the house-top—and yet no one heeded me. And my Joy and I were alone, unsought and unvisited.
Then my Joy grew pale and weary because no other heart but mine held its loveliness and no other lips kissed its lips.
Then my Joy died of isolation.
And now I only remember my dead Joy in remembering my dead Sorrow. But memory is an autumn leaf that murmurs a while in the wind and then is heard no more.
La felicità ha bisogno di vera e sana condivisione
E quando nacque la mia gioia è una poesia di Khalil Gibran che riesce a tracciare con un pizzico di malinconia la sensazione di abbandono che si vive quando l’indifferenza imperversa nei rapporti umani. “Il folle” riesce a trasferire anche qualcosa di molto più profondo, ovvero l’incapacità dell’umanità di saper vivere insieme in modo gioioso e felice.
La poesia rappresenta una delle parabole più delicate e universali di Khalil Gibran. Dietro l’apparente semplicità del racconto si nasconde una riflessione sulla natura della felicità, sul bisogno umano di condivisione e sul destino fragile di ogni emozione che non trova ascolto.
È un testo che unisce simbolismo e verità psicologica, parlando di ciò che accade dentro l’animo umano quando la gioia non riesce a uscire dal cuore per incontrarne un altro.
Scoprire e vivere la gioia è il desiderio più grande degli umani, una ricerca spesse volte che dura un’intera vita. E quando finalmente s’incontra la felicità, e si è da soli, si scopre che non esercita i suoi effetti.
La vera gioia è quella che si vive con gli altri, con il massimo numero di persone possibili, altrimenti perde velocemente la sua energia e finisce per migrare verso territori più vivi.
Rimane il fatto che molte volte il perverso prende il sopravvento. Quando gli altri percepiscono la tua gioia, la tua felicità, inevitabilmente si allontanano, scappano, fuggono per non vivere il disagio di non poter provare la medesima sensazione, 0 peggio perché la fortuna ha preferito premiare te e non loro.
“Il folle” e le sue parabole
Per comprendere appieno e interpretare i messaggi della poesia di Khalil Gibran, bisogna inquadrare questa parabola all’interno della raccolta The Madman, pubblicata nel 1918, che segna una svolta decisiva nella vita e nella poetica di Khalil Gibran. È la sua prima opera scritta in inglese, nata in un momento di grande trasformazione personale e mondiale.
L’autore viveva a New York, nel fermento del Greenwich Village, immerso in un ambiente di artisti, poeti e pensatori che cercavano un linguaggio nuovo per raccontare la condizione umana dopo la tragedia della guerra. Il Folle nasce da questa tensione tra Oriente e Occidente, tra spiritualità e modernità.
Il “folle” di Gibran non è un pazzo, ma un uomo che ha avuto il coraggio di togliersi le maschere che il mondo impone. È colui che vede la verità e la libertà, ma proprio per questo viene giudicato estraneo, distante, incompreso.
Nelle parabole che compongono la raccolta, Gibran esplora il rapporto tra l’anima e la società, tra il desiderio di autenticità e il peso delle convenzioni. E quando nacque la mia gioia si inserisce perfettamente in questo quadro, come un piccolo capolavoro simbolico che mostra la fragilità dei sentimenti quando restano isolati e la necessità di una comunione profonda tra le persone.
Il Folle è, in fondo, il manifesto di un’anima che cerca verità in un mondo confuso, una voce che ancora oggi ci invita a ritrovare la nostra umanità nel dialogo, nella condivisione e nella capacità di sentire insieme.
The Madman non nasce dal nulla, ma si inserisce in un filone di pensiero che esalta l’individuo contro gli effetti devastanti della massa. L’influenza di Nietzsche è palese. Il “Folle” di Gibran è molto simile allo Zarathustra di Nietzsche, un individuo solitario che scende tra gli uomini per annunciare una nuova saggezza, venendo però deriso e incompreso. L’idea che la “follia” sia una forma superiore di sanità, libera dalle maschere sociali, è un tema profondamente nietzschiano.
L’opera è intrisa di romanticismo e trascendentalismo. Khalil Gibran era un grande ammiratore di poeti come William Blake e di pensatori come Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Da loro riprende l’enfasi sull’intuizione, sull’individualismo e sulla ricerca di una verità spirituale al di là delle religioni organizzate e delle norme sociali.
Una parabola senza tempo sulla vera essenza della gioia
E quando nacque la mia gioia riesce a donare, nello stile della poesia in prosa di Khalil Gibran, una grande lezione sulla vita e una riflessione profonda sull’egoismo umano.
Leggendo la parabola, il primo gesto del protagonista è quello di stringere la sua gioia tra le braccia, come si farebbe con un bambino appena nato. Gibran sceglie di dare vita alla gioia, di trasformarla in un essere concreto e pulsante, offre la personificazione di questa creatura fragile e molto attenta alla compagnia.
Non è un’emozione astratta, ma una presenza reale che ride nel sole e chiede di essere vista.
In questo modo, Gibran suggerisce che la gioia, per quanto personale, non può esistere da sola. Come ogni essere vivente, ha bisogno di essere nutrita. E il suo nutrimento è la condivisione.
Quando “Il folle” sale sul tetto e invita i vicini a partecipare alla sua felicità, non lo fa per vanità, ma per un bisogno vitale. La sua gioia, come una fiamma, deve essere alimentata dallo sguardo e dal calore degli altri per non spegnersi.
La gioia vive solo se riflessa in un altro cuore. Senza questo specchio, resta prigioniera di chi la prova e comincia lentamente a morire.
Il silenzio dei vicini è il punto di svolta della parabola. Nessuno risponde all’invito, nessuno si avvicina, nessuno partecipa. Non c’è ostilità, non c’è rifiuto esplicito, ma una assenza assoluta di attenzione. È questa l’indifferenza che uccide.
Gibran mostra come la mancanza di risposta dell’altro possa trasformarsi nella più profonda forma di solitudine. L’uomo che gridava la sua gioia dal tetto non viene ascoltato, e quel silenzio diventa una ferita. La felicità, che all’inizio sembrava infinita, si spegne poco a poco, perché non trova un luogo dove posarsi.
Il tetto diventa allora il simbolo della condizione umana. È lo spazio in cui l’individuo si espone completamente, mostrando la propria luce al mondo. Ma più si mostra, più rischia di restare solo.
La gioia non muore perché viene negata, ma perché non viene accolta.
Man mano che il tempo passa, la gioia del protagonista diventa pallida e fragile. È un processo naturale e inevitabile, perché ogni emozione, se isolata, tende a consumarsi. L’assenza di legami la prosciuga, e la vitalità si trasforma in stanchezza.
Gibran ci ricorda che la felicità non è un possesso ma un flusso, un movimento che ha bisogno di attraversare più persone per continuare a vivere. Se la teniamo per noi, la chiudiamo in una stanza senza aria, e lentamente muore di asfissia.
In questa immagine struggente, la gioia che perde colore diventa metafora della fragilità del tempo, che tutto trasforma e che tutto, alla fine, dissolve.
Quando Gibran scrive “E ora sto a ricordare la mia morta gioia solo ricordando il mio morto dolore”, offre una verità tanto semplice quanto sconvolgente.
La gioia e il dolore non sono opposti, ma parte della stessa esperienza. Non si può ricordare l’una senza evocare l’altro, perché ogni felicità perduta lascia dietro di sé una scia di dolore, e ogni dolore porta con sé la memoria di ciò che un tempo ci faceva felici.
Khalil Gibran mostra come l’animo umano sia attraversato da continui cicli di luce e ombra, e come la memoria non possa distinguere davvero tra ciò che ha fatto bene e ciò che ha ferito.
Chi ama profondamente, soffre con la stessa profondità. Eppure, proprio in questo intreccio di gioia e dolore, la vita trova il suo significato più autentico.
L’immagine finale è una delle più poetiche e potenti di tutta la produzione di Gibran. Il ricordo viene paragonato a una foglia d’autunno che sussurra per un momento nel vento e poi tace per sempre.
È una visione dolce e malinconica del tempo che tutto dissolve, anche ciò che credevamo eterno.
Il poeta insegna che nulla dura per sempre, nemmeno la memoria delle emozioni più intense. Ma in quel breve sussurro, in quel mormorio del vento, c’è ancora vita. La gioia, anche se svanita, continua a esistere per un attimo nell’anima, come una luce che non vuole spegnersi del tutto.
Una parabola di Khalil Gibran sulla felicità universale e senza tempo
E quando nacque la mia gioia di Khalil Gibran attraversa il tempo come un messaggio destinato a ogni epoca.
Oggi più che mai, la parabola del poeta libanese parla con voce limpida, ricordandoci che la felicità non è un traguardo individuale ma un’esperienza condivisa.
Viviamo in un mondo che esibisce la gioia ma raramente la vive davvero. Mostriamo sorrisi, successi, immagini di felicità perfetta, ma dietro quella superficie si nasconde spesso un profondo senso di solitudine.
Proprio come il protagonista di Gibran, anche adesso si grida la gioia dai tetti dei social, nella speranza che qualcuno la ascolti, che qualcuno la riconosca, che qualcuno risponda.
Eppure, spesso, non arriva alcuna risposta.
L’indifferenza dell’umanità è inversamente proporzionale all’evoluzione della tecnologia. Più questa riesce a creare relazioni mediate, artificiali, distanti, più la condivisione delle emozioni diventa apparente, distratta, svogliata. La nostra epoca conosce tutto della comunicazione, ma ha smarrito la capacità dell’ascolto. Così la gioia, invece di unire, diventa un segnale che si perde nel rumore collettivo.
Gibran insegna che la felicità ha bisogno di autenticità, di presenza, di sguardi veri. Essere felici non significa gridarlo al mondo, ma permettere agli altri di partecipare a quella luce.
Condividere la gioia non è un atto di esibizione, ma di umanità profonda.
In questa poesia c’è un invito gentile e necessario per tutte le generazioni, quelle del passato, del presente e del futuro.
Non bisogna in nessun modo lasciare che la gioia muoia di solitudine. Ascoltare la gioia degli altri, partecipare, riconoscere, celebrare la felicità di chi sta vicino e di tutta l’umanità, offre un dono inestimabile: essere felice. Più si condivide gioia e più le batterie dell’anima si ricaricano di energia positiva per il nostro essere.
Solo così la felicità potrà continuare a vivere, trasformandosi in una forza che unisce invece di dividere.
E forse è proprio questo che Khalil Gibran voleva dirci più di un secolo fa, che la felicità, come la vita, esiste solo quando si condivide.