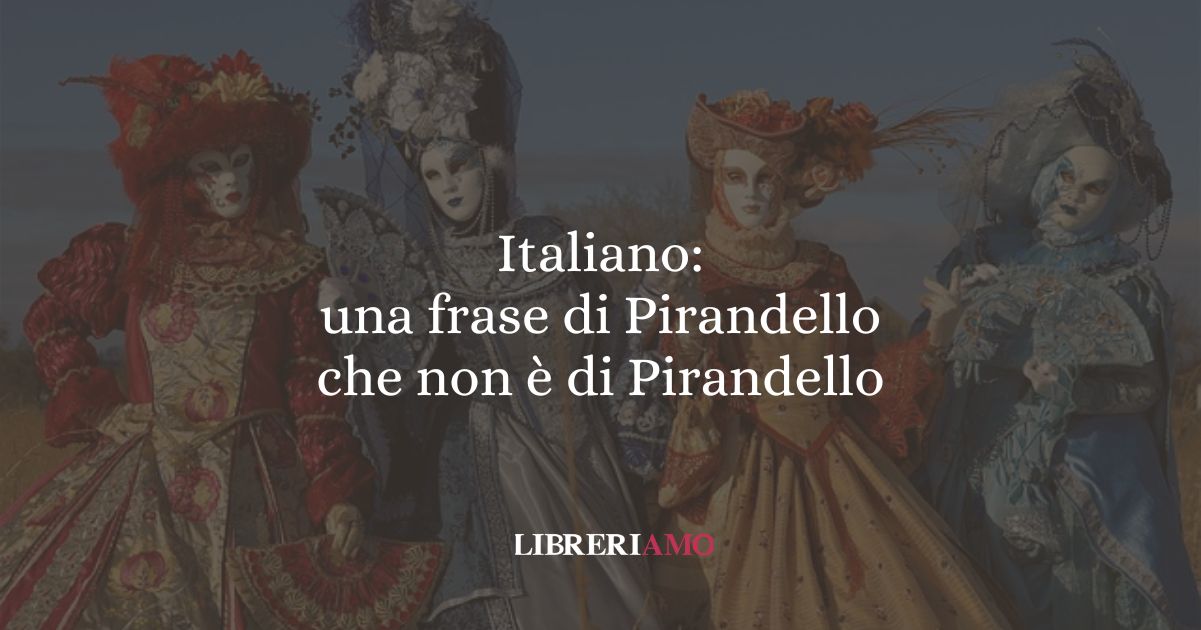Italiano e citazioni false: «Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti». Questa frase, spesso attribuita a Luigi Pirandello ma in realtà non rintracciabile nelle sue opere, esprime un concetto che, tuttavia, dialoga in maniera sorprendente con l’universo tematico dello scrittore siciliano. Pirandello è stato, infatti, il grande narratore e drammaturgo delle identità spezzate, dei ruoli sociali che diventano gabbie, delle maschere che ciascun individuo indossa per adattarsi agli sguardi altrui.
Italiano, citazioni false e maschere
Il tema della maschera, però, è infinitamente più ampio: accompagna la storia delle civiltà, le pratiche religiose, le rappresentazioni teatrali, i riti sociali e persino le riflessioni psicoanalitiche. La maschera è uno dei simboli più antichi e potenti dell’esperienza umana, e non smette di interrogarci.
Le prime tracce di maschere risalgono a circa novemila anni fa. In epoche arcaiche, probabilmente esse avevano una funzione magico-rituale: servivano a spaventare i nemici, a impersonare divinità o spiriti, a stabilire un contatto tra l’umano e il soprannaturale. La maschera era un medium, un tramite.
L’etimologia della parola stessa rivela la sua origine misteriosa. Secondo la Treccani, deriva dall’occitano masca, che a sua volta rimanderebbe a una radice preromana, forse addirittura preindoeuropea, collegata a immagini di buio, fuliggine, temporale, spettri, streghe. È affascinante pensare che, fin dalla nascita, la maschera si porti dietro un’aura di oscurità e di ambiguità, legata tanto al sacro quanto alla paura.
Con il tempo, le maschere entrarono nel teatro: dalla tragedia greca, che ne faceva strumento essenziale per amplificare la voce e rendere riconoscibili i personaggi, fino alla commedia dell’arte italiana, dove Arlecchino, Pantalone e Pulcinella hanno dato vita a figure universali. In questi casi la maschera aveva una funzione chiara: cancellare temporaneamente l’individualità del singolo attore per sostituirla con un personaggio. Finita la rappresentazione, la maschera si levava, e l’attore tornava se stesso.
Maschere sociali e psicologiche
Le cose si complicano quando si passa dal teatro alla vita. Esistono, infatti, “maschere” meno visibili ma altrettanto presenti: quelle che ciascuno di noi indossa nella quotidianità. Sono i ruoli sociali, le convenzioni, le aspettative che ci spingono a mostrarci in un modo piuttosto che in un altro.
Qui la citazione attribuita a Pirandello torna a colpire: «tante maschere e pochi volti». Perché se sul palcoscenico la maschera è un artificio temporaneo, nella società rischia di diventare permanente. Non recitiamo solo per un’ora, ma spesso per intere fasi della vita, dimenticando a volte cosa ci sia sotto la maschera.
Pirandello stesso, nelle sue opere, ci ha mostrato la labilità del confine tra volto e maschera. In Uno, nessuno e centomila, il protagonista scopre che gli altri lo vedono diversamente da come egli vede se stesso: ciascuno lo riduce a un ruolo, a una maschera. Di fronte a questa moltiplicazione di identità, il personaggio precipita in una crisi radicale.
Maschera e identità nell’epoca contemporanea
Oggi il discorso si amplia ulteriormente. Viviamo in una società che non solo ammette, ma quasi impone la maschera: nei social network, nei rapporti professionali, persino nella cura estetica del corpo. La maschera non è più eccezione: diventa regola.
Basta osservare il fenomeno crescente delle trasformazioni estetiche, dei ritocchi, degli interventi chirurgici volti a modificare i tratti naturali. È come se molte persone non si piacessero così come sono, e cercassero di reinventarsi un volto nuovo, definitivo, una maschera permanente.
Qui si apre un interrogativo inquietante. Si era detto che il nostro è il tempo di Narciso, ma il Narciso mitologico si amava fino a morirne. Noi, al contrario, sembriamo incapaci di amarci: milioni di giovani vivono il proprio corpo come inadeguato, da mascherare costantemente, anche a costo di negarne l’autenticità. Non siamo Narcisi, ma il loro contrario.
L’enigma del volto
Eppure, il volto resta il centro della nostra identità. È ciò che ci distingue, che ci rende unici, che ci consente di comunicare emozioni e verità. Il volto è difficile da leggere, come osserva Tullio Pericoli, ma proprio per questo resta la chiave per accedere alla profondità di una persona.
Il rischio, allora, è che l’incontro con un volto autentico diventi sempre più raro. Ci abituiamo a maschere lucide e levigate, prive di imperfezioni ma anche di verità. Così, quando ci imbattiamo in un volto nudo, sincero, potremmo persino trovarlo disarmante, tanto siamo avvezzi al filtro della maschera.
La maschera, in fondo, non è un male in sé. Ha avuto e continua ad avere funzioni vitali: permette di proteggersi, di recitare un ruolo, di sperimentare identità diverse. Ma se diventa definitiva, se soffoca il volto anziché preservarlo, si trasforma in una gabbia.
La citazione, pur non appartenendo a Pirandello, ci invita a vigilare su questo equilibrio fragile: riconoscere quando una maschera è utile e quando, invece, rischia di cancellare ciò che siamo davvero. Forse il compito più difficile e più prezioso, oggi, è proprio questo: reimparare a distinguere i volti dalle maschere, e avere il coraggio di mostrarci autentici almeno a chi davvero conta.