Italiano: conosci la differenza d’uso tra passato remoto e passato prossimo?
Nell’idioma italiano pochi argomenti grammaticali rivelano la profondità del nostro rapporto con il tempo quanto la distinzione tra passato remoto e passato prossimo. A prima vista, la differenza sembra puramente cronologica: il passato remoto per eventi lontani, il passato prossimo per eventi vicini. Ma questa spiegazione è solo superficiale. Come ricorda Bice Mortara Garavelli in…
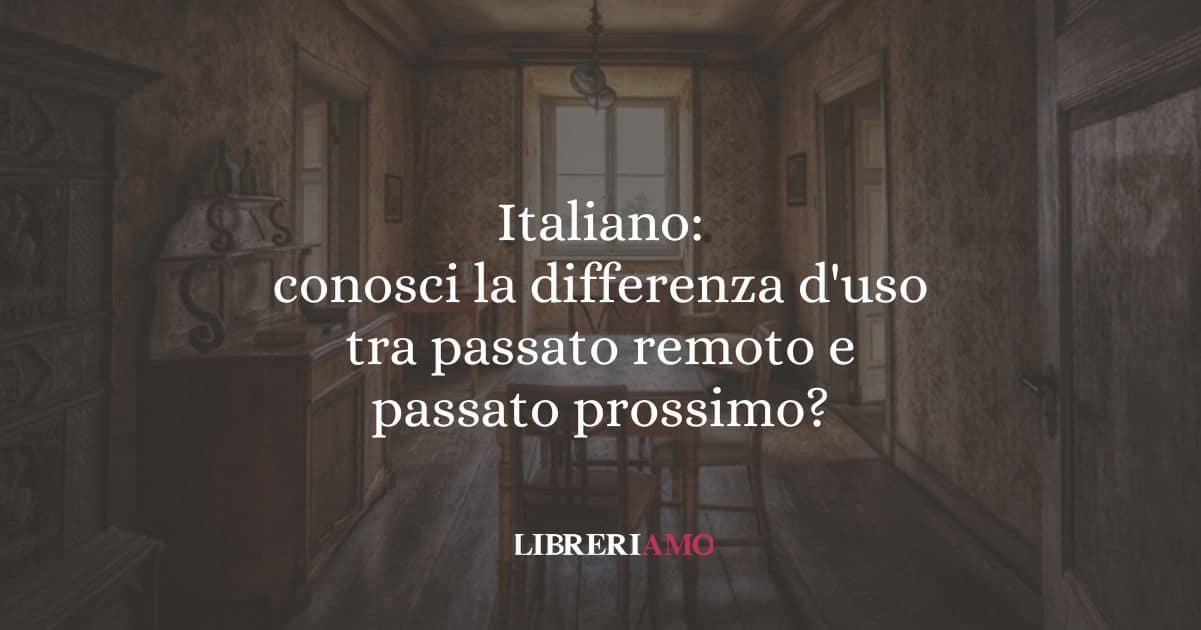
Nell’idioma italiano pochi argomenti grammaticali rivelano la profondità del nostro rapporto con il tempo quanto la distinzione tra passato remoto e passato prossimo. A prima vista, la differenza sembra puramente cronologica: il passato remoto per eventi lontani, il passato prossimo per eventi vicini. Ma questa spiegazione è solo superficiale. Come ricorda Bice Mortara Garavelli in un saggio pubblicato su La Crusca per voi, la scelta tra i due tempi non dipende tanto dalla distanza temporale dell’evento, quanto dal modo in cui lo percepiamo rispetto al presente: dal nostro punto di vista, dal grado di coinvolgimento emotivo, e dal tipo di testo o situazione comunicativa.
Il passato remoto e il passato prossimo, dunque, non sono semplicemente due modi di “collocare” un’azione nel passato, ma due strumenti che ci consentono di esprimere la nostra relazione con quel passato — se lo sentiamo ancora vivo, attuale, oppure se lo percepiamo chiuso e distante.
Italiano e percezione del passato: collegato o separato dal presente
Il passato prossimo, come suggerisce il suo stesso nome, indica qualcosa che, pur essendo accaduto, mantiene un legame con il presente. È il tempo verbale che usiamo per raccontare eventi di cui percepiamo ancora gli effetti o che appartengono a una cornice temporale che include l’oggi. Quando diciamo: “Ho mangiato troppo”, non stiamo semplicemente descrivendo un’azione passata, ma sottintendiamo che ne sentiamo ancora le conseguenze — magari un certo peso sullo stomaco.
Allo stesso modo, dire “È morto il mio vicino di casa” (anche se l’evento è avvenuto ieri) significa che la sua assenza ha ancora un effetto percepibile nel presente: il dolore, il ricordo, il cambiamento nel quotidiano. Il passato prossimo è, come scriveva il linguista Giacomo Devoto, il tempo di ciò che “lascia tracce” nel presente.
Il passato remoto, invece, esprime il distacco. È il tempo dell’evento compiuto, chiuso, che non lascia più segni sulla realtà di chi parla. Dire “Giulio Cesare morì nel 44 a.C.” significa parlare di un fatto totalmente separato dal presente, ormai fissato nel tempo. Il passato remoto, come sottolinea Mortara Garavelli, è “remoto” non perché cronologicamente lontano, ma perché psicologicamente rimosso, “separato” — proprio come indica la sua etimologia latina remotus, “allontanato”.
In questo senso, la differenza tra i due tempi non è oggettiva, ma soggettiva e prospettica: dipende da come l’oratore o lo scrittore colloca l’evento rispetto al momento dell’enunciazione.
L’aspetto diatopico: una questione geografica
Giovanni Nencioni, altro grande linguista italiano, aggiunge un ulteriore elemento di riflessione: la variazione geografica nell’uso dei due tempi. Anche questa osservazione, riportata in La Crusca per voi, ci mostra quanto la lingua non sia un sistema rigido, ma un organismo vivo che cambia a seconda dei luoghi e delle abitudini dei parlanti.
Nel Nord Italia prevale nettamente l’uso del passato prossimo: un torinese o un milanese tenderà a dire “Ieri sono andato al mare” o “Tre anni fa ho visitato Roma”, anche per eventi ormai lontani. Nel Sud, invece, è ancora molto diffuso il passato remoto, come “Ieri andai al mare” o “L’anno scorso visitai Roma”. La Toscana, considerata da molti linguisti la regione dove l’alternanza tra i due tempi è più equilibrata, conserva una sensibilità linguistica particolare: in un fiorentino si può ancora sentire la distinzione netta tra “Ho mangiato” e “Mangiai”, a seconda del senso di continuità o di chiusura dell’azione.
Questa distribuzione diatopica, influenzata dai dialetti locali, dimostra che la grammatica non è mai solo una questione di regole astratte: è anche il riflesso di un modo culturale di percepire il tempo. L’Italia settentrionale, dove prevale il passato prossimo, sembra mostrare una tendenza a collegare maggiormente il passato con il presente; il Sud, più ancorato al passato remoto, conserva una visione più narrativa, quasi epica, del tempo che fu.
Il valore stilistico e testuale dei tempi verbali
Ma la scelta tra passato remoto e passato prossimo non dipende solo dal parlante: varia anche in base al tipo di testo e al contesto comunicativo. Nella lingua scritta, soprattutto nella narrativa e nella storiografia, il passato remoto mantiene un ruolo fondamentale. È il tempo del racconto obiettivo, della cronaca storica, dell’azione compiuta e finita. In un romanzo o in una biografia si scriverà: “Giovanni uscì di casa e vide l’alba sorgere sul mare”, non “è uscito” e “ha visto”, perché il narratore si colloca in un tempo distante e autonomo rispetto agli eventi.
Nel parlato quotidiano, invece, prevale il passato prossimo: più naturale, più vicino all’esperienza diretta e alle conversazioni informali. Dire “Ho visto Maria ieri” comunica una sensazione di immediatezza, di realtà ancora presente nella memoria.
La scelta del tempo verbale, dunque, non è mai neutra: rivela il punto di vista di chi parla e la funzione del discorso. Un giornalista, un narratore o uno storico scelgono il tempo verbale come strumento per costruire un rapporto preciso tra passato e presente, tra evento e memoria.
Due tempi, due sguardi sul mondo
In definitiva, la distinzione tra passato remoto e passato prossimo non è solo grammaticale: è filosofica. Riflette due diversi modi di rapportarsi al tempo e all’esperienza. Il passato prossimo lega, mantiene vivi i fili con ciò che è stato, suggerisce continuità e permanenza. Il passato remoto, invece, separa, chiude, trasforma l’esperienza in storia.
Saperli distinguere e scegliere consapevolmente non significa solo padroneggiare meglio la lingua, ma anche padroneggiare il proprio modo di guardare al passato. La lingua italiana, con la sua ricchezza di sfumature temporali, ci offre la possibilità di decidere se un evento — grande o piccolo che sia — appartiene ancora al nostro presente o se, invece, è ormai consegnato definitivamente alla memoria. Per saperne di più: Sull’uso del passato remoto.