Italiano: 5 parole rare e affascinanti da conoscere
Scopriamo assieme l’origine e il significato di queste cinque parole appartenenti all’italiano dotto, che quasi non si usano più.
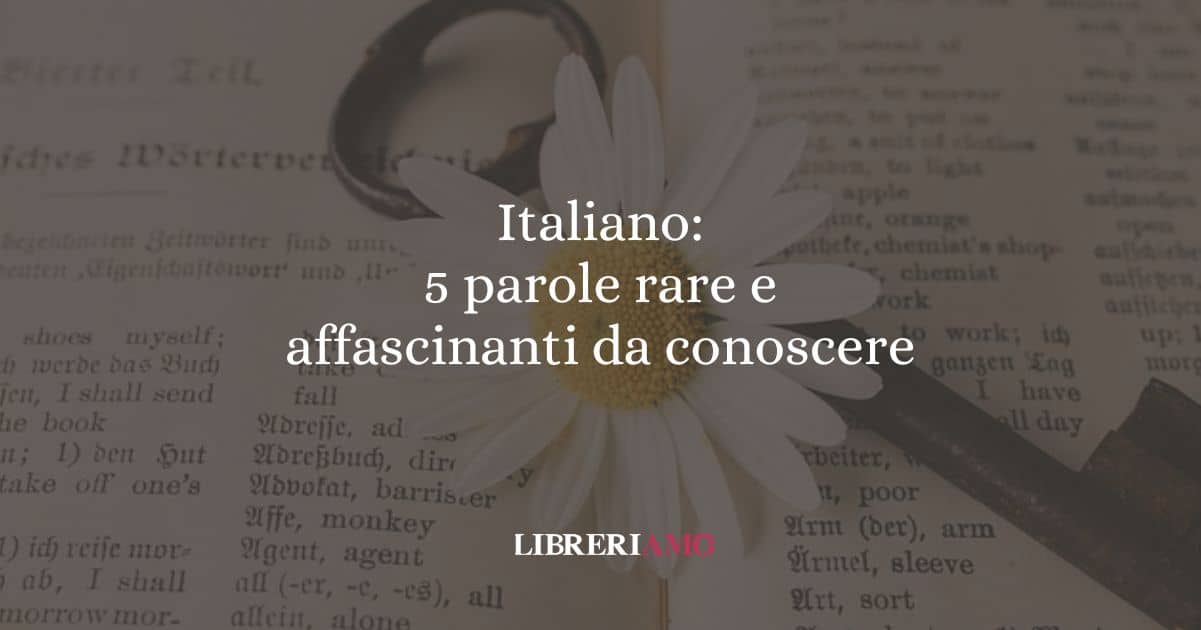
Il lessico contenuto nel vocabolario italiano è un immenso scrigno di tesori, che custodisce parole dal sapore arcaico, termini specialistici, prestiti da altre lingue e raffinate espressioni poetiche. Alcune di queste parole non appartengono al linguaggio quotidiano, ma proprio per questo conservano un’aura di fascino e di preziosità. Analizziamo dunque cinque vocaboli – tabarro, flanare, limnico, serico e pletorico – che, pur diversi tra loro, offrono un interessante viaggio attraverso la storia, la letteratura e la sensibilità linguistica.
Tabarro: il mantello divenuto cappotto
La parola tabarro designa un ampio mantello pesante, generalmente di lana scura, che veniva indossato soprattutto dai contadini, dai viandanti o dagli uomini del popolo fino al XIX secolo. Il termine ha un’origine incerta, probabilmente riconducibile allo spagnolo tabardo, a sua volta derivato dal francese antico tabard, che indicava un mantello da viaggio.
Il tabarro non era soltanto un capo di vestiario, ma un vero simbolo sociale e culturale: serviva a ripararsi dal freddo, ma anche a conferire un’aura di mistero, visto che poteva facilmente celare i movimenti o il volto di chi lo indossava. Non a caso, il tabarro compare spesso nella letteratura e nell’opera lirica: basti pensare alla celebre Tosca di Puccini, dove Mario Cavaradossi indossa un tabarro.
Ancora oggi, seppure raro, il termine può essere usato in senso figurato per indicare un velo, una copertura che cela qualcosa: “un tabarro di silenzio” o “un tabarro di malinconia”.
Flanare: l’arte di passeggiare senza meta
Il verbo flanare proviene dal francese flâner, che significa passeggiare senza fretta, bighellonare, osservare con curiosità l’ambiente circostante. Da questo verbo deriva il sostantivo flâneur, reso celebre da Charles Baudelaire e da Walter Benjamin, che descrive la figura del gentiluomo urbano dell’Ottocento che vaga per le strade di Parigi cogliendo suggestioni e riflessioni estetiche.
In italiano, il verbo “flanare” è poco comune e spesso rimane confinato all’uso colto o letterario. Tuttavia, possiede un valore evocativo straordinario: indica un camminare libero, svincolato da obblighi e scadenze, che diventa atto di contemplazione e conoscenza del mondo. Non è una semplice passeggiata, ma un esercizio dell’anima, un modo di appropriarsi della città e delle sue atmosfere. In un’epoca dominata dalla fretta, recuperare il senso del “flanare” significa ritrovare una dimensione di lentezza e di attenzione.
Limnico: il mondo delle acque
Il termine limnico deriva dal greco limnḗ, che significa “stagno” o “lago”. È un aggettivo tecnico, usato soprattutto in ambito scientifico, per indicare ciò che è relativo ai laghi o agli ambienti d’acqua dolce. Si parla, ad esempio, di fauna limnica, flora limnica o ecosistemi limnici.
Questa parola, sebbene appartenente prevalentemente al linguaggio specialistico, possiede un fascino poetico. Richiama immediatamente paesaggi silenziosi, specchi d’acqua immobile, zone umide abitate da creature sottili e delicate. In un contesto letterario, potrebbe essere impiegata per evocare atmosfere rarefatte, sospese tra terra e acqua, tra immobilità e trasformazione.
Serico: la delicatezza della seta
L’aggettivo serico deriva dal latino sericus, “di seta”. È quindi un termine che significa “setoso”, “fatto di seta” o “simile alla seta”. In epoca antica, parlare di tessuti serici equivaleva a evocare il lusso e la raffinatezza delle stoffe provenienti dall’Oriente, in particolare dalla Cina.
Oggi la parola è poco utilizzata nella lingua comune, sostituita dall’aggettivo “setoso”. Tuttavia, mantiene un tono elegante e prezioso. Definire una veste, un drappo o persino un paesaggio “serico” significa dotarlo di una qualità tattile e visiva particolare, morbida, brillante, raffinata. Non a caso, “serico” può essere usato anche in senso figurato, per descrivere un tratto delicato di voce, un atteggiamento gentile, una luce tenue.
Pletorico: l’eccesso e l’esuberanza
Infine, la parola pletorico proviene dal greco plḗthōr, “abbondanza, pienezza”. In origine, in medicina, indicava uno stato patologico di eccessiva pienezza di sangue nel corpo. Da lì il termine ha assunto un valore più generale, significando “sovrabbondante, eccessivo, troppo carico”.
Si può parlare di un discorso pletorico quando è ridondante, gonfio di parole superflue. Oppure di un apparato pletorico quando è caratterizzato da un eccesso di elementi, da un rigonfiamento che ne compromette la funzionalità. Al tempo stesso, l’aggettivo può assumere un senso ironico o letterario, descrivendo un carattere esuberante, traboccante di vitalità.
L’italiano e la bellezza della rarità
Tabarro, flanare, limnico, serico e pletorico: cinque parole diverse per origine e campo d’uso, ma accomunate dalla capacità di arricchire il nostro lessico e la nostra immaginazione. Esse ci ricordano che la lingua non è solo uno strumento pratico di comunicazione, ma anche un serbatoio di memorie storiche, culturali e sensoriali.
Il tabarro evoca il calore di un mantello e il mistero delle figure che lo indossano; flanare restituisce la lentezza poetica del passeggiare; limnico apre il mondo silenzioso dei laghi; serico regala la morbidezza della seta; pletorico ci mette di fronte agli eccessi della parola e della vita.
In un’epoca in cui il linguaggio tende alla semplificazione e all’impoverimento, riscoprire e usare termini come questi significa difendere la ricchezza della lingua italiana e, con essa, la profondità del pensiero e della sensibilità.