Infobulimia: storia e significato del neologismo entrato nel dizionario Treccani
Scopriamone l’origine e il significato di questo neologismo, figlio del nostro tempo in cui siamo immersi da informazioni e stimoli provenienti da infinite fonti.
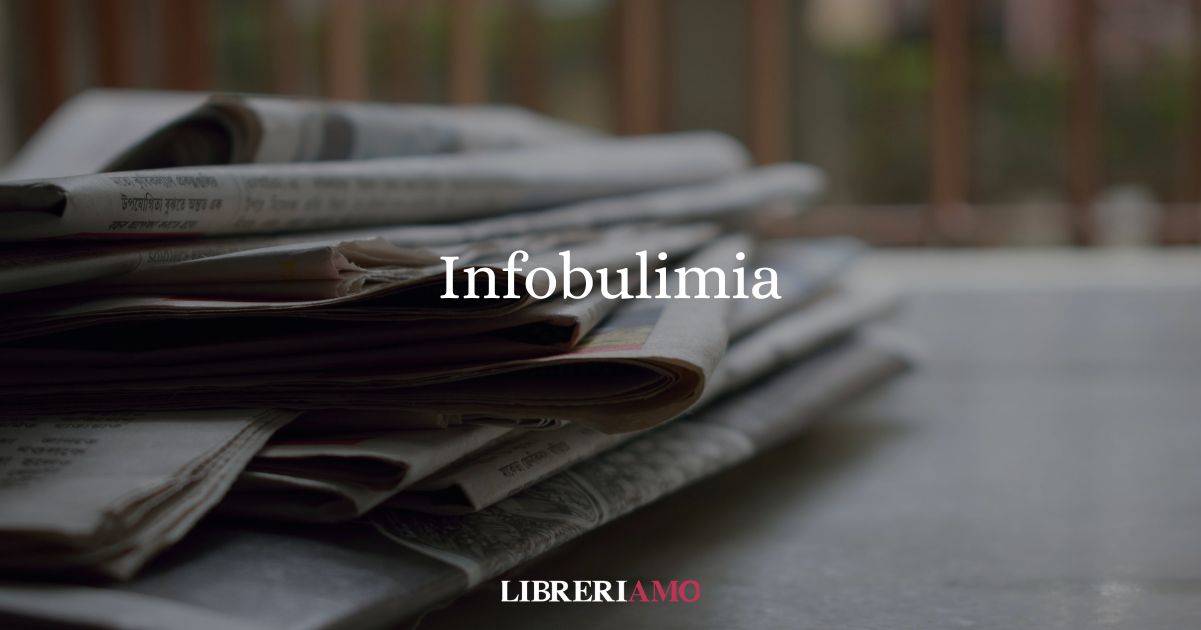
Una nuova entrata tra i neologismi della lingua italiana: l’enciclopedia Treccani ha infatti inserito il termine “infobulimia” tra i nuovi termini entrati nel linguaggio quotidiano. Scopriamone l’origine e il significato di questa parola, figlia del nostro tempo in cui siamo immersi da informazioni e stimoli provenienti da infinite fonti.
Cosa significa “infobulimia”
Il significato della parola è descritto come “la circolazione di una quantità sovrabbondante di informazioni che produce un sovraccarico cognitivo”. Il neologismo “infobulimia” indica quindi la compulsione o la dipendenza nel consumare continuamente informazioni, spesso senza la capacità o il tempo di elaborarle in modo critico. È un termine che lega il concetto di bulimia nervosa – caratterizzata da un’assunzione eccessiva e incontrollata di cibo – al contesto dell’informazione, evidenziando una vera e propria patologia della conoscenza nell’era digitale.
Come si manifesta e le conseguenze
L’infobulimia, pur non essendo riconosciuta come una diagnosi clinica formale nel DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), è un concetto sociologico e psicologico che inquadra il sovraccarico informativo (information overload) come un disturbo comportamentale.
Chi ne soffre non cerca l’informazione per necessità, ma per una coazione a ripetere, tipicamente manifestata nel controllo costante di feed di notizie, email, notifiche e social media. L’obiettivo primario non è arricchirsi, ma calmare l’ansia derivante dal timore di perdere l’ultima notizia o tendenza (Fear of Missing Out, FOMO).
L’eccesso di dati non porta a una maggiore consapevolezza, ma al contrario, alla superficialità e a un’incapacità di discernimento. Si traduce in stress, fatica mentale, calo della produttività e, paradossalmente, un senso di confusione anziché di chiarezza.
L’origine del neologismo
La parola infobulimia ha iniziato a circolare nel dibattito pubblico e mediatico all’inizio degli anni 2000, in parallelo con l’esplosione di Internet, dei feed di notizie in tempo reale e dei primi smartphone.
Sebbene il concetto di information overload risalga a epoche precedenti, la sua manifestazione come “bulimia” è stata favorita dall’accessibilità illimitata e dalla produzione esponenziale di contenuti digitali.
Il neologismo è potente perché utilizza la metafora del disturbo alimentare per descrivere un problema tipico della società dell’informazione: l’incapacità di sazietà. Proprio come la bulimia, il ciclo dell’infobulimia è distruttivo: l’eccesso di consumo non porta a nutrimento, ma al suo opposto.
I contesti in cui viene utilizzato
Le attestazioni d’uso degli ultimi vent’anni mostrano l’applicazione del termine in diversi contesti: da quello legato alle psicopatologie associate alla dipendenza da connessione, dove viene impiegato per descrivere una ricerca compulsiva di informazioni; all’ambito mediatico, per indicare – come evidenziato da Leonardo Mala su Repubblica.it (3 aprile 2009) – “la massa di notizie che il sistema dei media ingerisce a ciclo continuo e che immediatamente rigetta senza elaborazione”.
Più recentemente, il termine è usato anche in riferimento alle pratiche di ricerca online, che si traducono spesso “in un dispendio di tempo, energie e frustrazione”, come osservato da R. Guelfi e F. Saviano (goWare, 2024).
La differenza con Infodemia
Come indicato dalla stessa Treccani, il termine infobulimia “talvolta inteso come sinonimo di infodemia“, parola che si è affacciata nel nostro linguaggio quotidiano in occasione della pandemia e della conseguente circolo di informazioni e ricerca di news relative al Covid. Sebbene entrambi i fenomeni sono strettamente collegati e tipici dell’era digitale, occorre però usare i due termini nel modo corretto; mentre l’infobulimia è un disturbo individuale e comportamentale (la compulsione a consumare), l’infodemia è un problema sociale più ampio, che definisce la circolazione incontrollata di una quantità eccessiva di informazioni, spesso false o fuorvianti, che rendono difficile l’orientamento.
Una parola figlia della società contemporanea
Come avviene per tutti i neologismi che entrano nel nostro vocabolario, il frequente utilizzo della parola infobulimia riflette la necessità di selezionare, interpretare e valutare criticamente le informazioni in un contesto dominato dall’abbondanza e dall’immediatezza. Un’esigenza che papa Francesco aveva già richiamato a inizio anno, in occasione del Giubileo della Comunicazione, quando, con la premessa “volevo soltanto dire una parola” segnalava l’urgenza di contrastare la bulimia informativa attraverso essenzialità, credibilità e autenticità, principi che delineano la responsabilità di chi comunica.