100 anni de “Il grande Gatsby”, il capolavoro di Francis Scott Fitzgerald
In occasione dell’anniversario della nascita di Francis Scott Fitzgerald celebriamo i 100 anni de “Il grande Gatsby” uno dei classici più belli di sempre.
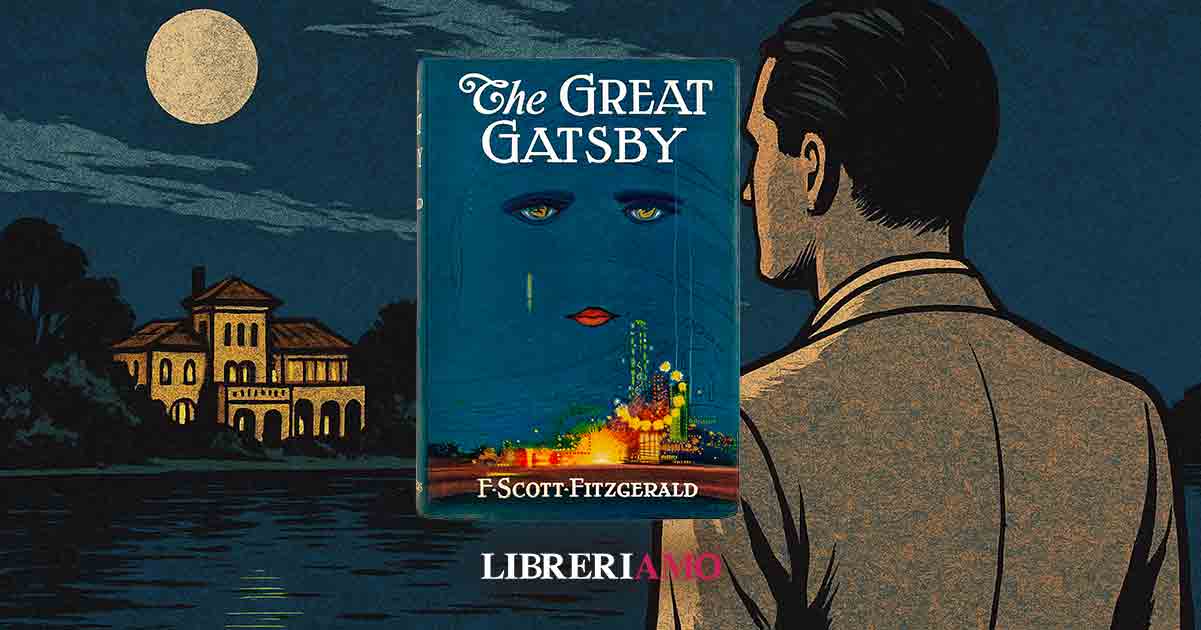
Il 24 settembre è l’anniversario di nascita di Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, Minnesota, 1896) e vogliamo augurare buon compleanno a questo grandissimo autore celebrando i 100 anni del suo capolavoro, Il grande Gatsby, pubblicato per la prima volta a New York il 10 aprile 1925. Un romanzo breve e folgorante, che ha saputo racchiudere lo spirito degli anni Venti americani e insieme le fragilità universali dell’animo umano.
Fitzgerald, con la sua scrittura elegante e musicale, ha immortalato la Jazz Age (Età del jazz), quell’epoca di feste sfrenate, ricchezze improvvise e illusioni scintillanti che segnarono gli Stati Uniti del Proibizionismo. Ma dietro i lustrini e le ville di Long Island, Il grande Gatsby racconta la disillusione di un sogno americano che si sgretola sotto il peso della realtà, la solitudine dietro l’apparenza, la nostalgia di un passato che non può più tornare.
A distanza di un secolo, il libro non ha perso nulla della sua attualità. I personaggi di Gatsby, Daisy e Tom continuano a parlare all’umanità di desiderio, denaro, potere e fragilità dei sentimenti, restituendo uno specchio fedele non solo degli anni ’20, ma anche del presente fatto di apparenze, status symbol e promesse luminose destinate a spegnersi.
Il contesto storico: la Jazz Age e l’illusione della modernità
Quando Il grande Gatsby vide la luce nel 1925, gli Stati Uniti stavano vivendo una stagione di trasformazioni radicali. Erano gli anni del Proibizionismo (1920-1933), che da un lato vietava la vendita di alcolici, dall’altro alimentava un fiorente mercato clandestino fatto di speakeasy, corruzione e arricchimenti improvvisi. È l’epoca delle grandi metropoli in espansione, della musica jazz che invade club e sale da ballo, della nascita del cinema sonoro, della pubblicità e della cultura di massa.
Il decennio dei “Ruggenti Anni Venti” sembrava incarnare il trionfo del progresso e della libertà individuale. La Prima guerra mondiale era alle spalle e una nuova generazione si gettava nella modernità con entusiasmo, tra automobili, radio e abiti scintillanti. Eppure, dietro questa euforia collettiva si celava una crescente inquietudine. L’economia viveva di speculazioni fragili, le disuguaglianze sociali si accentuavano e l’ansia di status sociale divorava i rapporti umani.
È in questo scenario che Francis Scott Fitzgerald, acuto cronista del suo tempo, ambienta Il grande Gatsby. Un romanzo che non si limita a fotografare la sua epoca, ma la decostruisce, mostrando come la corsa al successo e all’apparenza possa trasformarsi in una trappola esistenziale.
La trama de Il grande Gatsby: sogni, illusioni e disincanto
Il romanzo è narrato da Nick Carraway, un giovane del Midwest che nel 1922 si trasferisce a Long Island, a West Egg, per lavorare a New York nel settore finanziario. La sua casa modesta si trova accanto a una villa sontuosa appartenente a un uomo misterioso e affascinante: Jay Gatsby.
Gatsby è famoso per le sue feste colossali, dove si riversa tutta la società elegante e dissoluta dell’epoca: musica jazz, alcol proibito, abiti luccicanti e conversazioni superficiali. Ma dietro quell’opulenza si nasconde un desiderio segreto: riconquistare Daisy Buchanan, la donna amata anni prima e ora sposata con Tom Buchanan, un uomo ricchissimo, arrogante e conservatore, che incarna il potere e la brutalità della “vecchia” aristocrazia americana.
Nick, cugino di Daisy, diventa l’anello di congiunzione. Gatsby lo convince a organizzare un incontro con lei. La scintilla si riaccende, e Gatsby sogna di poter tornare indietro nel tempo, cancellando gli anni trascorsi e l’esistenza di Tom. Ma il romanzo ci mostra quanto sia illusorio voler ripetere il passato. Daisy, pur attratta dalla passione di Gatsby, non riesce a rompere con la sicurezza materiale e sociale garantita dal marito.
Sul fondo si muovono altre figure che ampliano il quadro sociale e morale dell’epoca:
Jordan Baker, giocatrice di golf e amica di Daisy, simbolo di un femminile moderno e indipendente, ma anche cinico.
Myrtle Wilson, amante di Tom, che rappresenta la classe lavoratrice assetata di riscatto, e suo marito George, meccanico stanco e disperato, che vive nella “valle delle ceneri”, una landa grigia segnata dal degrado industriale.
Il crescendo narrativo porta a un conflitto drammatico tra Gatsby e Tom, che rivela l’impossibilità di abbattere le barriere di classe e di sostituire l’illusione al reale. La storia culmina in un epilogo tragico, in cui l’amore, il sogno e la stessa vita di Gatsby si infrangono contro la brutalità di un mondo che preferisce chiudere gli occhi e rifugiarsi nel privilegio.
Nick, unico personaggio a provare autentica empatia per Gatsby, diventa la voce che consegna al lettore la parabola di un uomo che ha vissuto inseguendo una luce verde lontana, simbolo universale di speranza, desiderio e illusione.
Il sogno americano come non era mai stato raccontato
Al centro del romanzo c’è l’idea del sogno americano, inteso come possibilità di reinventarsi e conquistare successo e felicità grazie al talento e alla determinazione. Gatsby ne è l’incarnazione perfetta. Nato povero, si reinventa da zero, costruendo una fortuna immensa.
Ma la sua ricchezza nasce da attività losche e non gli permette di superare i confini invisibili tra “nuovi ricchi” e “vecchia aristocrazia”. Fitzgerald mostra così la contraddizione di un sogno che, da promessa di libertà, diventa illusione corrotta.
La nostalgia del passato: il sogno impossibile di Gatsby
Uno dei nuclei più potenti de Il grande Gatsby è l’ossessione per il passato perduto. Gatsby non è solo un uomo innamorato, è un uomo convinto di poter fermare e riscrivere il tempo. La sua idea fissa è Daisy com’era cinque anni prima, quando si erano conosciuti. Non importa che ora sia sposata, che la vita sia andata avanti, che lui stesso non sia più lo stesso. Gatsby è persuaso che “si possa ripetere il passato”.
In questa frase celebre, pronunciata con ingenua ostinazione, “Non si può ripetere il passato? Certo che si può!”, si racchiude il dramma del personaggio. La sua esistenza è dedicata a ricostruire una condizione perfetta e irripetibile, e tutta la sua ricchezza non è altro che uno strumento per riattivare quel momento cristallizzato nel tempo.
La nostalgia di Gatsby non è quindi un sentimento tenero o contemplativo, ma una forza devastante, che lo separa dalla realtà. Egli non vede Daisy per ciò che è, con le sue fragilità e ambiguità, ma come un’icona intatta del passato. E proprio questo scarto tra ideale e reale lo conduce verso la tragedia.
Fitzgerald ci consegna così una verità universale: il passato non è mai ripetibile, e il tentativo di ricrearlo è destinato a trasformarsi in disillusione. La nostalgia, nel romanzo, diventa un mito moderno: promette salvezza, ma in realtà rivela l’impossibilità di possedere il tempo e di rendere eterno ciò che per sua natura è fugace.
Il pregiudizio sugli “arricchiti”: tra East Egg e West Egg
Uno degli elementi più incisivi del romanzo è la divisione geografica e simbolica tra East Egg e West Egg, le due comunità di Long Island dove vivono i protagonisti. Da un lato, East Egg rappresenta la ricchezza “antica”, ereditata, nobilitata dal tempo e dalle genealogie. Dall’altro, West Egg è la patria dei “nuovi ricchi”, coloro che si sono fatti da sé, spesso con metodi poco chiari, e che ostentano il lusso in modo appariscente.
Gatsby appartiene a West Egg, e questo lo condanna, almeno agli occhi dell’élite di East Egg. Per quanto immensa sia la sua fortuna, non potrà mai essere considerato “uno di loro”. La sua villa sontuosa, le feste spettacolari, gli abiti eleganti, tutto in lui appare come una copia, un’imitazione dell’alta società, non una sua espressione autentica.
Il pregiudizio sugli “arricchiti” è uno dei cardini della critica sociale di Francis Scott Fitzgerald, che smaschera la presunta apertura del sogno americano, mostrando come in realtà le barriere di classe restino invalicabili. L’arroganza di Tom Buchanan, che disprezza Gatsby nonostante la sua ricchezza, incarna perfettamente questa mentalità.
In questa dinamica si rivela l’ipocrisia della società dell’epoca e, in fondo, anche della nostra. La meritocrazia viene celebrata a parole, ma in pratica chi proviene “da fuori” resta sempre un intruso. Gatsby, pur avendo costruito un impero, resta agli occhi di Daisy e Tom un outsider, un parvenu che non potrà mai ottenere l’unico riconoscimento che desidera: l’appartenenza al loro mondo.
Amore e desiderio come proiezione
Nel cuore del romanzo, l’amore non è mai un incontro autentico tra due esseri umani, ma una costruzione mentale, una proiezione di desideri e aspettative. Nessun personaggio ama davvero l’altro per ciò che è. Ognuno insegue un’immagine, un simbolo, un ideale.
Gatsby ama Daisy, ma non Daisy in carne e ossa. Ama il ricordo di un pomeriggio perfetto, il fascino di una voce che “suona come piena di soldi”, l’illusione di un passato che può tornare. Daisy, agli occhi di Gatsby, non è una donna con limiti e fragilità, ma un’icona luminosa, un talismano che può riscattare la sua vita. Per questo il suo sentimento, pur fortissimo, è condannato a non reggere all’urto della realtà.
Daisy ama Gatsby? Forse prova per lui nostalgia e attrazione, ma ciò che realmente la lega è il conforto del privilegio. Non sceglie lui, ma ciò che lui rappresenta, un’alternativa, una promessa. Alla fine, resta con Tom perché dietro l’amore intravede soprattutto sicurezza materiale e sociale.
Persino Tom e Myrtle vivono una relazione che non è amore ma bisogno: Tom cerca vitalità e potere, Myrtle cerca evasione e status. Lo stesso Nick, pur critico, si lascia attrarre da Jordan, simbolo di un femminile moderno e spregiudicato, più che da una donna concreta.
Fitzgerald ci mostra così che il desiderio spesso non si rivolge alla persona, ma a ciò che proiettiamo su di essa: un ideale, una promessa, una possibilità di trasformazione. L’amore in Il grande Gatsby non è mai reciproco, ma sempre asimmetrico, filtrato da immagini, ricordi e illusioni. È questo scarto tra desiderio e realtà a rendere inevitabile la disillusione.
I simboli che definiscono un’epoca
Francis Scott Fitzgerald riesce a condensare l’intero spirito degli anni Venti attraverso una serie di simboli potenti, che non sono semplici dettagli narrativi, ma vere e proprie chiavi di lettura universali. Ognuno di essi racconta tanto l’atmosfera del Jazz Age quanto i dilemmi eterni dell’essere umano.
La luce verde
Situata all’estremità del molo di Daisy, la luce verde è il simbolo per eccellenza del romanzo. Per Gatsby rappresenta la speranza, la promessa di un futuro da conquistare, l’amore che sembra a portata di mano. Ma è anche la testimonianza di un’eterna distanza: qualcosa che brilla e guida, senza mai farsi raggiungere. È il simbolo del desiderio infinito e irrealizzabile che muove l’uomo, ma che al tempo stesso lo condanna.
Gli occhi del Dottor T. J. Eckleburg
Il grande cartellone pubblicitario che domina la “valle delle ceneri”, con i suoi occhi enormi e vuoti, appare come un dio moderno e distaccato. Alcuni personaggi li interpretano come il giudizio divino, altri li ignorano del tutto. In realtà simboleggiano la vacuità di una società che consuma e abbandona, in cui anche lo sguardo divino sembra ridotto a réclame, un’immagine senza anima.
La valle delle ceneri
Tra New York e Long Island si estende una distesa grigia, desolata, fatta di polvere e rifiuti industriali. È lo spazio dei vinti, della fatica senza riscatto, dove vivono i Wilson. Rappresenta il contraltare oscuro del sogno americano, la prova che l’opulenza dei ricchi si regge sullo sfruttamento e sulla marginalità di altri.
Le feste di Gatsby
Apparentemente sfavillanti, le feste sono in realtà il trionfo della superficialità: centinaia di invitati che non conoscono il padrone di casa, conversazioni frivole, musica e alcol che mascherano il vuoto. Sono la metafora del consumo di massa, dell’effimero che brucia in una notte e lascia solo solitudine.
Le automobili
Le macchine sono status symbol, segno di modernità e potere, ma diventano anche strumenti di distruzione. Nel romanzo un’auto provoca l’evento che segna la svolta tragica della trama: simbolo della velocità senza controllo, della superficialità con cui i privilegiati giocano con la vita altrui.
I colori
Fitzgerald costruisce un vero e proprio codice cromatico: il verde della speranza, il giallo dell’oro e dell’illusione, il grigio della disperazione. Ogni colore non descrive solo la realtà, ma la carica di significati morali ed emotivi.
Questi simboli, così concreti e allo stesso tempo carichi di senso, hanno reso Il grande Gatsby un’opera capace di sopravvivere al tempo: non raccontano solo gli anni Venti, ma ogni epoca in cui l’uomo insegue sogni, status e desideri più grandi di lui.
Aneddoti e curiosità su Il grande Gatsby
Un libro che fu un flop
Oggi è considerato uno dei più grandi romanzi del Novecento, ma al momento della pubblicazione nel 1925 Il grande Gatsby vendette appena 24.000 copie. Francis Scott Fitzgerald rimase profondamente deluso, sperava che fosse il libro della consacrazione, ma non ricevette né il successo di pubblico né quello economico. Solo dopo la sua morte il romanzo venne riscoperto e rivalutato, fino a diventare un classico.
Il titolo che non convinceva
Fitzgerald non era sicuro del titolo. Aveva proposto diverse alternative, alcune delle quali oggi suonano decisamente meno evocative. Tra i candidati c’erano Among the Ash-Heaps and Millionaires (Tra i cumuli di cenere e i milionari), Trimalchio in West Egg (un riferimento a un personaggio dell’antica Roma noto per le sue feste ostentate), Gold-Hatted Gatsby (Gatsby dal cappello d’oro) e persino il più semplice Under the Red, White, and Blue (Sotto il rosso, il bianco e il blu). Fu il suo editore, Maxwell Perkins, a insistere per The Great Gatsby, un titolo che lo scrittore accettò con qualche riserva.
L’ispirazione reale per Gatsby
Alcuni biografi hanno ipotizzato che Gatsby fosse ispirato a veri “self-made men” dell’epoca, come il gangster Arnold Rothstein, noto per traffici loschi e per il lusso ostentato. Altri hanno visto echi della stessa esperienza di Fitzgerald, un giovane di origini non aristocratiche, che cercava di conquistare l’alta società per amore, nel suo caso la moglie Zelda Sayre.
Le illustrazioni della copertina
La copertina originale del libro, con i malinconici occhi femminili che fluttuano sopra un luna park notturno, è diventata una delle più iconiche della storia della letteratura. L’opera, intitolata Celestial Eyes, fu creata dall’artista Francis Cugat.
Fitzgerald ne fu così affascinato che dichiarò di aver “scritto il libro dentro di essa”, integrando l’immagine degli occhi nel romanzo attraverso il simbolico cartellone del Dottor T. J. Eckleburg nella Valle delle Ceneri.
Dal flop al mito grazie alla guerra
La rinascita del libro avvenne in un contesto inaspettato: la Seconda Guerra Mondiale. L’organizzazione “Council on Books in Wartime” selezionò “Il grande Gatsby” per essere stampato in un’edizione tascabile economica (le cosiddette “Armed Services Editions”) e distribuito a oltre 150.000 soldati americani al fronte.
Lontani da casa, i militari si identificarono con i temi della speranza, del sogno e della disillusione presenti nel romanzo, decretandone una seconda vita e una fama postuma che non ha mai smesso di crescere.
Hollywood e i film tratti da Il grande Gatsby
La potenza simbolica e visiva del romanzo di Fitzgerald ha sempre affascinato Hollywood, dando vita a numerosi adattamenti, ciascuno con un’interpretazione diversa dell’opera e del suo protagonista.
1949 – Alan Ladd
Il primo adattamento sonoro di successo fu quello diretto da Elliott Nugent, con Alan Ladd nei panni di Gatsby. Girato in un bianco e nero che accentuava il tono noir, il film rifletteva più i codici del cinema dell’epoca che l’atmosfera del Jazz Age.
1974 – Robert Redford e Mia Farrow
La versione diretta da Jack Clayton, con sceneggiatura di Francis Ford Coppola, è una delle più celebri. Robert Redford interpreta un Gatsby elegante e malinconico, mentre Mia Farrow è una Daisy fragile e sfuggente. Il film, sontuoso e fedele al romanzo, è ancora oggi ricordato per i costumi premiati con l’Oscar e per l’aura nostalgica che lo avvolge.
2013 – Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan
L’adattamento di Baz Luhrmann ha riportato Il grande Gatsby al centro della cultura pop. Estremamente barocco e spettacolare, unisce la ricostruzione anni Venti a una colonna sonora contemporanea (Jay-Z, Lana Del Rey), creando un contrasto volutamente anacronistico. Leonardo Di Caprio offre un Gatsby intenso, tormentato e romantico, che ha colpito soprattutto le nuove generazioni. Il film ha vinto due Oscar (costumi e scenografia) e ha consolidato l’immaginario visivo del romanzo presso il pubblico globale.
Ogni adattamento ha contribuito a fissare nell’immaginario collettivo l’immagine del milionario enigmatico, delle sue feste scintillanti e della luce verde sul molo. Se Redford ha dato al personaggio un’aura classica e romantica, DiCaprio lo ha trasformato in un’icona moderna della nostalgia e del desiderio impossibile.
L’eco in musica e cultura pop
Il grande Gatsby non è rimasto confinato alla letteratura: nel corso di un secolo è diventato un vero e proprio mito culturale, capace di ispirare artisti, musicisti, stilisti e registi.
Musica
Il romanzo ha influenzato interi generi musicali. L’adattamento di Baz Luhrmann del 2013, in particolare, ha rilanciato Gatsby nella cultura pop contemporanea con una colonna sonora esplosiva che mescolava jazz e hip hop (Jay-Z, Beyoncé, Lana Del Rey). La canzone Young and Beautiful di Lana Del Rey, scritta apposta per il film, è diventata l’inno malinconico di quell’universo di desideri e illusioni.
Moda e stile
Le feste di Gatsby hanno plasmato l’immaginario del glamour anni Venti, rilanciando piume, frange, paillettes e abiti scintillanti. Eventi e party a tema “Gatsby” si organizzano ancora oggi in tutto il mondo, da matrimoni a celebrazioni aziendali.
Cultura pop
Il mito di Gatsby è entrato nel linguaggio comune: “vivere come Gatsby” è diventato sinonimo di lusso sfrenato, mentre la “luce verde” è oggi un simbolo citato in film, serie TV, canzoni e articoli giornalistici. La frase finale, “Così continuiamo a procedere, barche contro corrente, risospinti senza posa nel passato” è tra le più citate nella cultura americana.
Influenze letterarie e artistiche
Molti scrittori contemporanei hanno ripreso temi e atmosfere del romanzo, dalla fragilità del sogno americano al fascino degli outsider. Gatsby continua a vivere nelle serie TV che raccontano ricchezza e decadenza (da Boardwalk Empire a Succession) e in produzioni teatrali e musicali che rivisitano la sua storia.
Chi è Francis Scott Fitzgerald
Francis Scott Key Fitzgerald nacque il 24 settembre 1896 a Saint Paul, Minnesota. Considerato uno dei più grandi scrittori americani del Novecento, fu insieme cronista e interprete del Jazz Age, espressione da lui stesso coniata per definire gli anni Venti: un’epoca di euforia economica, innovazioni culturali e inquietudini nascoste.
Fitzgerald esordì giovanissimo con Di qua dal Paradiso (1920), romanzo che lo rese subito celebre e lo introdusse nei circoli mondani newyorkesi. La sua vita fu segnata dall’amore appassionato e tormentato per Zelda Sayre, figura affascinante e complessa, che divenne musa e compagna, ma anche fonte di instabilità per via delle sue fragilità psichiche.
Tra gli anni Venti e Trenta pubblicò altri grandi romanzi:
Belli e dannati (1922), sul disincanto della gioventù dorata,
Il grande Gatsby (1925), la sua opera più celebre,
Tenera è la notte (1934), riflessione sulla fragilità e il declino, ambientata sulla Costa Azzurra.
Morì prematuramente il 21 dicembre 1940 a soli 44 anni, a Hollywood, dove lavorava come sceneggiatore. All’epoca era considerato uno scrittore in declino, quasi dimenticato; solo dopo la Seconda guerra mondiale la critica riscoprì la sua grandezza, consacrandolo tra i maestri indiscussi della letteratura americana.
Fitzgerald unisce la prosa lirica e musicale a una lucidissima capacità di analisi sociale. Le sue frasi sono intrise di malinconia, nostalgia, bellezza effimera. È il cantore dei sogni e delle illusioni, ma anche il critico impietoso della superficialità e delle disuguaglianze del suo tempo.
Oggi Francis Scott Fitzgerald è studiato in tutto il mondo come il romanziere della disillusione americana, colui che meglio di chiunque altro ha saputo cogliere il fascino e la fragilità del “sogno americano”. Il grande Gatsby, in particolare, è considerato il romanzo che racchiude l’essenza degli Stati Uniti del Novecento e la loro eredità culturale.
Perché Il grande Gatsby parla ancora a noi oggi
A cento anni dalla sua pubblicazione, Il grande Gatsby non è soltanto un ritratto dei ruggenti anni Venti americani, ma una riflessione universale sul rapporto tra desiderio e realtà, sogno e disillusione. Il romanzo ci ricorda che inseguire un ideale assoluto, sia esso l’amore perfetto, la ricchezza illimitata o la possibilità di riscrivere il passato, può trasformarsi in una condanna.
Oggi, nell’era dei social media, dell’ostentazione e della ricerca continua di status, Gatsby appare più attuale che mai. La rincorsa della “luce verde” che brilla all’orizzonte – follower, successo, visibilità, dominio – è diventata una marcia sfrenata senza chiedersi se ciò che si desidera corrisponda davvero chi si è. Il modello Gatsby è presente in tv, diventa oggetto di attenzione sfrenata da autorevoli organi d’informazione e naturalmente permette al mondo gossip di poter vivere.
La forza del romanzo sta nella sua duplicità, da un lato la seduzione dello splendore, dall’altro la spietata critica alla superficialità di chi “rompe cose e persone e poi si rifugia nel proprio denaro”. È per questo che Fitzgerald non consegna solo una storia d’amore o di fallimento, ma una lente per leggere ogni epoca segnata da illusioni collettive e sogni individuali.
Rileggere Il grande Gatsby oggi significa interrogarsi su cosa davvero muove la società dei consumi. Siamo disposti a vedere le persone per ciò che sono, o continuiamo a proiettare su di loro i nostri desideri? È la domanda che attraversa il romanzo e che, a distanza di un secolo, continua a fare di Gatsby non solo un personaggio letterario, ma un simbolo eterno della condizione umana.
Buon compleanno Francis Scott Fitzgerald e grazie per quest’opera che ancora oggi ha qualcosa da dire.