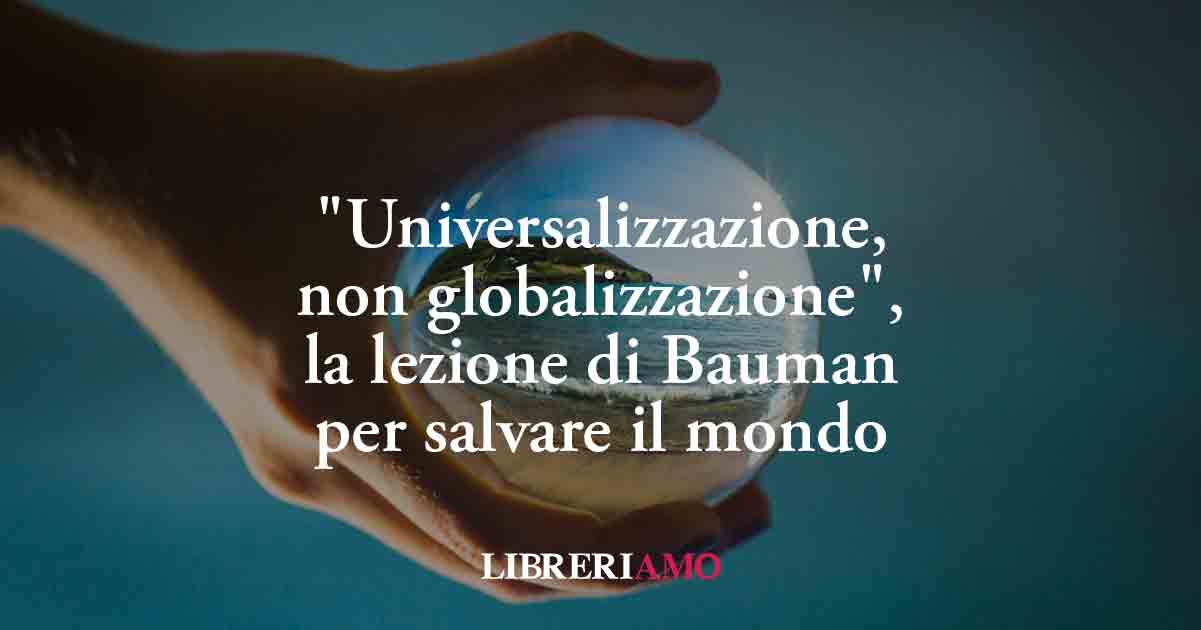C’è una frase di Zygmunt Bauman che racchiude un concetto ancora vivo nella riflessione filosofica, ma quasi del tutto ignorato dai media, dalla politica, dall’economia e persino dalle religioni. Un pensiero che, proprio in questa fase di grande caos globale, torna a imporsi con tutta la sua attualità.
La globalizzazione, nata con la promessa di abbattere i confini, unire le idee e armonizzare le culture, ha finito invece per generare, forse inconsapevolmente, la crisi mondiale che oggi stiamo vivendo. Quello che avrebbe dovuto essere un orizzonte di apertura si è trasformato in un’esperienza di frattura.
I confini che dovevano dissolversi sono tornati a chiudersi, le identità che avrebbero dovuto avvicinarsi si sono irrigidite, la difesa della nazione è diventata l’unica via percepita come possibile per salvarsi dai danni prodotti dal processo globale.
È in questo scenario che Zygmunt Bauman invita a ripensare una parola dimenticata, eppure decisiva: Universalizzazione.
L’universalizzazione, una volta elemento costitutivo del moderno discorso sugli affari globali, ma ormai caduta in disuso, raramente menzionata e forse più o meno dimenticata da tutti salvo che dai filosofi. Come i concetti di «civiltà», «sviluppo», «convergenza», «consenso» e molti altri termini chiave del pensiero proto- e classico-moderno, così l’idea di «universalizzazione» racchiudeva in sé la speranza, l’intenzione e la determinazione a creare un ordine; quella parola qualificava il senso di quanto ad essa veniva connesso o apparentato, ma significava soprattutto ordine universale, fare ordine su scala universale e davvero globale. Come gli altri concetti menzionati, l’idea di universalizzazione fu coniata sull’onda crescente delle capacità e delle risorse che le potenze moderne dispiegavano e delle ambizioni che la moderna intelligenza nutriva. Quell’insieme di concetti annunciava all’unisono la volontà di cambiare e rendere migliore il mondo, di diffondere il mutamento e il progresso a una dimensione globale, cioè all’umanità intera. Allo stesso tempo dichiarava l’intenzione di rendere simili le condizioni e le chances di vita di tutti, dovunque; forse, addirittura, di renderle eguali.
Che cosa Bauman intende per Universalizzazione
Nel libro Globalization. The Human Consequences, pubblicato da Polity Press-Blackwell Publishers Ltd., Cambridge-Oxford, nel 1998, la cui edizione italiana ha il titolo Dentro La Globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, con la traduzione di Oliviero Pesce, pubblicato da Laterza nel 2021, per Zygmunt Bauman l’universalizzazione non è uno slogan umanitario, ma è la grammatica profonda della modernità. Vuol dire trasformare l’indeterminato in determinato, l’ambivalenza in Eindeutigkeit (chiarezza), la casualità in regolarità.
Per farlo serve un attore capace di concentrare risorse e poteri: lo Stato moderno. È lo Stato, con il suo apparato burocratico gerarchico, a mobilitare la forza necessaria per “fare ordine” su un territorio e, per estensione, sul mondo. In questa visione, l’“ordine globale” non è altro che la somma di molti ordini locali, ciascuno custodito da un sovrano.
Lo Stato come macchina d’ordine
Bauman si muove qui in scia a Max Weber. Lo Stato è l’ente che detiene il monopolio dei mezzi di coercizione legittima. Ma aggiunge, con Cornelius Castoriadis, un punto decisivo: lo Stato è un apparato separato dalla collettività, costruito proprio per rendere permanente quella separazione e garantire la capacità di ordinare.
Per essere effettivo, quel potere si regge su tre colonne: una sovranità militare che protegga confini e imponga norme; una sovranità economica (la Nationalökonomie) che faccia “quadrare i conti” del progetto; una sovranità culturale che dia identità e coesione ai cittadini. L’universalizzazione, insomma, è il nome dell’aspirazione moderna a proiettare questa capacità d’ordine su scala universale.
La lezione di Bauman sull’univerasalizzazione che dovrebbe diventare concreta
Quando Bauman scrive che “l’universalizzazione, una volta elemento costitutivo del moderno discorso sugli affari globali, è ormai caduta in disuso, raramente menzionata e forse dimenticata da tutti salvo che dai filosofi”, costringe a guardare indietro alla storia della modernità. L’universalizzazione non era un concetto marginale, ma una categoria centrale: faceva parte di quel lessico con cui la modernità cercava di dare senso al proprio cammino. Insieme a parole come “civiltà”, “sviluppo”, “consenso”, “convergenza”, essa rappresentava una visione attiva, ordinatrice, che animava l’idea di progresso.
Universalizzare significava, in concreto, fare ordine su scala universale. Non un ordine qualsiasi, ma un ordine costruito, progettato, deliberato. L’umanità moderna si pensava come capace di trasformare la realtà in modo sistematico: dall’indeterminato al determinato, dall’ambivalenza alla chiarezza, dal caos alla regolarità.
È importante sottolinearlo: dietro l’universalizzazione non c’era solo la filosofia, ma anche la fiducia nella potenza materiale della modernità. Bauman parla di “onda crescente delle capacità e delle risorse che le potenze moderne dispiegavano” e delle “ambizioni che la moderna intelligenza nutriva”. In altre parole, era la combinazione tra nuove tecnologie, apparati statali centralizzati, economie nazionali sempre più forti, e un pensiero convinto che la ragione potesse ordinare il mondo.
Universalizzazione significava credere che il mutamento e il progresso potessero essere estesi a tutta l’umanità. Non era un progetto di chiusura, ma di espansione: migliorare il mondo intero, diffondere condizioni di vita più simili, forse addirittura uguali. Qui c’è l’eco dell’Illuminismo e della sua ambizione universale: la ragione non è patrimonio di un popolo, ma di tutti; il progresso non appartiene a una nazione, ma deve estendersi all’umanità intera.
Quella parola, “universalizzazione”, racchiudeva quindi tre tensioni fondamentali:
1. Etica
La speranza di un’umanità più giusta ed eguale.
2. Politica
La determinazione a creare istituzioni e regole condivise.
3. Pratica
L’intenzione di trasformare risorse e potenze in strumenti per “fare ordine” su scala globale.
Per questo Bauman dice che il concetto oggi è caduto in disuso. Non perché fosse superato o inutile, ma perché si è perso il coraggio di pensare il mondo in termini di progetto universale. Dove la modernità coltivava l’ambizione di costruire, il nostro tempo sembra aver rinunciato a quella fiducia, lasciandosi travolgere da dinamiche incontrollate che non hanno più un disegno.
Dal sogno universale al caos globale
Se l’universalizzazione incarnava il sogno moderno di un ordine globale, la fiducia che l’umanità potesse diventare progressivamente più unita, più simile, persino più giusta, la parola che l’ha sostituita negli ultimi decenni racconta invece tutt’altro: la globalizzazione.
La differenza è radicale. Mentre l’universalizzazione nasceva come progetto consapevole, fondato sulla volontà di pianificare, regolare, diffondere progresso e costruire un ordine comune, la Globalizzazione, per Bauman, non ha nulla di progettuale. Non è il frutto di una decisione politica o di una visione filosofica, ma il nome che diamo agli effetti non previsti e non governati delle nostre azioni.
Là dove l’universalizzazione era animata dalla speranza e dall’intenzione di trasformare il mondo, la globalizzazione appare come un fenomeno autopropulsivo, governato da forze anonime che nessuno controlla davvero. È il passaggio da ciò che scegliamo a ciò che semplicemente subiamo.
Il sociologo polacco lo esprime con chiarezza. La globalizzazione non riguarda ciò che vogliamo fare, ma ciò che ci sta accadendo. Non rimanda a iniziative pianificate, ma agli effetti globali di decisioni prese localmente, senza che nessuno disponga dei mezzi per guidarne le conseguenze. Non c’è un centro, non c’è una regia, non c’è un “consiglio di amministrazione” del mondo. Quello che c’è, invece, è una distesa sempre più vasta di caos.
Zygmunt Bauman riprende da Anthony Giddens l’immagine della “giungla costruita”. Non la natura indomita che l’uomo moderno si proponeva di addomesticare, ma il groviglio artificiale prodotto dallo stesso processo di civilizzazione. È una giungla che sovrasta, che sembra impossibile da attraversare e da dominare, dove le vecchie istituzioni, a partire dagli Stati, appaiono sempre più deboli, se non impotenti.
Ecco perché, per Bauman, la globalizzazione è il vero nome del “nuovo disordine mondiale” di cui parlava Jowitt. Dove la modernità sognava universalizzazione e ordine, noi ci ritroviamo con globalizzazione e disordine.
La crisi della sovranità statale
Lo Stato moderno era nato come garante dell’ordine. Per secoli aveva incarnato l’idea di poter trasformare il caos in regole, di custodire confini, identità e sicurezza. La sua forza si fondava su tre dimensioni: militare, economica e culturale.
Ma la globalizzazione ha incrinato questi pilastri. Nessuno Stato è più autosufficiente nella difesa, le economie dipendono da catene globali vulnerabili, le identità sono attraversate da flussi digitali che sfuggono a ogni controllo. La conseguenza è paradossale: gli Stati conservano il linguaggio e i simboli della sovranità, ma la loro capacità reale di governare i processi è sempre più limitata. È una sovranità che appare forte sulla scena politica, ma che dietro le quinte si rivela fragile.
Dal mondo degli Stati al mondo dei blocchi
Per gran parte del Novecento la scena globale non fu più dominata da singoli Stati, ma da grandi blocchi di potere. La Guerra Fredda costruì due poli contrapposti che esercitavano una sorta di meta-sovranità, coordinando e inglobando gli ordini nazionali all’interno delle rispettive sfere di influenza.
In questo contesto, il principio della piena sovranità statale cominciò a mostrare i suoi limiti. I tentativi di creare un “terzo polo”, come il movimento dei non allineati, venivano visti con sospetto e spesso soffocati. Anche in Africa, l’Organizzazione dell’Unità Africana sancì l’intangibilità dei confini coloniali pur riconoscendone l’artificialità, perché ormai l’obiettivo prioritario era garantire una stabilità minima.
Il risultato fu un ordine globale che non corrispondeva più alla somma di ordini nazionali autonomi, ma a una fragile architettura di blocchi, dentro i quali la sovranità dei singoli Stati veniva inevitabilmente ridimensionata.
Il paradosso del post-globalizzazione
Con la fine dei grandi blocchi, lo scenario mondiale è diventato ancora più contraddittorio. Da un lato, molti Stati hanno scelto volontariamente di cedere parti della loro sovranità a istituzioni sovranazionali, come l’Unione Europea o la NATO, nella consapevolezza di non poter più reggere da soli le sfide globali.
Dall’altro, assistiamo alla proliferazione di nuovi Stati minuscoli e fragili, nati spesso da spinte etniche o identitarie, che reclamano il diritto di sedere all’ONU con le stesse prerogative delle grandi potenze. Come osservava causticamente Eric Hobsbawm, il voto delle Seychelles finisce per pesare quanto quello del Giappone: è il trionfo formale della sovranità nel momento del suo declino sostanziale.
Ecco il paradosso: più la sovranità reale evapora, più cresce il desiderio di rivendicarla. Il mito dello Stato si rafforza proprio mentre la sua capacità di governare i processi globali si indebolisce.
Siamo nell’era dei Muri, dei sovranismi e delle crisi globali
Il mondo che abitiamo oggi porta i segni evidenti di quel paradosso. La globalizzazione, come fase storica, è alle spalle. Ciò che resta sono le sue conseguenze degenerative, che si riflettono in ogni angolo della vita politica ed economica.
Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente dimostrano che l’interdipendenza non ha portato alla pace promessa, ma a nuove fragilità. Le catene energetiche e alimentari, che avrebbero dovuto renderci più sicuri, si rivelano vulnerabili a ogni shock. La pandemia di Covid-19 ha mostrato l’impotenza degli Stati nel fronteggiare una crisi sanitaria planetaria, e la sfida climatica ricorda ogni giorno che i confini nazionali non fermano né tempeste, né siccità, né migrazioni ambientali.
Di fronte a questo scenario, molti governi rispondono con la promessa rassicurante del ritorno all’identità nazionale. Brexit, il “Make America Great Again”, la retorica dei muri e delle frontiere chiuse: sono tutte varianti di una sovranità teatrale. Una messinscena politica che offre l’illusione del controllo, mentre le forze che determinano davvero il destino delle società, finanza, tecnologia, clima, flussi migratori, restano irriducibilmente globali.
Questa chiusura identitaria, però, non risolve i problemi. Ma, li sposta e spesso li aggrava. Un virus non chiede il passaporto, il riscaldamento globale non si ferma ai confini, le piattaforme digitali non conoscono dogane. È il grande cortocircuito del nostro tempo: più i problemi sono globali, più le risposte politiche diventano locali, parziali, illusorie.
Universalizzazione: la via d’uscita dal caos
Bauman ci offre una lezione semplice e radicale: la globalizzazione sì è subita, l’universalizzazione si sceglie.
La globalizzazione è stato un processo cieco, fatto di effetti imprevisti, di forze anonime che hanno travolto Stati e istituzioni. Ma l’universalizzazione resta una possibilità: non più come imposizione di un modello unico, bensì come orizzonte di principi condivisi, capaci di dare senso e direzione a un mondo frammentato.
Significa tornare ad assumersi la responsabilità di “fare ordine su scala universale”. Non cancellando le differenze, ma iscrivendole dentro un disegno comune. Significa riconoscere che nessuno Stato può affrontare da solo la sfida climatica, le pandemie, l’intelligenza artificiale o i flussi migratori.
Universalizzare oggi vuol dire dotarsi di regole globali per governare le tecnologie che plasmano le nostre vite; costruire istituzioni planetarie per proteggere la salute pubblica e la dignità dei migranti; stringere alleanze che trasformino l’interdipendenza in solidarietà e non in fragilità.
Il nostro tempo, segnato dal post-globalizzazione, moltiplica muri e nazionalismi. Ma sono illusioni di protezione: dietro di esse il disordine cresce. La vera scelta è se rifugiarci nella nostalgia di sovranità ormai impraticabili, o avere il coraggio di una nuova universalizzazione.
Bauman ci ricorda che la modernità sognava un giardino universale e ha finito per costruire una giungla caotica. Sta a noi decidere se rimanere intrappolati tra i rovi o tornare a coltivare un orizzonte comune.
La globalizzazione ci ha travolti. Ma solo l’universalizzazione può salvarci. Grazie grande maestro Zygmunt Bauman per ciò che hai donato all’umanità.