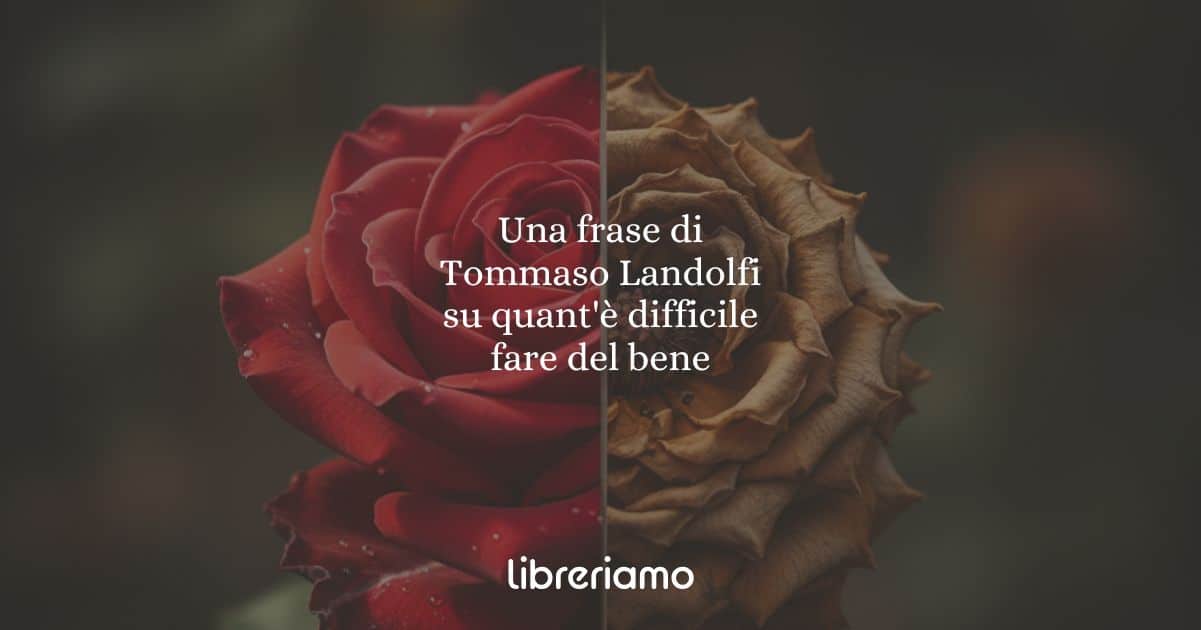Questa affermazione di Tommaso Landolfi (1908-1979) – scrittore, traduttore, intellettuale tra i più originali e appartati della letteratura italiana novecentesca – condensa in poche righe una visione etica radicalmente pessimista che merita di essere esplorata nelle sue implicazioni filosofiche, morali ed esistenziali. Landolfi ci pone davanti a un’impossibilità che è insieme logica ed etica: qualsiasi azione umana, anche quella apparentemente più innocua o benintenzionata, produce necessariamente danno a qualcuno. Se questo è vero, allora l’innocenza è impossibile, e siamo tutti condannati a una colpevolezza strutturale da cui non esiste via d’uscita.
“È possibile fare checchessia senza recar danno a qualcuno? Sfido chi si voglia a dimostrarlo possibile. Il nostro bene è dunque un male, quand’anche fosse il minore.”
Il contesto: “Des mois” e la scrittura diaristica
“Des mois” (1967) è uno dei diari frammentari di Landolfi, genere in cui lo scrittore pisano eccelse particolarmente. I suoi diari non sono confessioni intime o cronache quotidiane ma piuttosto meditazioni filosofiche, osservazioni sulla lingua e sulla letteratura, riflessioni amare sulla condizione umana. Sono scritti di un’intelligenza abrasiva, spesso misantropica, sempre lucidissima.
La frase in questione ha il tono tipico della scrittura diaristica landolfiana: parte da un interrogativo apparentemente semplice (“È possibile fare qualcosa senza danneggiare qualcuno?”), procede con una sfida retorica (“Sfido chiunque a dimostrare il contrario”), e conclude con una deduzione logica implacabile (“Il nostro bene è dunque un male”). È filosofia fatta con gli strumenti della lingua, non con sistemi elaborati.
La domanda radicale: l’impossibilità dell’azione innocua
“È possibile fare checchessia senza recar danno a qualcuno?” La domanda usa il termine arcaico “checchessia” (qualsiasi cosa, qualunque cosa) che conferisce al discorso un tono solenne, quasi giuridico. Non si chiede se sia possibile evitare danni in certe azioni specifiche, ma se esista anche una sola azione – “checchessia” – che non produca danno.
La risposta implicita è negativa: no, non è possibile. Qualsiasi cosa facciamo, qualcuno ne riceve danno. Questa è un’affermazione radicale che va contro l’intuizione comune. Tendiamo a pensare che molte nostre azioni siano neutre o positive, che non danneggino nessuno. Mangiare un panino, leggere un libro, fare una passeggiata – come potrebbero queste azioni danneggiare qualcuno?
Ma Landolfi ci invita a guardare più a fondo. Mangiare un panino significa che qualcun altro non lo mangerà (in un mondo di risorse finite). Leggere un libro significa dedicare tempo a quello invece che a un altro (danneggiando l’autore non letto). Fare una passeggiata significa occupare spazio, consumare suola delle scarpe prodotte da operai sfruttati, forse calpestare insetti. Estendendo l’analisi, ogni azione ha catene causali infinite di conseguenze, molte delle quali negative per qualcuno.
La sfida retorica: l’inversione dell’onere della prova
“Sfido chi si voglia a dimostrarlo possibile.” Questa sfida è un movimento retorico potente. Landolfi non si assume l’onere di dimostrare la sua tesi (che ogni azione danneggia qualcuno), ma sfida l’interlocutore a dimostrare il contrario. Inverte l’onere della prova.
È una strategia efficace perché dimostrare un’affermazione universale negativa (“non esiste alcuna azione che non danneggi nessuno”) è quasi impossibile, mentre confutarla richiederebbe solo un controesempio. Ma Landolfi è convinto che nessun controesempio reggente possa essere trovato. Ogni azione che ci sembra innocua, a un esame più attento, rivelerà qualche danno collaterale.
C’è qui un’eco dello scetticismo filosofico antico: la sospensione del giudizio davanti all’impossibilità di dimostrazioni definitive. Ma mentre lo scettico antico sospendeva il giudizio, Landolfi lo formula eccome: ogni azione danneggia. “Il nostro bene è dunque un male, quand’anche fosse il minore.” Questa è la conclusione, introdotta dal “dunque” che segnala inferenza logica. Se ogni azione danneggia qualcuno, allora anche le nostre azioni buone (quelle che ci procurano bene) sono necessariamente male per qualcun altro.
Il “nostro bene” – ciò che ci fa stare bene, ci avvantaggia, ci procura felicità – implica strutturalmente un male. Non è che potrebbe comportare un male (casualità), ma che necessariamente lo comporta. È un male mascherato da bene, o meglio, è insieme bene (per noi) e male (per altri).
La precisazione finale – “quand’anche fosse il minore” – introduce una sfumatura importante. Landolfi riconosce che esiste una gradazione: alcuni mali sono minori di altri. Non tutte le azioni dannose sono ugualmente dannose. Ma questo non cambia la sostanza: anche il male minore resta male. Non possiamo assolverci dicendo “ho scelto il male minore”, perché resta che abbiamo scelto un male.
Le implicazioni etiche: la colpevolezza universale
Se Landolfi ha ragione, le implicazioni etiche sono devastanti. Significherebbe che:
L’innocenza è impossibile: nessuno può agire senza produrre danno, quindi nessuno è innocente. Siamo tutti colpevoli per il solo fatto di esistere e agire.
L’imperativo morale diventa paradossale: “non fare del male” diventa un comando impossibile da seguire. Qualsiasi cosa facciamo (incluso il non agire, che è anch’esso una scelta con conseguenze) produce danno.
La responsabilità si espande all’infinito: se ogni nostra azione ha catene causali infinite di conseguenze dannose, siamo responsabili di mali che non possiamo nemmeno prevedere o controllare.
Il calcolo utilitarista diventa obbligatorio: se non possiamo evitare il male, possiamo al massimo scegliere il male minore. Ma questo ci condanna a un calcolo perpetuo e angoscioso delle conseguenze.
Il pessimismo radicale: Tommaso Landolfi e Leopardi
Il pessimismo di Landolfi ha echi leopardiani, ma con una curvatura etica particolare. Leopardi vedeva la natura come matrigna, fonte di sofferenza inevitabile. Landolfi aggiunge una dimensione morale: non solo soffriamo, ma facciamo soffrire, inevitabilmente, strutturalmente.
Questo pessimismo etico è più corrosivo di quello cosmico leopardiano perché ci rende non solo vittime ma anche carnefici. Non possiamo nemmeno consolarci pensando di essere innocenti sofferenti: siamo colpevoli sofferenti, produttori di male anche quando cerchiamo il bene.
La dimensione esistenziale: l’angoscia dell’agire
Al di là dell’etica teorica, c’è una dimensione esistenziale in questa riflessione. Se qualsiasi azione produce danno, l’atto stesso di vivere e agire diventa fonte di angoscia. Come possiamo agire sapendo che danneggeremo qualcuno?
Questa consapevolezza può portare a due esiti opposti:
Paralisi: se ogni azione è dannosa, meglio non agire. Ma anche il non agire è una scelta con conseguenze. Si finisce in una paralisi esistenziale.
Cinismo: se è impossibile evitare il male, tanto vale smettere di preoccuparsene. Diventa tutto equivalente. Ma questo porta all’abdicazione morale.
Landolfi stesso sembra oscillare tra questi poli, senza trovare una sintesi consolatoria. La sua scrittura testimonia questa angoscia dell’impossibilità dell’innocenza.
La riflessione di Landolfi si inserisce in una lunga tradizione filosofica che ha meditato sul male necessario, dal mito di Adamo (la conoscenza del bene e del male come caduta) a Dostoevskij (tutti siamo colpevoli di tutto), da Sartre (l’impossibilità di avere le mani pulite) a Hannah Arendt (la banalità del male).
Ma Landolfi radicalizza: non è che a volte dobbiamo fare del male per un bene maggiore (male necessario in senso classico), è che qualsiasi bene che facciamo è strutturalmente anche un male. Non c’è via d’uscita, non c’è redenzione possibile.
C’è però un possibile valore in questo pessimismo radicale: ci impedisce l’autocompiacimento morale. Se sappiamo che anche il nostro bene è un male per qualcuno, saremo più umili, meno giudicanti, più consapevoli della complessità morale dell’esistenza.
Non potremo più dividerci facilmente in buoni e cattivi. Dovremo riconoscere che tutti, anche i migliori, producono danno. Questo potrebbe generare più compassione, più comprensione delle debolezze altrui.
Ma è una saggezza amara, che non consola, che non redime. È la saggezza di chi ha guardato nell’abisso e ha visto che l’innocenza è solo un’illusione.
La frase di Landolfi ci lascia senza via d’uscita. Non offre soluzioni, non propone redenzioni. Semplicemente constata: qualsiasi cosa facciamo, danneggiamo qualcuno. Il nostro bene è un male.
Cosa fare con questa consapevolezza? Forse l’unica risposta è: continuare a vivere e agire, sapendo che saremo sempre in qualche misura colpevoli, cercando almeno di scegliere i mali minori, portando il peso di questa impossibile innocenza.
È una visione cupa, certamente. Ma ha la durezza della verità non edulcorata. E forse, nel riconoscimento onesto della nostra strutturale colpevolezza, c’è più autenticità che in tutte le illusioni di innocenza con cui normalmente ci confortiamo.
Landolfi ci toglie le consolazioni. E ci lascia soli con la domanda senza risposta: come vivere sapendo che il nostro bene è un male?