Una frase di René Magritte sulla scienza e sulla poesia
Leggiamo assieme questa citazione di René Magritte rilasciata a Maurice Bots il 2 luglio 1951, su progresso tecnologico e poesia.
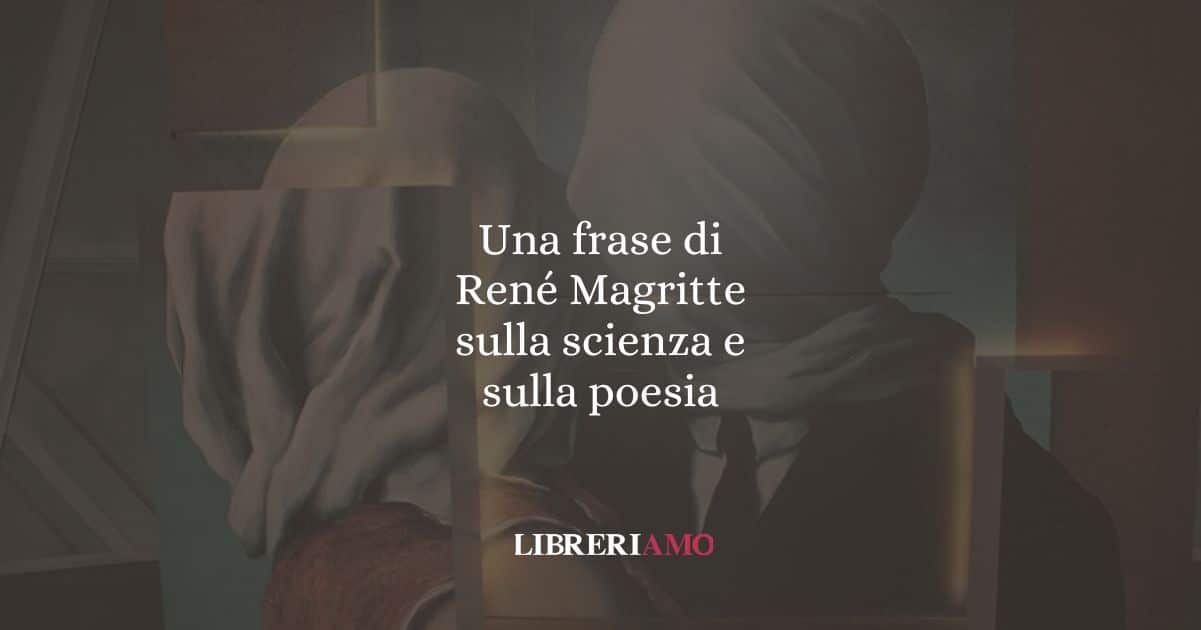
Con questa frase, pronunciata in un’intervista del 2 luglio 1951, René Magritte consegna una delle definizioni più sorprendenti e profonde della poesia e, più in generale, dell’esperienza artistica. Non una risposta, non un’analisi teorica, non una formula estetica, ma un’immagine: quella di uno studioso curvo sul suo microscopio, intento a penetrarne i segreti, e poi improvvisamente costretto ad arrestarsi davanti al limite estremo del visibile. È in quel punto, dice Magritte, che nasce la poesia. Per comprendere il significato pieno di questa affermazione bisogna entrare nel suo universo poetico, fatto di paradossi, di immagini sospese, di enigmi visivi che non cercano soluzioni ma generano domande.
«Uno studioso al microscopio vede molto più di noi. Ma c’è un momento, un punto, in cui anch’egli deve fermarsi. Ebbene, è a quel punto che per me comincia la poesia.»
René Magritte: arte che si fa poesia
René Magritte non parla solo di scienza: parla della condizione umana. L’uomo studia, indaga, osserva, tenta di capire. Il microscopio è metafora della volontà di conoscenza, dell’ansia di spiegazione che caratterizza il pensiero moderno. Ma nessuno strumento può condurre all’infinito. Nell’atto stesso del conoscere si produce una soglia, un punto cieco, un confine oltre il quale lo sguardo non può andare. Eppure, mentre per lo scienziato questo punto rappresenta un limite, per l’artista è un varco: ciò che non si può vedere diventa lo spazio dell’immaginazione.
La poesia, per Magritte, nasce dal limite. Non è ciò che si conosce, né ciò che si vede. È ciò che comincia dove l’occhio si arresta. È il regno dell’inesplicato, dell’ombra dietro l’oggetto, del mistero che ogni realtà porta con sé. La poesia non è un ornamento, non è una fuga dal reale; al contrario, è il movimento che svela la parte di realtà che gli strumenti di precisione non possono raggiungere.
Magritte, a differenza di altri surrealisti, non esplora l’inconscio come un territorio di caos esplosivo. Il suo surrealismo è un esercizio di precisione. Le sue immagini sono limpide, nitidissime, come osservate proprio attraverso un microscopio. Ma questa nitidezza non serve a definire: serve a incrinare. Magritte mette davanti ai nostri occhi oggetti perfettamente riconoscibili – una mela, una finestra, un cielo, un cappello a bombetta – e li colloca in situazioni logicamente impossibili: la mela che riempie una stanza, il treno che esce da un caminetto, la notte e il giorno che coesistono nella stessa piazza. L’immagine è precisa, ma la logica è sospesa.
Proprio come lo studioso al microscopio vede sempre più dettagli fino a un punto d’arresto, così lo spettatore di Magritte, osservando le sue opere, arriva a un momento in cui la realtà sembra perfettamente definita ma, allo stesso tempo, inspiegabile. La poesia nasce da questa tensione tra chiarezza visiva e oscurità concettuale.
Il mistero come dimensione della realtà
In Magritte la poesia coincide con il mistero, ma non nel senso di qualcosa di arcano o esoterico. Il mistero è una condizione ordinaria delle cose. È l’eccedenza del reale rispetto alle definizioni che tentiamo di dargli. Un oggetto non si esaurisce mai nella sua funzione, nel suo nome, nella sua utilità. Ogni cosa possiede una sua zona muta, un suo lato enigmatico, che emerge non appena lo si guarda con sufficiente intensità.
Per questo l’artista belga era ossessionato dal rapporto tra parola e immagine. Il quadro con scritto Ceci n’est pas une pipe è un esempio lampante: l’immagine è perfetta, la parola nega ciò che appare. È un invito a riconoscere che nessun sistema – né il linguaggio, né la percezione, né la scienza – può afferrare la totalità dell’essere.
La poesia inizia, dunque, in quella distanza che si apre tra ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere.
La frase di Magritte indica anche la funzione dell’arte: non spiegare il mondo, ma ampliarlo. Dove la scienza si ferma per necessità, l’arte si muove per libertà. Dove l’occhio si arresta davanti al limite fisico del microscopio, la mente poetica intravede possibilità. La poesia, in questo senso, non è evasione ma espansione: ci permette di percepire non ciò che è materialmente presente, ma ciò che è potenzialmente reale. Magritte non cerca risposte: cerca aperture. Le sue opere sono finestre che non si affacciano su un paesaggio, ma su una domanda.
C’è infine un messaggio di grande umiltà e, al tempo stesso, di enorme fiducia nella creatività umana. Dove si ferma la conoscenza comincia l’immaginazione: non come alternativa, ma come continuità. La poesia non interviene per riempire un vuoto, ma per riconoscere che il reale è sempre più grande delle sue spiegazioni.
La scienza ci dice “fin qui possiamo arrivare”; la poesia risponde “e ora comincia un’altra avventura”. La frase di Magritte è un invito a non considerare i limiti come fallimenti, ma come soglie: luoghi in cui si apre la possibilità dell’imprevisto.
In questo senso, l’arte di Magritte è un esercizio costante di attenzione al confine. Là dove il sapere si arresta, dove il microscopio non può più ingrandire, dove l’occhio non può più vedere, egli ci suggerisce di non rassegnarci, ma di ascoltare: perché proprio lì, in quel punto inafferrabile, comincia la poesia.