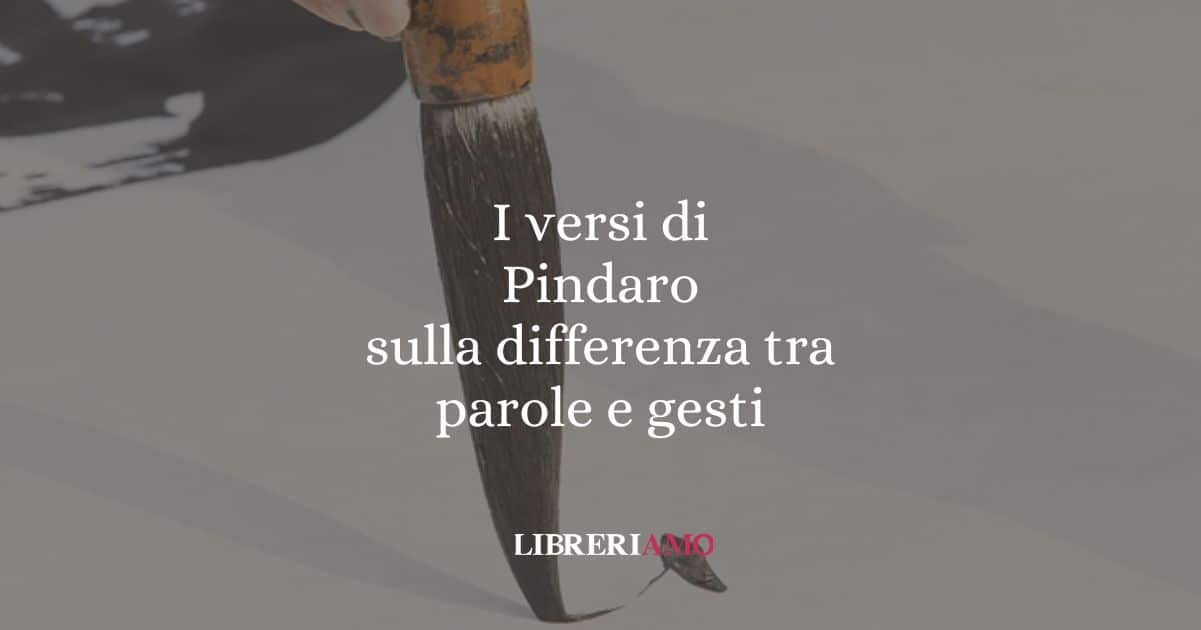Questi versi di Pindaro, tratti dalla Quarta Olimpica, ci portano al cuore di una concezione dell’uomo e della vita che affonda le radici nella cultura greca arcaica e che, al tempo stesso, parla ancora oggi con sorprendente attualità. La poesia pindarica, nata per celebrare le vittorie atletiche e gli eroi che le incarnavano, non si limitava a un elogio retorico: era anche occasione di riflessione morale, di ricerca di verità e di definizione di ciò che dà valore all’esistenza.
«Io non intingo le mie parole
nella menzogna; l’azione è la verifica di ogni uomo».
L’arte di Pindaro: tra mito e verità
Pindaro (518-438 a.C.) è forse il più grande poeta lirico greco, autore di odi celebrative che intrecciano mito, religione e attualità. Le sue parole non sono mai semplici ornamenti, ma cercano di innalzare il vincitore atletico a un livello quasi sacro, inserendolo in una rete di rimandi che uniscono gli dèi e gli uomini, il passato eroico e il presente.
Eppure, proprio in un contesto così intriso di simboli e immagini mitiche, Pindaro avverte l’urgenza di precisare: «Io non intingo le mie parole nella menzogna». Nonostante la poesia sia, per definizione, arte della parola, essa non deve cadere nella falsificazione. La poesia pindarica vuole essere verità poetica, non invenzione gratuita.
L’azione come verifica
La seconda parte del verso chiarisce ancora meglio questa prospettiva: «l’azione è la verifica di ogni uomo». Non bastano i discorsi, le narrazioni, le promesse: ciò che conta è l’azione concreta, la prova tangibile di ciò che si è. Questo principio affonda le radici nell’etica greca, per la quale la virtù (areté) non è una qualità astratta ma si dimostra nei fatti, in battaglia, nello sport, nelle scelte quotidiane.
Nell’atleta celebrato dalle odi, l’azione si manifesta nella vittoria olimpica, frutto di disciplina, forza e coraggio. Ma Pindaro ci invita a leggere questo principio in senso più universale: l’identità e il valore dell’uomo si rivelano sempre e solo attraverso ciò che egli fa.
Parola e azione: un equilibrio difficile
Il rapporto tra parola e azione, già nel mondo antico, è stato un nodo cruciale. I sofisti, contemporanei di Pindaro, attribuivano grande potere al linguaggio, capace di persuadere e di trasformare la realtà. Pindaro, invece, mette in guardia: le parole senza l’azione rischiano di scivolare nella menzogna. Non basta parlare bene, occorre agire bene.
Questa contrapposizione non significa svalutare la parola. Al contrario, Pindaro ne riconosce il valore, ma a condizione che essa sia ancorata a una realtà verificabile. La poesia non è allora un inganno, ma un mezzo per rendere eterno ciò che l’azione ha reso grande.
L’idea che l’uomo si definisca attraverso le azioni è un principio che attraversa tutta la filosofia e la letteratura occidentale. Aristotele, nella sua Etica Nicomachea, riprenderà il concetto affermando che la virtù non è un possesso, ma un atto costante. Molti secoli dopo, anche filosofi moderni come Kant sottolineeranno che ciò che conta è l’agire, più che l’intenzione dichiarata.
In questo senso, Pindaro anticipa una concezione etico-pratica dell’uomo: non esiste identità autentica senza la conferma dei fatti. Un uomo può dichiararsi giusto o coraggioso, ma sarà la sua condotta, non le sue parole, a testimoniarlo davvero.
Se spostiamo questa riflessione al presente, i versi di Pindaro acquistano un rilievo straordinario. Viviamo in un’epoca in cui la parola, soprattutto attraverso i media e i social network, sembra avere un potere quasi assoluto. Promesse, dichiarazioni, narrazioni personali e collettive si moltiplicano, spesso senza corrispondere a una realtà concreta.
In questo contesto, il monito pindarico risuona come un richiamo alla responsabilità dell’azione. Non basta dichiarare un impegno, bisogna dimostrarlo con i fatti. Non basta proclamare valori o ideali, occorre tradurli in comportamenti quotidiani.
L’uomo tra verità e menzogna
Il rifiuto di Pindaro di intingere le proprie parole nella menzogna è anche un atto di integrità poetica e morale. Significa affermare che la parola, se vuole avere valore, deve essere trasparente, deve rispecchiare la realtà. Non si tratta di rinunciare all’immaginazione poetica, ma di mantenere un legame profondo tra l’immagine e la verità dell’uomo.
Questa posizione mette Pindaro in una luce particolare rispetto a molti autori moderni che hanno fatto della finzione o della provocazione il centro della loro poetica. La sua è una poesia che celebra, ma che al tempo stesso educa, invitando a non dimenticare che ogni discorso trova la sua legittimità nell’azione.
La Quarta Olimpica di Pindaro, da cui provengono i versi in questione, è un testo che celebra una vittoria sportiva, ma il messaggio che ne emerge va ben oltre il contesto agonistico. L’idea che «l’azione è la verifica di ogni uomo» ci accompagna come una verità universale: l’essenza dell’uomo non si misura nei proclami, ma nelle scelte concrete, nella coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa.
In questo senso, Pindaro ci offre una lezione sempre attuale: la grandezza non risiede solo nella parola, ma nella parola che trova conferma nell’azione. E la menzogna non è altro che la distanza insanabile tra ciò che diciamo e ciò che compiamo.