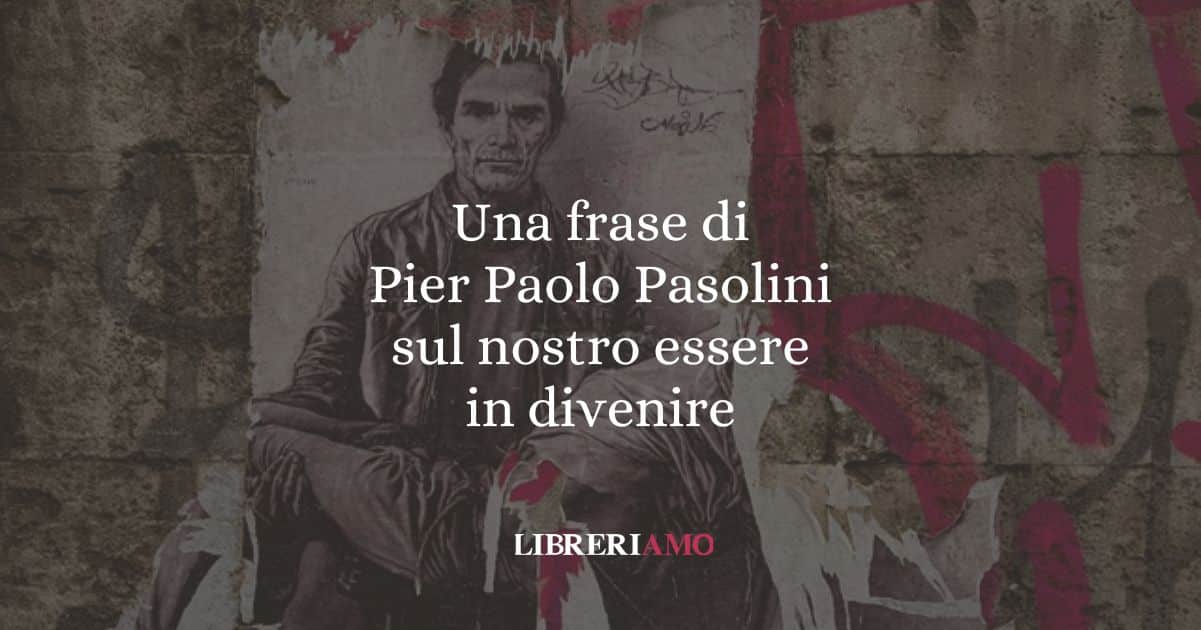La citazione di Pier Paolo Pasolini racchiude in poche righe una riflessione vertiginosa sull’identità, sul linguaggio e sulla comprensione dell’opera artistica e umana. È una frase che, come spesso accade in Pasolini, non può essere letta solo come una dichiarazione personale: è anche una teoria sul rapporto fra vita e linguaggio, fra autore e interpretazione, fra esperienza e senso.
«Finché io non sarò morto, nessuno potrà garantire di conoscermi veramente, cioè di potere dare un senso alla mia azione, che dunque, in quanto momento linguistico, è mal decifrabile»
In queste parole risuona la consapevolezza drammatica che ogni esistenza — tanto più quella di un artista — è un testo in divenire, un’opera incompiuta che solo la morte può chiudere e rendere interpretabile nella sua totalità. Finché l’autore è vivo, la sua vita continua a scrivere nuove pagine, a produrre nuovi segni, a modificare il significato di ciò che ha detto o fatto. La comprensione definitiva di un essere umano, e soprattutto di un autore, è dunque sempre differita, sospesa finché non si può osservare l’intero disegno.
Pier Paolo Pasolini e l’opera aperta
La frase di Pasolini sembra echeggiare un’idea che ha attraversato il pensiero novecentesco: quella dell’opera aperta, teorizzata da Umberto Eco negli stessi anni. L’opera d’arte, come la vita, non è un sistema chiuso, ma un processo di significazione continuo, che si trasforma insieme ai contesti, alle letture, alle interpretazioni. Pier Paolo Pasolini porta questa idea all’estremo, applicandola non solo al testo, ma alla persona stessa: “nessuno potrà garantire di conoscermi veramente”, dice, perché l’io — come il linguaggio — è un organismo in mutazione, mai fissato una volta per tutte.
In fondo, conoscere qualcuno significa dargli un senso, cioè interpretarlo. Ma per poter dare senso occorre disporre di un testo completo. E l’essere umano, finché vive, non smette di scrivere la propria opera: ogni gesto, ogni parola, ogni contraddizione aggiunge un nuovo capitolo. Solo la morte — quella “linea finale” che arresta il flusso — consente di chiudere il libro e di tentare una lettura complessiva.
Vita e linguaggio: l’azione come testo
Pier Paolo Pasolini parla della propria “azione” come di un momento linguistico. È un’affermazione densa e profondamente coerente con la sua poetica. Per lui, ogni atto — politico, poetico, umano — è linguaggio: un segno che comunica, una scrittura nel mondo. Il linguaggio, tuttavia, non è mai trasparente. Ogni segno può essere interpretato in più modi, ogni parola porta con sé ambiguità, allusioni, stratificazioni di senso.
Quando Pasolini afferma che la sua azione è “mal decifrabile”, riconosce l’impossibilità di separare la vita dall’interpretazione. Il suo impegno civile, la sua omosessualità vissuta come scandalo, la sua adesione a un marxismo eterodosso, la sua polemica contro la società dei consumi — tutto in lui è linguaggio, ma un linguaggio difficile, pieno di contraddizioni, di cortocircuiti, di verità che si negano a se stesse.
In questo senso, Pasolini è perfettamente consapevole del destino dei suoi interpreti: non si potrà mai capire davvero la sua opera finché la sua vita rimane aperta, e anche dopo la morte ogni lettura sarà parziale, limitata, condizionata dal tempo e dalle ideologie.
L’io come enigma
Dietro la frase di Pasolini si cela anche una riflessione sull’enigma dell’identità. L’io non è mai del tutto conoscibile, nemmeno a se stesso. La coscienza che parla è sempre mediata dal linguaggio, e il linguaggio, a sua volta, è uno strumento imperfetto, che traduce e tradisce. Pier Paolo Pasolini, che vedeva nel linguaggio la forma più alta ma anche più tragica dell’esperienza umana, sapeva che ogni parola è una maschera, un tentativo di rappresentare ciò che non si lascia dire pienamente.
Quando dice che la sua azione è “mal decifrabile”, non parla solo della difficoltà che altri hanno nel comprenderlo: riconosce anche la propria impossibilità di decifrarsi interamente. Finché viviamo, siamo immersi nel flusso delle nostre stesse contraddizioni. Solo la morte, fermando quel flusso, può dare alla vita una forma, un contorno, un’unità apparente.
L’autore e la sua morte
C’è in questa frase un’anticipazione del tema — reso celebre da Roland Barthes — della “morte dell’autore”. Ma Pasolini lo rovescia: per lui, l’autore deve morire per poter essere compreso, non per scomparire dal testo. La morte non dissolve l’autore, ma lo consegna finalmente all’interpretazione, rendendolo leggibile come totalità.
In questo senso, la sua riflessione è quasi profetica. La morte violenta di Pier Paolo Pasolini nel 1975 ha fatto esplodere la sua figura in mille interpretazioni: politico, martire, provocatore, visionario, poeta maledetto. Solo dopo la morte, il suo “testo vivente” è diventato leggibile, anche se mai del tutto decifrabile. Quella frase, pronunciata poco tempo prima della fine, suona oggi come una sinistra premonizione: solo la morte avrebbe potuto “chiudere” il suo linguaggio, fissarlo in una forma interpretabile.
Il senso come costruzione postuma
In definitiva, Pier Paolo Pasolini ci dice che il senso — della vita, dell’arte, dell’azione — non è mai un dato immediato, ma una costruzione retrospettiva. Lo capiamo solo dopo, guardando indietro. Ogni vita è un testo che scriviamo senza conoscere la fine; solo quando la fine arriva, le parti sembrano disporsi in un ordine, in una possibile coerenza.
Ma anche questa coerenza è un’illusione. Il senso è un effetto prodotto dal nostro bisogno di significato, non una realtà oggettiva. Così, nessuno potrà mai “garantire di conoscere veramente” Pier Paolo Pasolini, perché ogni interpretazione sarà un atto creativo, un gesto che aggiunge — anziché svelare — senso.