Una frase di Niccolò Machiavelli sul valore della gratitudine
Leggiamo assieme questa citazione di Niccolò Macchiavelli tratta da sedicesimo capitolo de “Il Principe”, sulla gratitudine e la sua importanza.
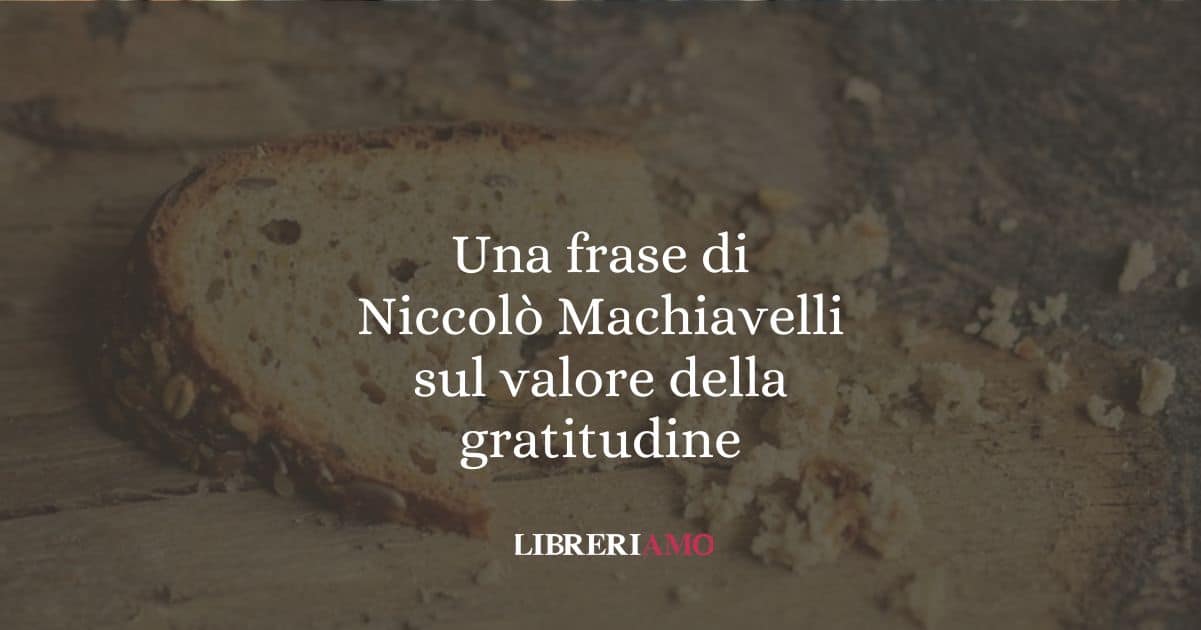
La riflessione di Niccolò Machiavelli sulla gratitudine vista attraverso il suo contrario, la liberalità, contenuta nel sedicesimo capitolo de Il Principe, appartiene a quelle massime politiche che hanno reso l’opera fiorentina una delle più discusse della modernità. Al cuore di questa citazione vi è una constatazione pratica, quasi economica, ma che si riflette direttamente sulla gestione del potere: la liberalità, ossia la generosità e l’elargizione di beni, non è virtù che si rinnova da sé, ma un capitale che si consuma. Se non governata con prudenza, essa conduce inevitabilmente alla rovina o all’odio dei sudditi.
«Non è cosa che consumi sé stessa quanto la liberalità; la quale mentre che tu usi, perdi la facoltà di usarla; e diventi o povero o contennendo [spregevole], o, per fuggire la povertà, rapace et odioso.»
Niccolò Machiavelli e la liberalità
Niccolò Machiavelli osserva che la liberalità ha in sé un carattere paradossale. Diversamente da altre virtù che possono crescere con l’esercizio — come il coraggio, la prudenza, la fedeltà — la generosità è vincolata alle risorse materiali di chi la pratica. Ogni dono, ogni concessione, ogni atto di larghezza comporta una spesa; e a lungo andare, il patrimonio del principe non può che ridursi. La liberalità, dunque, è una virtù “consumante”, che porta colui che la esercita a perdere la facoltà stessa di essere liberale.
In questo senso, Machiavelli rompe con una lunga tradizione etica e politica, che aveva esaltato la munificenza come segno di grandezza d’animo. Aristotele, nella Etica Nicomachea, aveva visto nella liberalità un giusto mezzo tra l’avarizia e la prodigalità. I trattatisti medievali l’avevano inserita tra le virtù regali, insieme alla clemenza e alla giustizia. Ma il segretario fiorentino ne denuncia i rischi: se esercitata senza calcolo, essa diventa causa di impoverimento e di perdita di autorità.
Le conseguenze politiche della generosità eccessiva
Machiavelli avverte che il principe troppo liberale ha davanti a sé tre strade, tutte negative. La prima è la povertà: spendendo oltre misura, egli non avrà più i mezzi per governare. La seconda è il disprezzo: un sovrano ridotto in miseria perde prestigio agli occhi dei sudditi e degli alleati, risultando incapace di mantenere il decoro del potere. La terza, la più pericolosa, è la rapacità: per sostenere le proprie elargizioni, il principe può ricorrere a nuove tasse, confische, o addirittura ruberie. In questo modo, da benefattore diventa oppressore, e da amato rischia di trasformarsi in odiato.
Il ragionamento machiavelliano, che può sembrare cinico, è in realtà profondamente realistico. La politica non si regge sui buoni sentimenti, ma sulla gestione delle risorse e dei rapporti di forza. Se la liberalità mette a rischio il bene supremo, che è la stabilità dello Stato, essa deve essere limitata o addirittura evitata.
Un aspetto interessante di questa riflessione è la distinzione implicita tra la generosità privata e quella pubblica. Come individuo, ciascuno può scegliere di essere liberale, di condividere i propri beni con gli altri, anche a costo della propria rovina. Ma un principe non governa per sé: governa per uno Stato, e dunque il suo patrimonio coincide con la sicurezza e la prosperità dei sudditi. La sua liberalità, se eccessiva, non danneggia solo lui, ma l’intera comunità.
Machiavelli suggerisce quindi una forma di parsimonia, che non è avarizia, ma calcolo politico. Essere troppo generosi nelle spese correnti o nei doni personali conduce alla rovina, mentre è lecito, e persino utile, mostrarsi liberali in circostanze straordinarie, ad esempio con i bottini di guerra o con ricchezze acquisite senza gravare sui cittadini.
Gratitudine e ingratitudine dei sudditi
La riflessione sulla liberalità si lega direttamente al tema della gratitudine, centrale per Machiavelli. Il principe che elargisce doni, favori, denaro, spera naturalmente di ottenere gratitudine. Ma qui il pensatore fiorentino smaschera un’altra illusione: la gratitudine non è un sentimento duraturo. Gli uomini, dice Machiavelli, sono più pronti a dimenticare i benefici ricevuti che i torti subiti. Di conseguenza, il prezzo della liberalità non trova quasi mai un adeguato ritorno.
Il principe liberale rischia quindi di dissipare le proprie risorse senza ottenere in cambio una fedeltà stabile. E quando, non potendo più mantenere quel ritmo di elargizioni, sarà costretto a interromperle, i sudditi lo abbandoneranno, mostrando che la loro devozione non era per lui, ma per i suoi doni.
L’attualità della riflessione
La lezione di Machiavelli mantiene una sorprendente attualità, non solo in politica, ma anche in economia e nelle relazioni sociali. Un leader, un imprenditore, persino un individuo nelle relazioni personali, sa bene che la generosità incontrollata può trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Se da un lato essa crea simpatia e consenso, dall’altro può alimentare aspettative impossibili da mantenere. Quando le risorse finiscono, resta solo il malcontento di chi non riceve più.
Pensiamo, ad esempio, ai governi che cercano consenso attraverso politiche di spesa sconsiderata: finché i fondi resistono, la popolarità cresce; ma quando giunge la crisi, il debito e le tasse trasformano la liberalità in fonte di rabbia sociale. Lo stesso vale nelle aziende: un manager che promette continuamente bonus e premi senza reali risorse rischia di perdere credibilità.
La massima di Machiavelli sulla liberalità, contenuta nel Principe, non è un invito all’avarizia, ma un monito alla misura. Il principe non deve dissipare le proprie risorse per guadagnarsi il favore dei sudditi, perché la gratitudine è labile e la povertà o la rapacità conducono alla rovina. Meglio mostrarsi parsimoniosi, ma solidi, che generosi e poi costretti a opprimere.
In queste parole si coglie l’essenza del pensiero machiavelliano: una politica non fondata sull’ideale astratto delle virtù tradizionali, ma sull’analisi concreta degli effetti. Il potere non si mantiene con la fama di generosità, ma con la capacità di governare le risorse, evitando di diventare poveri, spregevoli o odiati. Una lezione di sobrietà che, a distanza di cinque secoli, conserva intatta la sua forza.