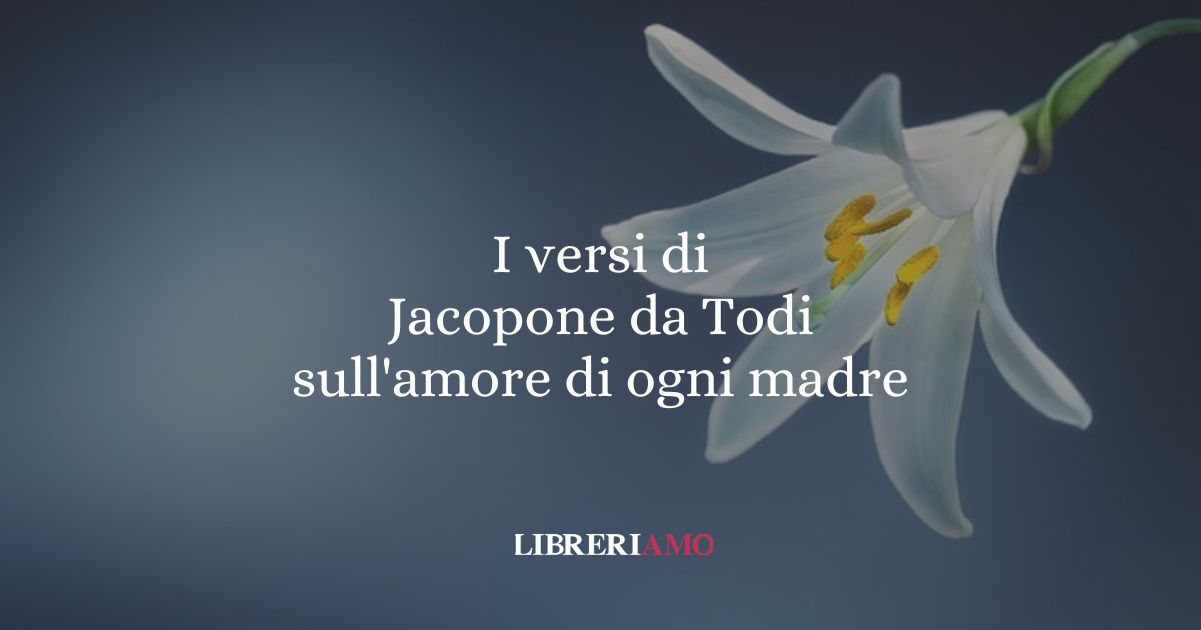Nella poesia medievale italiana vi sono testi che hanno la forza di un dramma teatrale, capaci di scuotere ancora oggi chi legge o ascolta. Tra questi si colloca il celebre Pianto della Madonna, meglio noto come Donna de paradiso, di Jacopone da Todi, uno dei massimi poeti religiosi del Duecento. Nei versi:
«O figlio, figlio, figlio,
figlio, amoroso giglio!
Figlio, chi dà consiglio
al cor mio angustiato?Figlio occhi iocundi,
figlio, co’ non respundi?
Figlio, perché t’ascundi
al petto o’ si’ lattato?»
si manifesta l’essenza più intima della poesia di Jacopone: l’unione fra devozione cristiana e sentimento umano, fra teologia e dramma.
Jacopone da Todi e il pianto della Madonna come dramma universale
Questi versi sono parte di un lamento che la Vergine Maria innalza davanti al Figlio crocifisso. Jacopone, con straordinaria capacità espressiva, non si limita a descrivere il dolore della Madre di Cristo in termini astratti o liturgici, ma lo rende immediatamente comprensibile e vicino, attraverso il linguaggio della quotidianità. Maria non è solo la Madre di Dio, è anche una madre che vede morire il proprio figlio e che si strazia nel non poterlo salvare.
Le ripetizioni insistite – “figlio, figlio, figlio” – hanno il valore di un grido, di una invocazione che cerca di trattenere la vita che sfugge. L’immagine del “figlio, amoroso giglio” associa la purezza del giglio, fiore mariano per eccellenza, alla dolcezza e fragilità del Cristo, ormai consumato dalla Passione.
Jacopone utilizza un linguaggio popolare, lontano dalla raffinatezza cortese, perché il suo intento non è rivolgersi a una ristretta élite, ma scuotere i cuori dei fedeli. Il Pianto ha infatti la struttura del “lauda drammatica”: una poesia religiosa che, per la sua costruzione dialogica e corale, poteva essere recitata o cantata nelle piazze e nelle confraternite.
L’umanità della Vergine è l’umani di ogni madre
Il valore più innovativo di questi versi è la rappresentazione di Maria non come una figura lontana, trionfante e gloriosa, ma come donna che soffre in carne e ossa. Il “cor mio angustiato” rivela una partecipazione tutta terrena: l’angoscia di chi ha dato la vita a un figlio e ora lo vede rifiutato, oltraggiato, ucciso.
Particolarmente toccante è la domanda: “Figlio, perché t’ascundi al petto o’ si’ lattato?”. Qui si intrecciano teologia e maternità biologica. La Madonna rievoca l’immagine dell’allattamento, cioè del legame fisico e corporeo che l’ha unita a Gesù bambino, e la contrappone al silenzio del Figlio ormai morente, che non può più rispondere al suo richiamo. In questa tensione tra il ricordo della vita e la realtà della morte, Jacopone tocca corde universali, capaci di emozionare ben oltre il contesto religioso.
Una rivoluzione poetica: il dolore al centro
Nel Medioevo, la poesia religiosa tendeva spesso a rappresentare Cristo come giudice o re glorioso, mentre Maria veniva descritta come regina dei cieli. Jacopone, invece, ribalta questa prospettiva: non il trionfo ma la sofferenza, non la distanza ma la vicinanza. Il dolore diventa il linguaggio con cui si esprime l’umanità della fede.
Il poeta umbro, che aveva scelto la via della povertà francescana dopo una vita mondana, conosceva bene il valore redentivo della sofferenza. Per lui, il dolore non è sterile, ma una via di conoscenza, un modo per partecipare al mistero divino. Così, la sofferenza della Vergine non è solo il racconto di un dramma familiare, ma il simbolo della partecipazione di tutta l’umanità al sacrificio del Cristo.
La forza drammatica delle domande
Questi versi sono costruiti come una sequenza di domande senza risposta: “Chi dà consiglio al cor mio angustiato?”, “Perché t’ascundi?”. Le domande rivelano lo smarrimento della madre, ma anche il silenzio tragico della croce. Non ci sono risposte, perché il mistero della morte e del dolore resta insondabile.
Il silenzio di Cristo non è però assenza, ma pienezza: Egli tace perché il suo sacrificio parla più di mille parole. Maria, con il suo lamento, diventa la voce di tutti coloro che cercano di dare un senso alla sofferenza e non trovano risposte.
Una poesia che parla al presente
Il fascino di Donna de Paradiso risiede nella sua universalità. Non è solo un testo religioso, ma un’opera che parla a chiunque abbia vissuto il dolore della perdita. La figura di Maria diventa archetipo della madre che piange il figlio, e il suo grido attraversa i secoli, trovando eco nella letteratura, nell’arte, nella musica sacra.
La sua attualità sta nel mostrare come la poesia possa dare voce alle emozioni più profonde, trasformando la sofferenza individuale in esperienza collettiva. Jacopone, con il suo linguaggio semplice e diretto, crea un ponte tra il XIII secolo e i lettori contemporanei, ricordando che, al di là delle differenze storiche e culturali, il dolore di una madre è un’esperienza universale.
I versi di Jacopone da Todi rappresentano un vertice della poesia religiosa medievale italiana. La ripetizione ossessiva del termine “figlio”, l’uso di immagini quotidiane come l’allattamento, la forza drammatica delle domande senza risposta, fanno del Donna de paradiso un testo straordinariamente moderno nella sua capacità di commuovere.
Attraverso il pianto di Maria, Jacopone ci mostra che la fede non è mai disgiunta dall’umanità, che il divino non esclude il dolore umano, ma lo assume e lo trasfigura. È in questa fusione tra maternità terrena e mistero della Passione che la poesia trova la sua forza, rendendo immortale il grido della Madre: «O figlio, figlio, figlio…».