I versi di Guido Gozzano sull’amore e il tempo che passa
Leggiamo assieme questi versi di Guido Gozzano tratti dalla sua poesia manifesto “La signora Felicita ovvero la Felicità”.
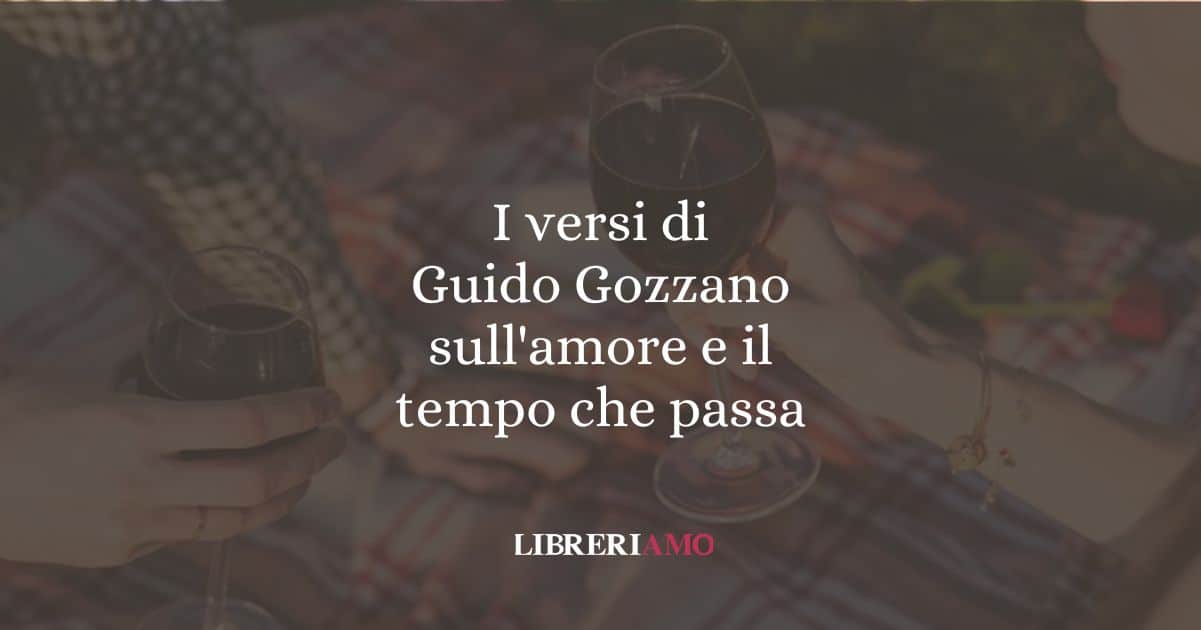
I versi di Guido Gozzano tratti da La signorina Felicita ovvero la Felicità rappresentano uno dei momenti più intensi e significativi della poesia crepuscolare italiana. In queste quattro linee, semplici nella forma e musicali nel ritmo, si racchiude il nucleo essenziale della poetica di Gozzano: la tensione costante tra la malinconia del tempo che scorre e la dolce illusione di una felicità possibile, incarnata nei piccoli gesti, negli affetti domestici e nei volti familiari.
“Vedevo questa vita che m’avanza:
chiudevo gli occhi nei presagi grevi;
aprivo gli occhi: tu mi sorridevi,
ed ecco rifioriva la speranza!”
Guido Gozzano e la signorina Felicita
La poesia La signorina Felicita è un capolavoro di equilibrio tra ironia e tenerezza, tra disincanto e nostalgia. Il poeta torinese, esponente di punta del movimento crepuscolare, osserva la vita con uno sguardo lucido e disilluso, ma allo stesso tempo profondamente umano. La “Signorina Felicita”, figura reale e simbolica insieme, rappresenta per lui l’ideale di un’esistenza semplice e serena, contrapposta alla vita inquieta e intellettualizzata della modernità.
Nel passo citato, la scena è di una semplicità quasi cinematografica: il poeta, sopraffatto dal senso del tempo che passa — “questa vita che m’avanza” —, chiude gli occhi come per difendersi dai “presagi grevi”, ossia dalle visioni oscure del futuro, dalle ansie, dai pensieri della morte e della vanità delle cose. Ma nel momento in cui li riapre, il sorriso della donna amata dissipa ogni oscurità, e la speranza torna a fiorire, come un fiore che sboccia dopo l’inverno.
È un’immagine di luminosa delicatezza: un sorriso diventa la forza vitale che sconfigge, almeno per un attimo, il senso del nulla. Nella struttura del testo, si nota il movimento alternato tra chiusura e apertura — chiudere gli occhi, aprirli —, che rispecchia il ritmo stesso della vita, oscillante tra paura e fiducia, tristezza e consolazione. Gozzano non descrive un gesto isolato, ma un ciclo emotivo, un meccanismo interiore che si rinnova ogni volta: il dolore, la fuga nell’immaginazione, il ritorno alla realtà, e in essa la riscoperta della speranza.
La figura femminile è qui centrale, ma non nel senso romantico o passionale. Non è l’oggetto di un desiderio sensuale o idealizzato; è, piuttosto, una presenza rassicurante, concreta, quasi domestica. In La signorina Felicita, la donna è ritratta come una “buona massaia”, con mani laboriose e gesti quotidiani. È l’antitesi della femme fatale decadente o della donna angelicata: rappresenta, invece, un ideale borghese di equilibrio, di calma, di normalità. Tuttavia, proprio in questa normalità Gozzano trova un barlume di verità e di consolazione.
Il sorriso di Felicita — quel sorriso che “rifiorisce la speranza” — non è dunque un segno di passione, ma un gesto di umanità. È la tenerezza che salva il poeta dal peso dell’esistenza. Nella sua apparente leggerezza, racchiude la possibilità di una grazia minima, fragile, ma necessaria. Il poeta, che avverte la precarietà della vita e la vanità delle aspirazioni, trova in quel sorriso un appiglio per continuare a sperare, pur sapendo che la speranza stessa è destinata a svanire.
Gozzano, come tutti i crepuscolari, avverte la fine di un mondo: quello dell’Ottocento idealista, eroico, fiducioso nel progresso e nella poesia come strumento di verità. Di fronte al nuovo secolo, dominato dal disincanto, dall’ironia e dal senso della fine, egli sceglie di rifugiarsi nei toni sommessi, nelle piccole cose, nei gesti quotidiani. Il suo sguardo è ironico, ma mai cinico: egli sa che la felicità è un’illusione, e tuttavia non rinuncia a cercarla.
Il lessico dei versi è volutamente semplice, quasi parlato: vedevo, chiudevo, aprivo, sorridevi. Questi verbi, all’indicativo, restituiscono la concretezza del gesto e la sincerità dell’esperienza. Non vi è nulla di artificioso o retorico. La musicalità del verso nasce dalla naturale alternanza dei suoni e dal ritmo ternario che accompagna l’azione: vedere, chiudere, aprire, sorridere. È come una piccola parabola della vita: la consapevolezza della morte (chiudere gli occhi) e la rinascita nella speranza (aprirli di nuovo al sorriso).
La “vita che m’avanza” è una metafora straordinariamente ambigua: da un lato indica il tempo che resta, il futuro che si avvicina inesorabile; dall’altro, la vita che “avanza” su di noi come un’onda o un esercito, minacciando di travolgerci. È l’immagine del tempo che consuma, della vecchiaia che incombe, della precarietà di ogni cosa umana. Di fronte a questo movimento inesorabile, il sorriso dell’amata non può fermare il tempo, ma può sospenderlo per un istante, può dare senso all’attimo presente.
In questa contrapposizione tra la vita che scorre e il sorriso che la addolcisce si gioca tutta la poetica gozzaniana: la coscienza del limite unita al desiderio di bellezza, la malinconia temperata dall’ironia, il pessimismo mitigato dalla dolcezza.
“Ed ecco rifioriva la speranza”: l’ultimo verso chiude il quartetto con una luce improvvisa, quasi miracolosa. È la speranza che non viene da grandi ideali o da promesse ultraterrene, ma da un gesto umano, da un sorriso quotidiano. È una speranza fragile, provvisoria, ma per questo autentica.
Gozzano ci insegna che la felicità non è un possesso, ma un riflesso: il bagliore di un sorriso che, per un attimo, illumina l’oscurità. E in quell’attimo — forse soltanto in quello — la vita, pur avanzando implacabile, smette di far paura.