Una frase di Gustave Flaubert sulla voglia di cambiamento
Leggiamo assieme questa citazione dell’immortale autore francese Gustave Flaubert, in cui lo scrittore vagheggia desideri di cambiamento.
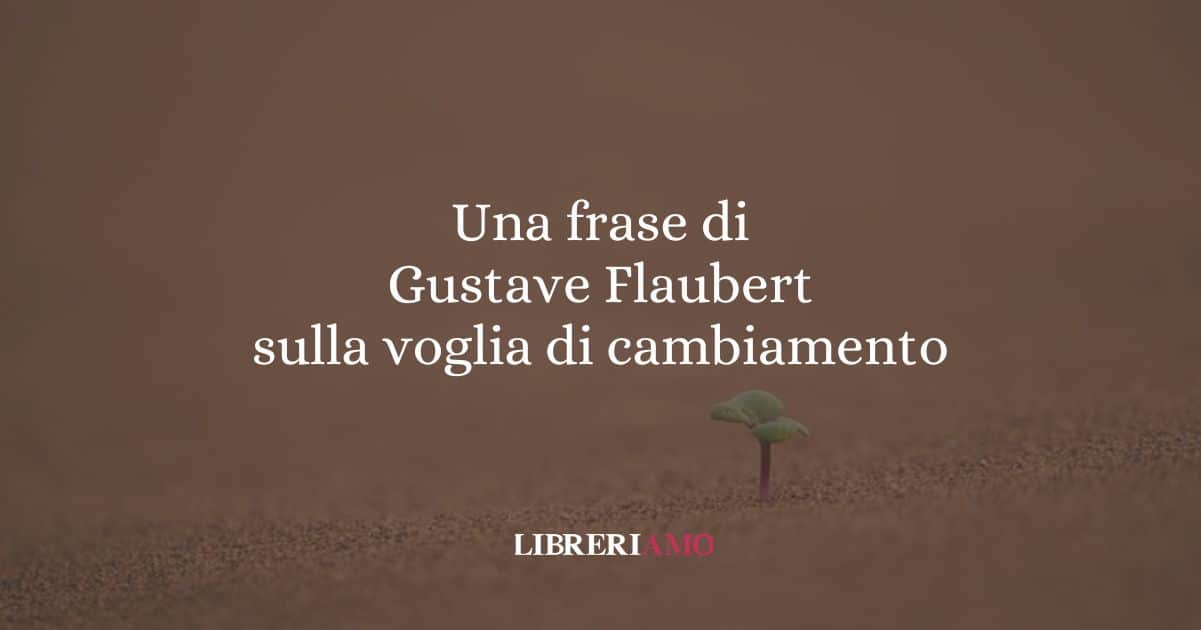
La citazione di Gustave Flaubert racchiude una delle tensioni più profonde dell’animo umano: il desiderio di fuga. In queste parole, che riecheggiano la malinconia e l’irrequietezza dell’autore francese, si coglie un impulso quasi vitale a rompere la ciclicità dell’abitudine, a liberarsi dal peso della ripetizione e a cercare altrove un significato, anche senza sapere dove.
“La foglia caduta si agita e vola al vento; così io vorrei volare, andarmene, partire per non tornare più, non importa dove, ma lasciare il mio paese; la mia casa mi pesa sulle spalle, sono entrato e uscito tante volte dalla stessa porta! Tante volte ho alzato gli occhi verso lo stesso posto, verso il soffitto della mia camera, che dovrebbe esserne consumato”
Gustave Flaubert e il desiderio di cambiamento
Flaubert, noto per la sua ossessione per la perfezione stilistica e per la sua sensibilità verso la noia borghese del suo tempo, riesce qui a trasformare un gesto naturale – il volo di una foglia – in una metafora universale della condizione umana. Come la foglia che, staccandosi dall’albero, si abbandona al vento senza sapere dove sarà portata, anche l’uomo desidera talvolta rinunciare al controllo, affidarsi all’imprevisto, uscire dal cerchio chiuso della propria quotidianità.
La casa, in questa prospettiva, diventa il simbolo più concreto della prigione dell’abitudine. “La mia casa mi pesa sulle spalle” – scrive Gustave Flaubert – e in questa immagine quasi fisica si avverte il senso di oppressione che nasce dal vivere troppo a lungo nello stesso luogo, tra le stesse mura, con gli stessi gesti. La ripetizione, per l’autore, non è solo una forma di monotonia: è un logoramento interiore. Il soffitto della camera, osservato mille volte, “dovrebbe esserne consumato”: è come se anche gli oggetti si stancassero dello sguardo, come se la realtà stessa diventasse fragile, corrosa dalla consuetudine.
In questa immagine della “foglia caduta”, il desiderio di fuga non si traduce in una vera speranza di libertà, ma in un sogno malinconico, quasi disperato. Gustave Flaubert non dice di voler partire verso un luogo preciso, ma “per non tornare più”. La fuga non è un viaggio verso qualcosa, ma una fuga da qualcosa: dal peso del noto, dalla ripetizione, forse persino da se stesso. È un impulso esistenziale che appartiene a chi sente troppo profondamente la stasi della vita.
L’autore di Madame Bovary conosce bene questa inquietudine. Emma Bovary stessa è una foglia in balia del vento: cerca di fuggire dal grigiore provinciale e dall’inerzia di un’esistenza mediocre attraverso l’amore, il lusso, la trasgressione. Ma la sua fuga è illusoria, destinata a schiantarsi contro la realtà. Anche Gustave Flaubert, attraverso di lei, racconta la difficoltà di conciliare il desiderio di movimento con l’impossibilità di sfuggire alla propria condizione. È forse questo il nucleo più amaro della citazione: la consapevolezza che, per quanto si desideri volare, la radice resta, invisibile, ma tenace.
Il soffitto della camera, simbolo della ripetizione, rappresenta anche il limite della percezione. Guardarlo “tante volte” significa misurare il tempo attraverso ciò che non cambia. È l’immobilità che fa ammalare l’anima, quella che Flaubert – come altri autori dell’Ottocento, da Baudelaire a Leopardi – sente come una condanna. La noia, o spleen, diventa allora la cifra di una generazione che, pur avendo raggiunto il progresso, l’ordine, la civiltà, si scopre svuotata di senso.
In questa tensione tra il desiderio di partire e l’impossibilità di farlo davvero, si manifesta anche una riflessione più profonda sul rapporto tra individuo e luogo. Il “paese” che l’autore vuole lasciare non è solo uno spazio geografico, ma una metafora della propria identità, delle convenzioni sociali e culturali che imprigionano. L’aspirazione a “volare via” diventa allora un gesto di ribellione, un rifiuto dell’omologazione. Ma, come spesso accade in Flaubert, questa ribellione resta confinata nell’immaginazione, in una dimensione interiore che non si traduce mai in azione concreta.
Il vento che muove la foglia non è solo simbolo di libertà: è anche simbolo del tempo. La foglia vola perché il suo ciclo vitale è compiuto, e in questo volo c’è un’ombra di morte. Anche l’uomo che desidera partire “per non tornare più” sembra sentire che ogni cambiamento autentico implica una perdita, una fine. Gustave Flaubert ci ricorda che il desiderio di altrove è spesso un modo per misurare la distanza tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, tra la vita vissuta e quella sognata.
Così, dietro il sogno del volo si nasconde la malinconia dell’impossibile. La fuga rimane un atto mentale, una fantasia che consola e tortura insieme. E tuttavia, proprio in questa tensione – nel voler “andarsene” pur restando – si rivela la grandezza dell’animo umano: la capacità di immaginare, di desiderare, di sentire che esiste sempre un altrove, anche se inafferrabile.
La foglia che cade e si lascia portare dal vento, allora, diventa emblema dell’uomo moderno, sospeso tra l’inquietudine e la speranza. Non c’è direzione certa, non c’è approdo sicuro: ma c’è, in quel gesto di abbandono, la più autentica forma di libertà che Gustave Flaubert potesse immaginare.