I versi di Giovanni Pascoli che ricordano la forza della speranza
Leggiamo questi versi di Giovanni Pascoli, che compongono le prime due strofe della poesia “Povero Dono”, testo cupo con una luce in fondo.
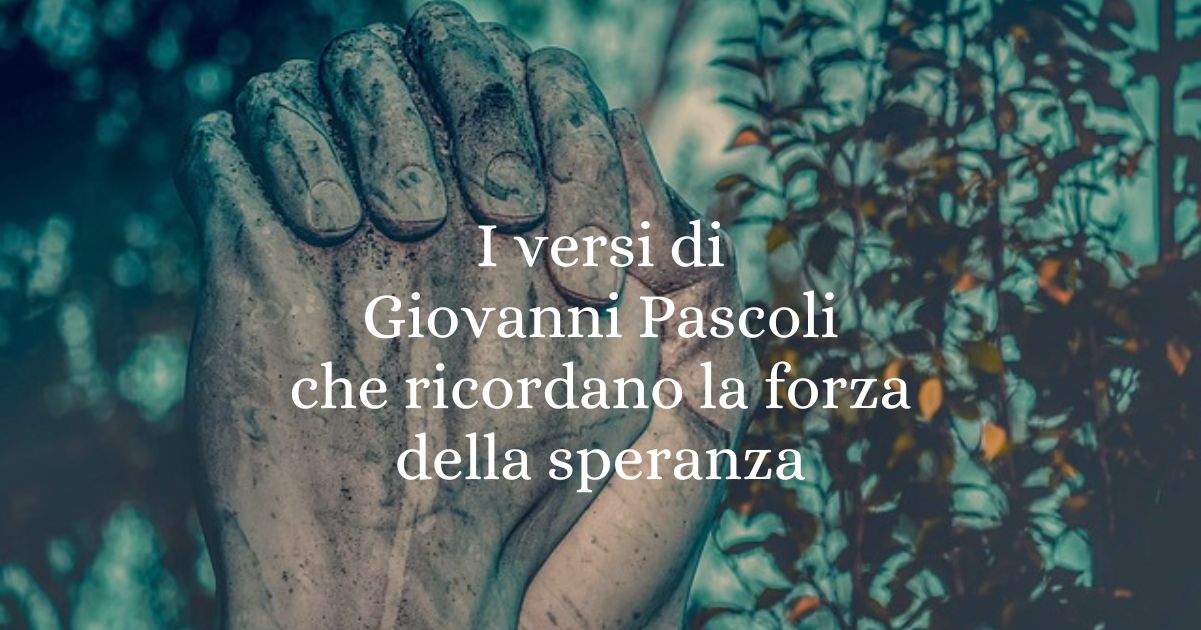
Con questi versi d’esordio del madrigale Povero dono, Giovanni Pascoli ci introduce in un’atmosfera di tensione interiore e di lotta spirituale, oscillante tra la tentazione della fine e un richiamo alla speranza. Siamo nel cuore di una delle tematiche più profonde e dolorose della poetica pascoliana: quella del suicidio come esito di un dolore insopportabile, ma anche della resistenza spirituale che nasce da una voce, da un ricordo, da un legame affettivo che trascende la morte.
Getta quell’arma che t’incanta. Spera
l’ultima volta. Aspetta ancora, aspetta
che il gallo canti per la città nera.Il gallo canta, fuggono le larve.
Fuggirà, fuggirà la maledetta
maga che con fatali occhi t’apparve.
Giovanni Pascoli e la speranza oltre la disperazione e la morte
Composta nel 1895 e pubblicata in occasione delle nozze Bemporad-Padovano, Povero dono entrò poi a far parte della raccolta Myricae nella sezione del 1897 (MY497). Il componimento è strutturato in forma di madrigale, ovvero una composizione lirica breve in endecasillabi che nella forma scelta da Pascoli segue lo schema metrico ABA, CBC, DEDE. I versi sono attraversati da un raffinato gioco di assonanze e allitterazioni, strumenti retorici che sostengono la tensione emotiva e rafforzano la musicalità del testo. Il suono e il senso si fondono in una poesia che è al contempo confessione intima e invito morale.
La poesia si apre con un imperativo carico di urgenza: «Getta quell’arma che t’incanta.» L’arma, simbolo della morte volontaria, esercita un fascino oscuro, quasi magico, sul soggetto lirico. È una seduzione mortale, che rispecchia lo stato psicologico di chi contempla il suicidio come via d’uscita dal dolore. Il verbo “incanta” non è casuale: richiama il potere stregonesco della disperazione, come se l’arma fosse essa stessa una maga, una presenza malefica che irretisce l’anima sofferente.
Segue un’esortazione che diventa una preghiera laica: «Spera / l’ultima volta. Aspetta ancora, aspetta…» La ripetizione del verbo “aspettare” dilata il tempo, sospende il gesto estremo. È il tempo dell’attesa del miracolo, dell’intervento salvifico, e anche del possibile cambiamento. Il poeta invoca un barlume, un segnale: «che il gallo canti per la città nera.» L’immagine del gallo evoca immediatamente il rinnegamento di Pietro e, insieme, la possibilità del pentimento e della redenzione. Il canto del gallo, simbolo della rinascita del giorno, irrompe nella “città nera” — simbolo della notte, del lutto, della morte — come un’eco di resurrezione.
La seconda terzina prosegue sul medesimo registro visionario: «Il gallo canta, fuggono le larve. / Fuggirà, fuggirà la maledetta / maga che con fatali occhi t’apparve.» La ripetizione del verbo “fuggire” segna un momento catartico: come la luce dell’alba scaccia le ombre, così il canto del gallo allontana le “larve”, ovvero i fantasmi interiori, i pensieri cupi, le presenze demoniache della mente. E infine, fugge anche la “maga”, figura emblematica del male, colei che “apparve” con occhi “fatali”, cioè destinati a condurre alla fine. Si tratta di una personificazione della tentazione, del dolore travestito da seduzione, di un’idea di morte che si traveste da sollievo.
Tutto questo ha un profondo risvolto autobiografico. Giovanni Pascoli stesso, in una sua confessione contenuta nei Carmina (CC La voce, vv. 37-48), racconta una notte passata in carcere, durante la quale fu sul punto di togliersi la vita: «agli uomini, la mia vita, / volevo lasciargliela lì…». Ma proprio in quel momento, sentì una voce smarrita, un soffio che lo chiamava: “Zvanî…” — il suo nome infantile in dialetto romagnolo. Era la voce della madre morta, che lo salvò da un gesto irreparabile. Questa memoria riemerge in “Povero dono”, sia nell’immagine del gallo che canta — segno di un ritorno alla coscienza — sia nella fuga della maga, ovvero della disperazione.
Nella quartina finale, che qui non è riportata integralmente ma che chiude il madrigale, Giovanni Pascoli intensifica il tono elegiaco con allitterazioni e giochi fonici (tra cui “Madre, morta, mesto, mormorìo”) e con un suggestivo uso dell’annominatio tra prece e pregherà, che rafforza il legame tra la memoria della madre e il gesto salvifico della preghiera. La madre morta, nel suo silenzioso mormorio notturno, diventa figura protettrice, simbolo di un amore eterno che resiste al nulla e alla disperazione.
La luce della speranza
In conclusione, “Povero dono” non è solo un breve componimento in versi: è una testimonianza di lotta interiore, un frammento lirico che contiene l’eco di una crisi esistenziale autentica, vissuta dal poeta e trasfigurata in simboli universali. Il “povero dono” a cui si allude nel titolo può essere la vita stessa, fragile, dolorosa, ma ancora degna di essere sperata e custodita. In un mondo che spesso spinge verso il buio, Giovanni Pascoli invita ad attendere il gallo, ad ascoltare la voce che chiama nel silenzio. Anche nella “città nera” dell’anima, un canto può ancora annunciare la salvezza.