Una frase di Gianni Rodari sul valore dell’immaginazione
Leggiamo questa citazione di Gianni Rodari tratta da “Grammatica della fantasia” in cui lo scrittore fa comprendere il valore dell’immaginazione.
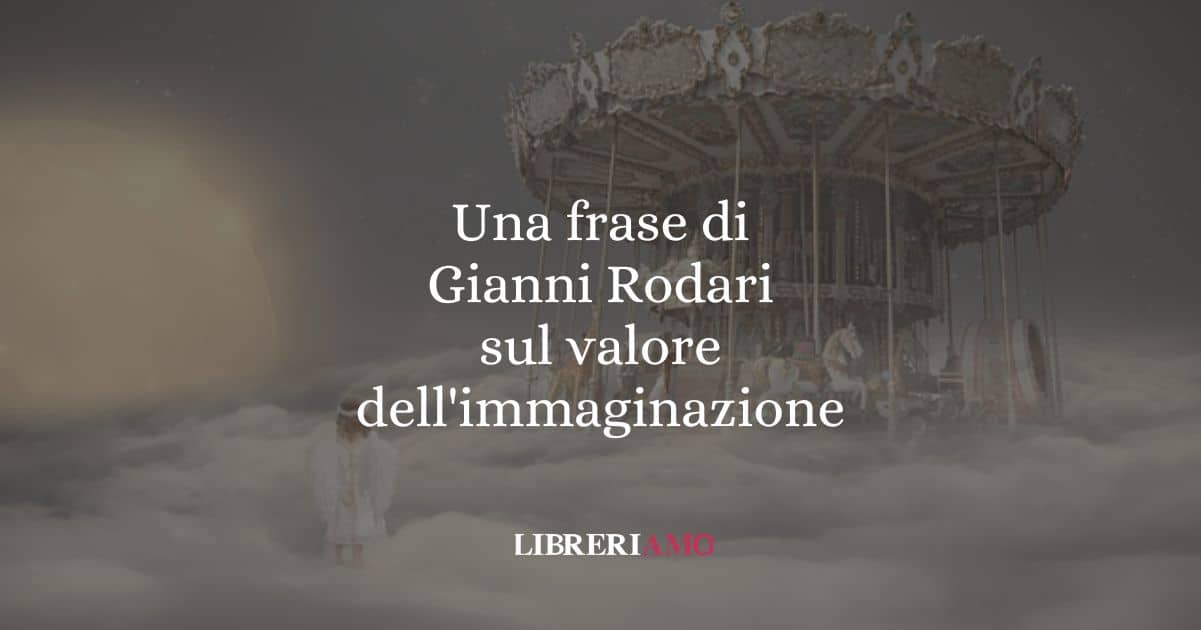
Gianni Rodari, nel suo capolavoro Grammatica della fantasia (1973), offre una delle più lucide e rivoluzionarie riflessioni sull’importanza dell’immaginazione nell’educazione e nella formazione umana. La sua celebre affermazione è una dichiarazione di poetica e, al tempo stesso, un manifesto pedagogico. In essa Rodari afferma che la fantasia non è un lusso della mente infantile, né un semplice svago, ma una forma di conoscenza e di pensiero che attraversa tutte le discipline, dalla matematica alla politica, dalla poesia all’etica.
“L’immaginazione del bambino, stimolata a inventare parole, applicherà ai suoi strumenti su tutti i tratti dell’esperienza che sfideranno il suo intervento creativo. Le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe. Servono alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno politico: insomma, all’uomo intero, e non solo al fantasticatore”
Gianni Rodari e l’immaginazione
Rodari parte da una convinzione fondamentale: l’immaginazione è una facoltà cognitiva, non un’attività marginale. L’atto di inventare parole, di creare fiabe o di costruire mondi simbolici è per il bambino — e, idealmente, per ogni uomo — un modo per esplorare la realtà, per comprenderla e trasformarla. Quando un bambino “inventa parole”, non gioca semplicemente con i suoni: esercita la mente, stabilisce relazioni, costruisce analogie, mette in atto un ragionamento creativo.
Rodari, da profondo conoscitore del linguaggio, sa che la parola è uno strumento di pensiero: cambiare le parole significa cambiare la percezione del mondo. Se l’immaginazione è stimolata, essa si estende a “tutti i tratti dell’esperienza” — vale a dire, a ogni ambito della conoscenza e della vita. La fantasia, dunque, non è confinata alla sfera artistica: è un principio universale di invenzione, capace di intervenire ovunque vi sia un problema da risolvere o un limite da superare.
Le fiabe e la matematica
Una delle intuizioni più sorprendenti di Rodari è l’affermazione che “le fiabe servono alla matematica come la matematica serve alle fiabe”. Dietro questa formula poetica si nasconde un’idea profondamente moderna: la fantasia e la logica non sono opposti, ma complementari. Le fiabe, infatti, allenano alla costruzione di nessi, alla coerenza interna, alla previsione di conseguenze: in fondo, raccontare una fiaba significa organizzare il pensiero in una sequenza ordinata di cause ed effetti, di ipotesi e di soluzioni.
Analogamente, la matematica — che può sembrare distante dal mondo del racconto — è una forma di immaginazione rigorosa. Essa si basa su un linguaggio simbolico, su strutture mentali che inventano mondi astratti, popolati da numeri e funzioni, ma non meno fantastici delle terre incantate di un racconto. Rodari invita così a superare le separazioni rigide tra le “materie umanistiche” e quelle “scientifiche”: entrambe, se vissute come esperienze di scoperta, si nutrono di curiosità, di ipotesi, di invenzione.
La fantasia come strumento di libertà
Nel pensiero di Rodari, la fantasia non è solo un esercizio mentale, ma anche un atto politico. Quando egli scrive che le fiabe servono “alla poesia, alla musica, all’utopia, all’impegno politico”, sta affermando che la creatività è una forma di libertà. Chi sa immaginare può anche concepire un mondo diverso, più giusto, più umano. L’immaginazione diventa allora il primo passo verso la trasformazione sociale: è ciò che permette di non accettare la realtà come immutabile.
Rodari, che ha vissuto gli anni difficili del dopoguerra e del dibattito pedagogico del Novecento, vede nella scuola un luogo in cui la fantasia deve essere educata, non repressa. In una società che tende a premiare la ripetizione e la conformità, egli propone una scuola che stimoli la creatività, l’invenzione linguistica, la capacità di porre domande. La “grammatica della fantasia” non è un metodo per creare artisti, ma per formare cittadini capaci di pensare criticamente.
Il valore delle parole inventate
Nell’immagine del bambino che “inventa parole” si condensa la poetica di Rodari. L’invenzione linguistica non è solo un gioco: è un modo per appropriarsi del mondo. Quando il bambino inventa una parola, egli afferma un diritto fondamentale: il diritto di nominare, di dare forma alla realtà secondo la propria sensibilità. Questo processo è profondamente umano, perché è attraverso il linguaggio che costruiamo la nostra identità e il nostro rapporto con gli altri.
Rodari sapeva che il linguaggio dei bambini è pieno di errori, di deformazioni, di parole buffe e meravigliose. Ma in quegli “errori” egli vedeva la prova di una mente viva, capace di sperimentare. Come un piccolo scienziato, il bambino verifica ipotesi, combina suoni, prova significati. L’adulto dovrebbe imparare da quella libertà: l’educazione linguistica non dovrebbe reprimere, ma guidare quella energia creativa.L’uomo intero
La chiusa della citazione — “Servono all’uomo intero, e non solo al fantasticatore” — è forse la più profonda. Con essa Rodari supera definitivamente l’idea romantica del “fantastico” come territorio separato dalla vita quotidiana. La fantasia non appartiene solo agli artisti o ai sognatori, ma a ogni uomo che voglia vivere pienamente. È un elemento costitutivo della nostra umanità, una risorsa che ci permette di affrontare la complessità del mondo.
Nel bambino, la fantasia è spontanea; nell’adulto, deve essere riconquistata. Ma in entrambi i casi essa è la chiave per tenere insieme i diversi aspetti dell’esperienza: logica e intuizione, scienza e arte, ragione e sentimento.
Gianni Rodari, con la Grammatica della fantasia, ci consegna una visione dell’immaginazione come forza unificante e conoscitiva. Le sue parole invitano a vedere nella creatività non una fuga, ma un modo di abitare la realtà in modo più profondo e libero.