I versi di Georg Trakl sul lento declinare dell’estate
Leggiamo assieme questi versi del poeta espressionista austriaco Georg Trakl tanto amato da Martin Heidegger, sul declinare dell’estate.
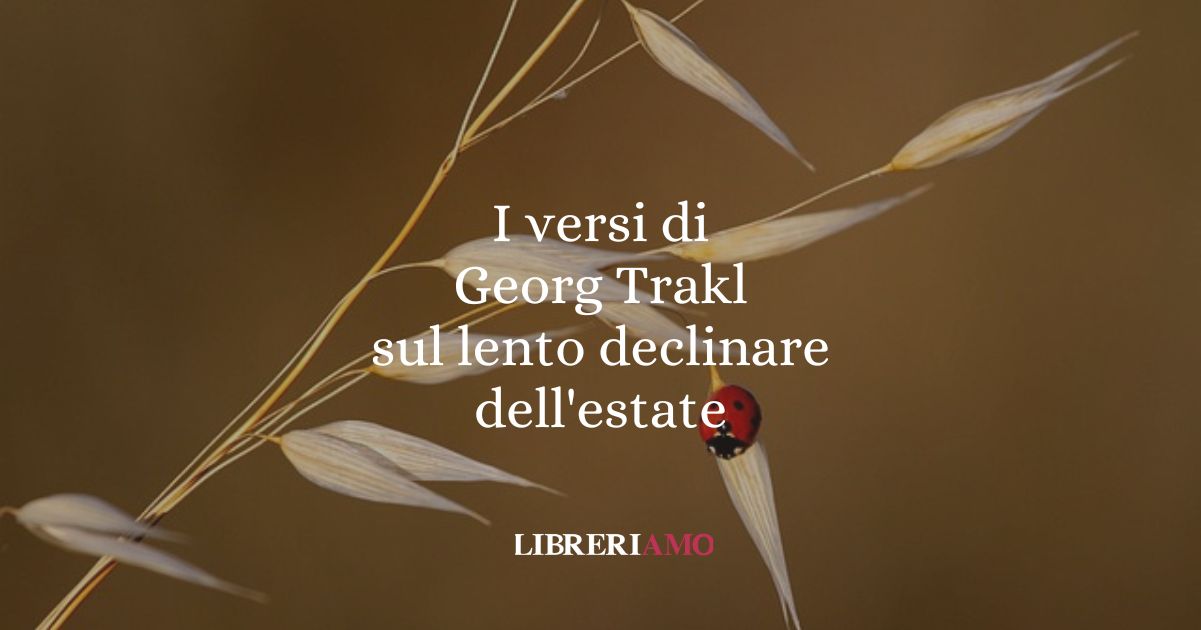
I versi di Georg Trakl tratti dalla poesia Declino dell’estate costituiscono una delle pagine più intense della lirica europea del primo Novecento. Essi recitano:
«La verde estate si è fatta
così lieve, il tuo cristallino volto.
Allo stagno serale morirono i fiori,
l’atterrito richiamo del merlo.Inutile speranza della vita. Già si prepara
la rondine al viaggio nella casa
e il sole affonda dietro la collina;
già accenna la notte al viaggio delle stelle.»
Questi versi, impregnati di malinconia e di un simbolismo delicato, racchiudono il senso tragico e insieme visionario della poesia di Trakl, capace di trasformare immagini naturali in allegorie esistenziali. La fine dell’estate diventa, infatti, un segno del tempo che scivola verso la decadenza, della vita che si consuma, del passaggio inevitabile verso il buio.
Georg Trakl e l’estate che svanisce
La poesia si apre con un’immagine di dissolvenza: «La verde estate si è fatta / così lieve, il tuo cristallino volto.» L’estate, con la sua pienezza vitale, non scompare bruscamente, ma diventa “lieve”, impalpabile, quasi trasparente. Il parallelismo con il “cristallino volto” suggerisce la fragilità di ciò che è bello e luminoso: come un cristallo, può riflettere la luce ma è anche pronto a infrangersi.
In Trakl, la natura non è mai soltanto sfondo, ma specchio dell’anima. La stagione che si chiude diventa metafora della giovinezza che svanisce, della vitalità che si attenua, della vita stessa che si avvia a un destino di declino.
Lo stagno serale e la morte dei fiori
La seconda immagine introduce un tono più cupo: «Allo stagno serale morirono i fiori, / l’atterrito richiamo del merlo.» Lo stagno, già di per sé simbolo di quiete stagnante, di immobilità malinconica, diventa il luogo in cui la bellezza si spegne. I fiori, che rappresentano la freschezza della vita, muoiono; e il richiamo del merlo, uccello solitamente associato al canto, non è un suono gioioso ma un grido “atterrito”, che comunica paura e smarrimento.
Qui emerge un tratto tipico della poesia di Trakl: la natura non consola, ma partecipa all’angoscia esistenziale. Ogni elemento naturale si tinge di inquietudine, si piega a un simbolismo che richiama la precarietà dell’esistenza umana.
L’inutile speranza della vita
La terza strofa si apre con un’affermazione drastica: «Inutile speranza della vita.» Non vi è più spazio per illusioni: la vita stessa appare priva di senso, perché inevitabilmente destinata alla fine. Questa disillusione radicale, che percorre gran parte della produzione di Trakl, riflette il clima culturale del primo Novecento, segnato da crisi, guerre imminenti e smarrimento spirituale.
L’aggettivo “inutile” accentua il tono tragico: non è soltanto che la speranza è fragile o illusoria, ma è del tutto vana. La caducità che colpisce l’estate e i fiori si estende all’esistenza umana, privata di qualsiasi appiglio duraturo.
La rondine e il viaggio
Eppure, in mezzo a questa disperazione, compare l’immagine della rondine: «Già si prepara / la rondine al viaggio nella casa.» Le rondini, simbolo di migrazione ciclica, evocano il movimento e il ritorno, ma anche la precarietà: esse abbandonano i luoghi abituali per seguire il richiamo delle stagioni.
Il termine “casa” introduce un’eco di intimità, di rifugio, ma non spegne l’idea del distacco. La vita, come la rondine, è sempre in viaggio: non conosce stasi, ma un continuo andare e tornare, che tuttavia non risolve la domanda di senso.
Il tramonto del sole e la notte che avanza
La poesia si chiude con due immagini potenti: «E il sole affonda dietro la collina; / già accenna la notte al viaggio delle stelle.» L’affondare del sole non è un semplice tramonto, ma un gesto che richiama la caduta, la fine, quasi una scomparsa definitiva.
Subito dopo, la notte si annuncia come viaggiatrice delle stelle. L’oscurità, dunque, non è vuota: porta con sé il movimento cosmico, il silenzio in cui brillano le costellazioni. Ma anche qui la bellezza è intrisa di malinconia: le stelle sono lontane, irraggiungibili, e la loro comparsa segna la vittoria della notte sulla luce.
Declino naturale e declino interiore
L’intera poesia può essere letta come un’allegoria del declino interiore dell’uomo moderno. L’estate che svanisce non è soltanto la stagione naturale, ma anche la stagione della vita, della speranza, della giovinezza. L’autunno che incombe e la notte che avanza incarnano invece la decadenza, la perdita di significato, l’approssimarsi della morte.
In questo senso, Trakl si inserisce pienamente nella sensibilità simbolista e decadente europea, in cui la natura diventa un linguaggio per parlare dell’anima e del destino umano.
La musica dei versi
Dal punto di vista stilistico, i versi di Trakl colpiscono per la loro musicalità sommessa. Le immagini si susseguono con fluidità, come fotogrammi che scorrono l’uno dopo l’altro, senza bruschi contrasti. La sintassi semplice, quasi colloquiale, amplifica il senso di inevitabilità: non c’è enfasi retorica, ma una voce che constata, che osserva, che registra con lucidità il dissolversi del mondo.
I versi di Declino dell’estate rappresentano una perfetta sintesi della poetica di Georg Trakl: malinconica, simbolica, intrisa di immagini naturali trasfigurate in allegorie esistenziali. L’estate che svanisce, i fiori che muoiono, il merlo che grida atterrito, la rondine che parte e il sole che affonda dietro la collina sono tutte figure di un destino universale: la vita che si consuma, la speranza che si spegne, la notte che inevitabilmente avanza.
Eppure, in questa visione tragica, rimane anche una sorta di austera bellezza: la notte che porta il “viaggio delle stelle” suggerisce che, pur nella caduta, esiste un ordine cosmico, un ritmo più grande dell’uomo. È forse questa la forza dei versi di Trakl: trasformare la disperazione in poesia, la caducità in immagine, il dolore in canto.