Una frase di Gandhi sul valore imprescindibile della libertà
Leggiamo assieme questa citazione del Mahatma Gandhi in cui ricorda ai propri lettori il valore della disobbedienza civile.
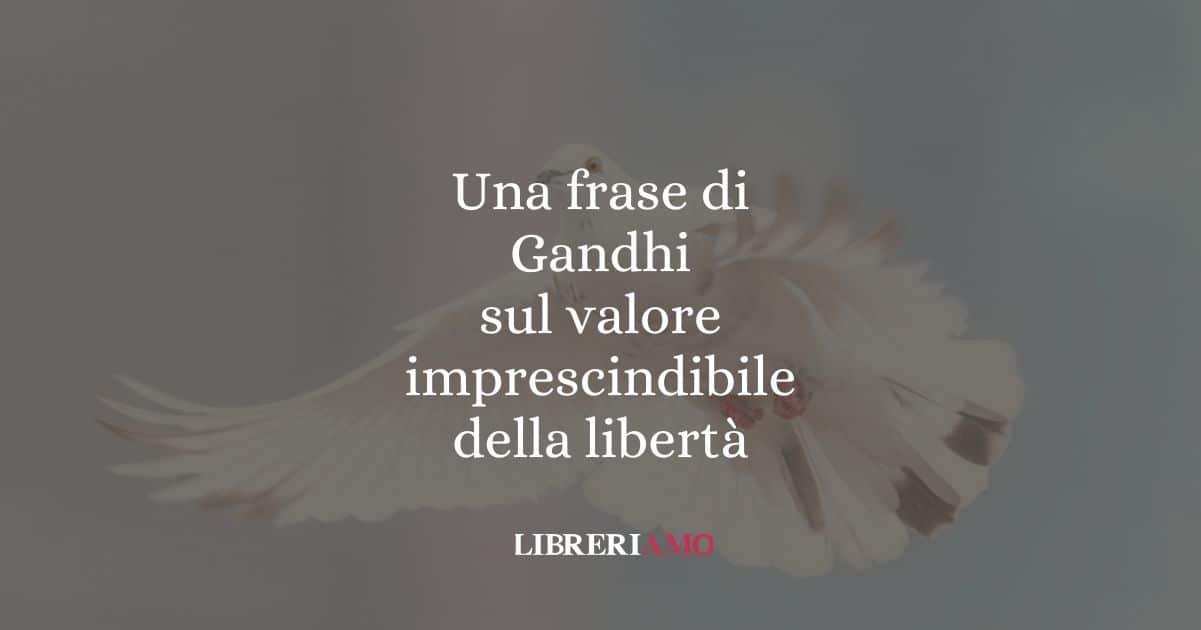
La riflessione di Mohandas Karamchand Gandhi sulla disubbidienza civile è uno dei punti cardinali del suo pensiero politico e morale. Nel testo Antiche come le montagne troviamo una definizione che riassume con chiarezza la sua visione:
«La disubbidienza per essere civile dev’essere sincera, rispettosa, contenuta, mai provocante, deve basarsi su principi bene assimilati, non dev’essere capricciosa e soprattutto non deve nascondere rancore e odio.»
Questa citazione non è soltanto una regola tattica, ma un principio etico che lega indissolubilmente l’azione politica alla crescita interiore dell’individuo. Gandhi non concepisce la disubbidienza come semplice atto di ribellione, bensì come una forma superiore di responsabilità morale, un modo per rivelare l’ingiustizia e al tempo stesso costruire un nuovo rapporto con la verità.
Disubbidienza civile e sincerità
La prima condizione che Gandhi pone è la sincerità. Non può esserci disubbidienza civile autentica se l’azione non scaturisce da una convinzione profonda. La sincerità è ciò che distingue un gesto calcolato o opportunistico da un atto realmente radicato nei principi. Per Gandhi, la sincerità non si misura con la coerenza formale, ma con l’adesione intima ai valori della giustizia e della non violenza (ahimsa).
Essere sinceri significa riconoscere che la disubbidienza non nasce dal desiderio di affermare il proprio ego, ma dalla necessità di difendere un bene comune, una verità che riguarda tutti.
Un altro punto centrale è il rispetto. La disubbidienza civile, per Gandhi, non deve mai trasformarsi in un insulto all’avversario. Anche quando si contrasta un potere ingiusto, è necessario mantenere la dignità dell’altro. Il rispetto non equivale ad accettare la violenza o la tirannia, ma a ricordare che chi opprime non smette di essere un essere umano.
Il rispetto si traduce in contenimento: non rispondere alla violenza con la violenza, non cedere alla tentazione della vendetta, non lasciarsi trascinare da un odio cieco. È questo autocontrollo a rendere la disubbidienza “civile” e non una semplice esplosione di rabbia.
La disubbidienza civile non deve essere provocante. Gandhi diffida delle azioni che cercano deliberatamente di suscitare reazioni violente, perché queste finiscono per alimentare il ciclo del conflitto. La non provocazione è una forma di saggezza: non si tratta di evitare il confronto, ma di costruirlo in modo che resti aperto alla trasformazione e non degeneri in distruzione.
Una disubbidienza che provoca intenzionalmente rischia di perdere la propria credibilità morale. Diventa allora un gioco di potere, un atto teatrale privo di contenuto etico.
Principi bene assimilati
Gandhi insiste che la disubbidienza civile deve basarsi su principi bene assimilati. Non basta richiamarsi genericamente alla giustizia: è necessario che chi pratica la resistenza abbia interiorizzato i valori che guidano l’azione. Questo richiede studio, riflessione, meditazione.
In altre parole, la disubbidienza civile non può essere improvvisata. È una disciplina spirituale e politica che esige formazione e consapevolezza. Solo così diventa una forza capace di trasformare la società e non un gesto effimero destinato a spegnersi.
Non capricciosa
Gandhi mette in guardia anche dal rischio della capricciosità. Una disubbidienza nata da un impulso momentaneo, da un capriccio personale o da una moda del momento, perde forza e legittimità. Perché sia efficace, deve rispondere a un senso profondo di giustizia, condiviso e riconoscibile.
La lotta non violenta non è un atto isolato, ma parte di un cammino collettivo. Non può essere guidata dall’arbitrio individuale, ma deve poggiare su un orizzonte comune, che nasce dall’adesione convinta a principi universali.
Senza rancore né odio
Forse il punto più radicale della citazione è la condanna del rancore e dell’odio. Gandhi sa che ogni lotta rischia di degenerare se alimentata da sentimenti distruttivi. Il rancore inquina la purezza dell’azione, trasforma la ricerca di giustizia in vendetta personale.
Per questo la disubbidienza civile deve essere un esercizio costante di purificazione interiore. Non basta astenersi dalla violenza fisica: bisogna liberarsi dalla violenza del cuore. Solo così il gesto di resistenza può rivelare la sua forza trasformativa, perché non cerca di distruggere l’avversario, ma di convertirlo, o almeno di renderlo consapevole della sua ingiustizia.
L’attualità di Gandhi
Le parole di Gandhi hanno un’attualità sorprendente. Nel nostro tempo, segnato da proteste sociali, manifestazioni e conflitti, la distinzione tra disubbidienza civile e semplice disordine è spesso trascurata. La lezione gandhiana ci ricorda che la forza della protesta non sta nel volume della rabbia, ma nella profondità dei principi che la guidano.
Molti movimenti civili contemporanei, dalla difesa dell’ambiente ai diritti umani, hanno trovato ispirazione in questa visione. Il metodo non violento, basato su sincerità, rispetto e assenza di odio, rimane uno degli strumenti più potenti per trasformare le società senza alimentare nuove catene di violenza.
La citazione di Gandhi da Antiche come le montagne definisce un ideale di disubbidienza che è allo stesso tempo politico e spirituale. Non basta ribellarsi: bisogna farlo con sincerità, rispetto, autocontrollo, principi chiari e senza odio. In questa disciplina rigorosa si manifesta la vera civiltà, quella che non mira a distruggere l’avversario, ma a risvegliare in lui e in noi la coscienza della verità.
In un mondo in cui la protesta spesso si riduce a slogan urlati o a gesti provocatori, le parole di Gandhi restano un invito a recuperare il senso autentico della disubbidienza civile: non come sfogo di rabbia, ma come atto di amore per la giustizia e per l’umanità intera.