I versi di Gabriele D’Annunzio sulla bellezza della diversità
Leggiamo assieme questi versi di Gabriele D’Annunzio tratti da Laudi, Maia, I, Laus vitae, che inneggiano alla bellezza della diversità del creato.
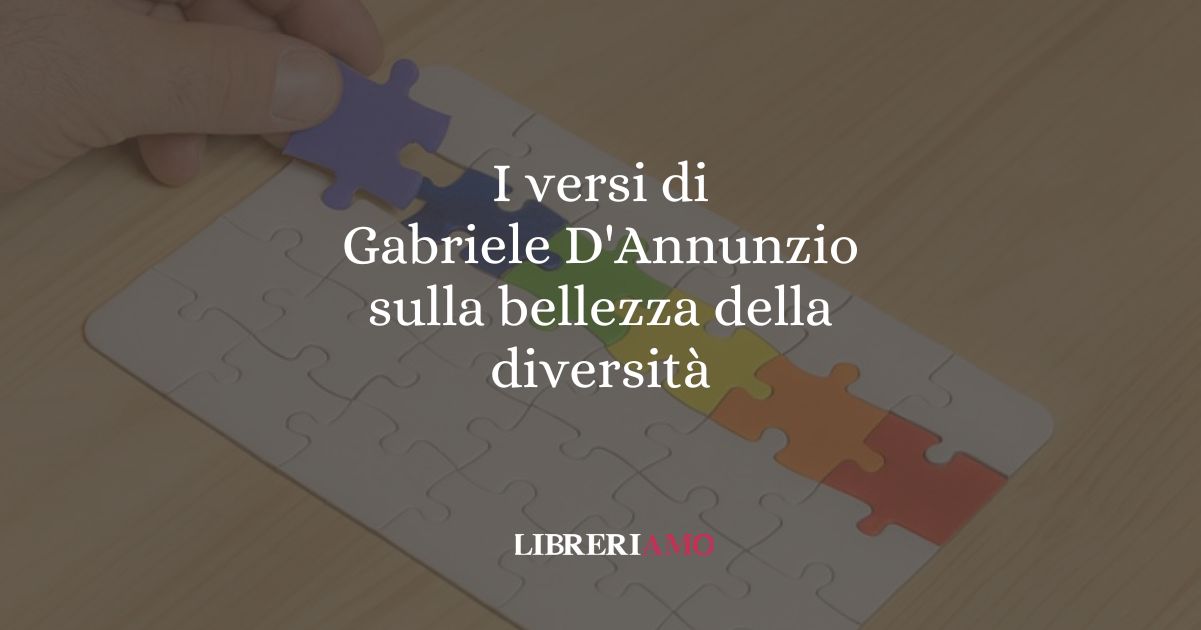
I versi di Gabriele D’Annunzio:
“Laudata sii, Diversità
delle creature, sirena
del mondo! Talor non elessi
perché parvemi che eleggendo
io t’escludessi,
o Diversità, meraviglia
sempiterna…”
contenuti nella prima sezione delle Laudi, nel libro Maia, rappresentano uno dei momenti più intensi e significativi della poetica dannunziana. Essi si collocano all’interno di Laus vitae, un inno alla vita che celebra la bellezza del mondo e delle sue infinite manifestazioni. La figura della Diversità viene personificata e invocata come se fosse una divinità o una sirena, attrattiva e seducente, capace di incantare chi la contempla.
Il contesto delle Laudi di Gabriele D’Annunzio
Le Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi costituiscono una delle opere più ambiziose del D’Annunzio poeta. Nel progetto originario avrebbero dovuto essere sette libri, intitolati come le Pleiadi, le stelle della mitologia greca. Di queste, furono effettivamente composti quattro libri: Maia, Elettra, Alcyone e Merope.
Il libro Maia si apre con Laus vitae, un lungo poema in cui D’Annunzio celebra la vitalità, la forza della natura e l’esperienza sensibile come suprema fonte di piacere e conoscenza. È un’opera che respira un forte vitalismo nietzschiano e che si pone come esaltazione dell’esistenza in tutte le sue forme, senza esclusioni.
Nell’estratto in questione, D’Annunzio eleva un inno alla Diversità delle creature, definendola sirena del mondo. La metafora della sirena non è casuale: come le sirene del mito attiravano i marinai con il loro canto, così la varietà delle forme di vita e delle esperienze umane esercita una seduzione irresistibile. La diversità diventa dunque sinonimo di bellezza, di ricchezza inesauribile, di mistero che affascina e insieme disorienta.
Il poeta confessa di non aver sempre potuto scegliere, perché scegliere significava escludere, e l’idea di escludere qualcosa dalla contemplazione universale gli sembrava quasi una mutilazione. Questa tensione rivela l’ansia totalizzante del D’Annunzio, il suo desiderio di possedere e vivere tutte le esperienze, di non lasciarsi sfuggire nessuna possibilità di piacere o conoscenza.
Diversità come meraviglia sempiterna
Il termine “sempiterna” sottolinea la dimensione eterna della diversità. Non si tratta di una semplice molteplicità accidentale, ma di un principio fondamentale che governa l’esistenza. Il mondo vive e prospera grazie alla differenza delle forme, alla varietà delle specie, alla molteplicità dei fenomeni. Senza diversità non ci sarebbe vita, ma uniformità sterile.
D’Annunzio, con la sua sensibilità estetica esasperata, percepisce questa verità e la trasforma in celebrazione poetica. La diversità diventa per lui una forma di religione laica: lodata come si loda una divinità, cantata come si canta un inno sacro.
Il legame con Nietzsche e il vitalismo
In questi versi si sente forte l’eco del pensiero di Friedrich Nietzsche, che D’Annunzio aveva letto e assimilato. L’idea di esaltare la vita in tutte le sue forme, senza rifiutare nulla, corrisponde al principio nietzschiano dell’“amor fati”, l’amore del proprio destino, qualunque esso sia.
Il rifiuto di scegliere, perché la scelta comporta esclusione, è legato alla volontà di vivere “oltre” i limiti, di non porre confini all’esperienza. È un atteggiamento che richiama anche la figura del superuomo nietzschiano, capace di accogliere e dominare la molteplicità del reale senza piegarsi a dogmi o restrizioni morali.
Per D’Annunzio la diversità non è soltanto un dato naturale, ma anche un valore estetico. Essa alimenta la curiosità, lo stupore, il desiderio inesauribile di scoprire. Ogni forma di vita, ogni esperienza, ogni differenza diventa fonte di ispirazione e arricchimento.
In questo senso, la diversità si oppone all’omologazione e alla mediocrità. Essa rappresenta la meraviglia sempiterna proprio perché non si lascia ridurre a una forma unica, ma si rinnova continuamente. È un principio di movimento, di vitalità, di trasformazione costante.
Un messaggio attuale
Questi versi di D’Annunzio, pur scritti nel contesto decadentista di inizio Novecento, conservano una sorprendente attualità. In un mondo globalizzato, spesso dominato dall’omologazione culturale, l’invocazione alla diversità come “sirena del mondo” appare quasi profetica.
La capacità di valorizzare le differenze – che siano culturali, biologiche o individuali – rappresenta ancora oggi una delle sfide più importanti per la convivenza umana. L’elogio della diversità diventa così un invito a riconoscere la ricchezza del pluralismo e a resistere alla tentazione di uniformare tutto a un modello unico.
I versi di D’Annunzio in Laus vitae non sono soltanto un’ode alla natura, ma un’autentica filosofia poetica. Lodare la Diversità significa riconoscere che la vita è un intreccio di forme molteplici, ognuna delle quali contribuisce alla bellezza del mondo.
L’immagine della sirena, la confessione del poeta che non osa scegliere per non escludere, l’idea della meraviglia sempiterna: tutto concorre a esaltare un vitalismo che non si accontenta del singolare, ma abbraccia il molteplice.
In questo senso, D’Annunzio offre al lettore non solo un’esperienza estetica, ma anche un monito esistenziale: vivere pienamente significa saper accogliere la diversità, celebrarla e lasciarsi sedurre dal suo canto, senza paura di smarrirsi nella sua infinita ricchezza.