I versi di Gabriele D’Annunzio sull’arrivo di Settembre
Leggiamo assieme questi versi di Gabriele D’Annunzio tratti dalle Laudi contenute dell’Alcyone; versi che parlano dell’arrivo di settembre.
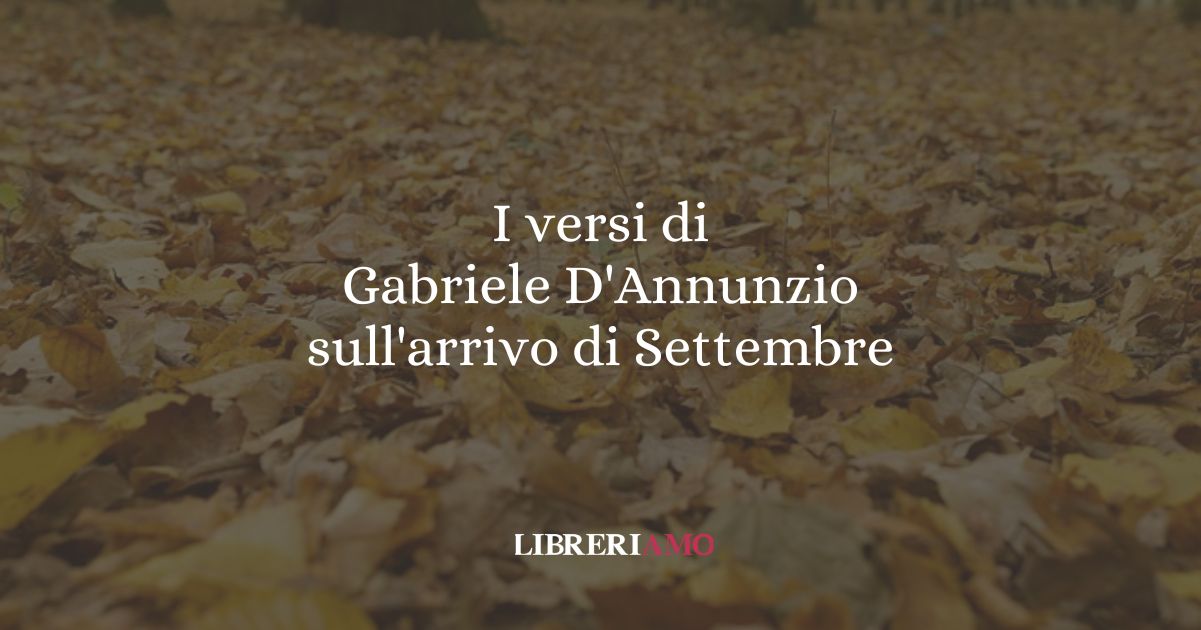
Tra i versi più celebri e intensi delle Laudi di Gabriele D’Annunzio si colloca l’incipit della poesia I pastori:
«Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare.»
Questi versi, così semplici e solenni al tempo stesso, racchiudono una delle immagini più potenti della tradizione italiana: la transumanza, ossia lo spostamento stagionale dei pastori abruzzesi dalle montagne verso i pascoli più miti delle pianure pugliesi e delle zone costiere. In poche parole, D’Annunzio riesce a fondere la concretezza di un’usanza secolare con una visione poetica che assume valore universale: il movimento ciclico della vita, il legame inscindibile tra uomo e natura, l’idea del viaggio come destino.
Il contesto: Gabriele D’Annunzio e I pastori
La poesia appartiene al terzo libro delle Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, intitolato Alcyone (1903). Questo libro è forse il più lirico e naturalistico dell’intero ciclo dannunziano: celebra i paesaggi italiani, la sensualità della natura e la fusione panica dell’uomo con l’ambiente che lo circonda.
I pastori, in particolare, non è una semplice descrizione etnografica. Pur partendo da un fenomeno reale e tradizionale, D’Annunzio trasfigura la transumanza in un rito solenne e quasi sacrale. Il poeta si rivolge direttamente a settembre, personificandolo, e ne sottolinea il ruolo di segno del tempo, di mese che annuncia il cambiamento e il passaggio.
“Settembre, andiamo. È tempo di migrare”
Il primo verso è di una semplicità assoluta, ma dietro la sua immediatezza si cela un profondo valore simbolico. “Andiamo” è un invito corale, che accomuna il poeta ai pastori e, per estensione, a tutta l’umanità. La vita è movimento, è migrazione, è passaggio da uno stato all’altro. Non si può restare immobili di fronte al fluire del tempo: settembre, con i suoi cieli più limpidi e le giornate che si accorciano, ricorda che la natura cambia e che l’uomo deve adattarsi.
Il verbo “migrare” è qui particolarmente significativo. Non indica soltanto lo spostarsi fisico dei pastori, ma allude anche a un più vasto pellegrinaggio esistenziale. L’uomo, come gli animali e come le stagioni, è sempre chiamato a spostarsi, a cercare nuove terre, nuovi orizzonti, nuove possibilità.
I pastori e la tradizione abruzzese
Nell’Abruzzo montano, terra d’origine di D’Annunzio, la transumanza rappresentava per secoli un fenomeno fondamentale di sopravvivenza economica e sociale. A settembre, quando i pascoli d’alta quota si inaridivano, i pastori conducevano le greggi verso la pianura, lungo tratturi che univano l’Appennino al Tavoliere delle Puglie e alle coste adriatiche. Questo spostamento, che poteva durare settimane, era una sorta di rito collettivo, carico di significati comunitari e identitari.
D’Annunzio eleva questa pratica a simbolo poetico. L’immagine dei pastori che lasciano gli “stazzi” (ovili montani) e si dirigono verso il mare è emblematica di un rapporto armonioso tra uomo e natura, in cui il ritmo della vita umana segue quello delle stagioni. Non vi è scontro né dominio, ma partecipazione e adattamento.
Natura, nostalgia e destino
Nella poesia si avverte anche un tono di nostalgia. I pastori abbandonano i luoghi familiari, le montagne che hanno ospitato la loro vita estiva, e intraprendono un viaggio che li porta lontano. Questa partenza ha un sapore dolceamaro: è necessaria, inevitabile, ma segna comunque un distacco. Settembre diventa così il mese della separazione, del congedo, ma anche dell’attesa di un ritorno futuro.
Il movimento verso il mare, inoltre, non è casuale. Il mare, per D’Annunzio, è simbolo di apertura, di infinito, di libertà. La transumanza non è soltanto una discesa geografica: è un cammino verso orizzonti più ampi, verso la possibilità di un nuovo inizio.
Una poesia universale
Se da un lato I pastori celebra una tradizione profondamente radicata nell’Abruzzo, dall’altro ha un valore universale. Tutti i popoli, in epoche e luoghi diversi, hanno conosciuto fenomeni di migrazione, di spostamento legati alle stagioni o alla necessità di sopravvivenza. La poesia diventa così una meditazione sul rapporto ancestrale tra uomo e natura, sulla condizione di perenne movimento che caratterizza l’esistenza umana.
Non a caso, i versi iniziali hanno assunto una fortuna straordinaria anche al di fuori del contesto dannunziano, divenendo un motto che si presta a interpretazioni molteplici: dall’invito al cambiamento personale alla riflessione sull’emigrazione moderna, dalle migrazioni storiche alle partenze che segnano la vita di ogni individuo.
La musicalità e lo stile
Dal punto di vista formale, i versi sono caratterizzati da una musicalità limpida e solenne. La scansione metrica è regolare, l’uso dell’imperativo (“andiamo”) e del presente (“è tempo”) conferisce un tono di immediatezza e di urgenza. D’Annunzio rinuncia a complicazioni retoriche per privilegiare la forza evocativa delle immagini e la coralità della voce poetica.
Questa scelta stilistica riflette la volontà di aderire al ritmo naturale delle cose: i versi stessi sembrano scorrere come un passo lento e cadenzato, simile a quello delle greggi in cammino.
I versi «Settembre, andiamo. È tempo di migrare. / Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori / lascian gli stazzi e vanno verso il mare» rappresentano una delle più alte sintesi poetiche di Gabriele D’Annunzio. Essi racchiudono la concretezza di una tradizione secolare, la transumanza, ma la trasfigurano in simbolo universale della condizione umana: la necessità di adattarsi al fluire del tempo, di partire, di affrontare il distacco e di cercare sempre nuovi orizzonti.
In questa poesia si intrecciano memoria personale, nostalgia collettiva e visione cosmica. Settembre diventa il mese del cambiamento, della separazione e del rinnovamento, mentre i pastori incarnano l’immagine di un’umanità che cammina insieme, in armonia con la natura e con il proprio destino.