I versi di Dante Alighieri sulla pigrizia, problema di ogni Agosto
Leggiamo assieme questi versi di Dante Alighieri tratta dal XXIV canto dell’Inferno, in cui il poeta descrive il male che è la pigrizia.
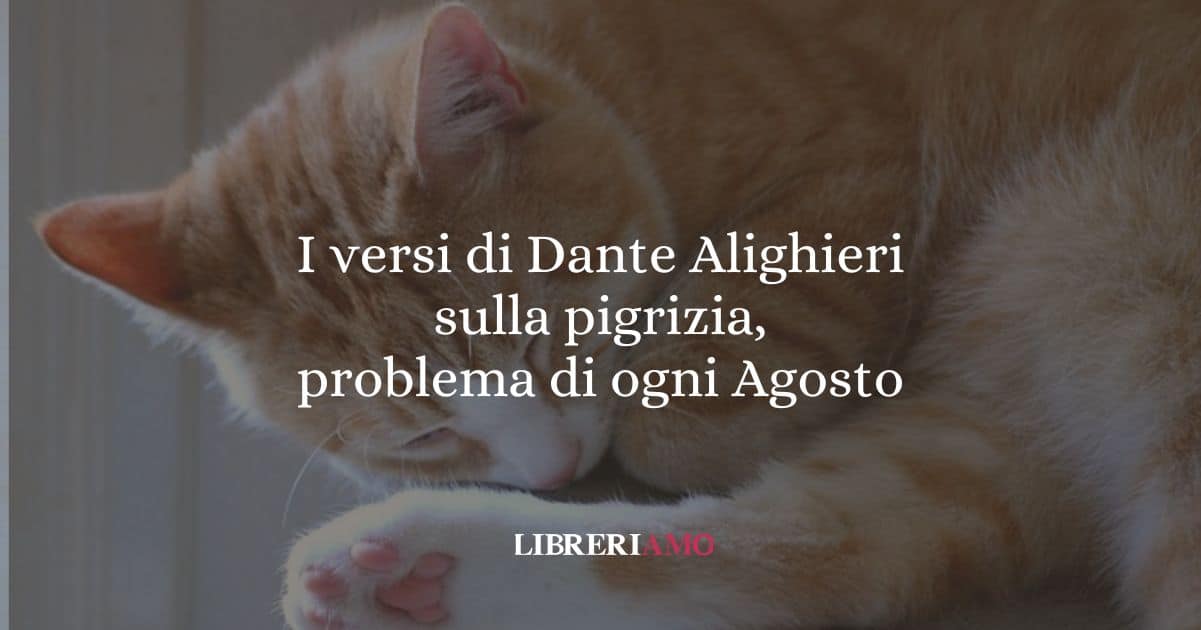
Tra le molte immagini potenti che Dante Alighieri dissemina nella Commedia, i versi del XXIV canto dell’Inferno dedicati alla pigrizia hanno mantenuto nei secoli una straordinaria forza evocativa:
“…Seggendo in piuma,
in fama non si vien, né sotto coltre;
senza la qual chi sua vita consuma,
cotal vestigio in terra di sé lascia,
qual fummo in aere e in acqua la schiuma.”
Con poche, incisive parole, Dante costruisce una sentenza universale che travalica i confini del suo tempo e che parla ancora oggi alla nostra esperienza. L’immagine delle “piume” e delle “coltri” richiama immediatamente il conforto e l’inerzia: chi sceglie di vivere nella comodità, senza sforzo e senza azione, non può conquistare fama né lasciare traccia duratura di sé. Al contrario, il suo passaggio sulla terra sarà effimero come il fumo che si disperde nell’aria o come la schiuma che si dissolve sull’acqua.
Contesto del Canto di Dante Alighieri
Il XXIV canto dell’Inferno si colloca all’interno dell’episodio dei ladri (in questo particolare canto, Vanni Fucci, ladro di reliquie sacre), puniti tra il settimo e il decimo bolgia dell’ottavo cerchio. Prima di affrontare la descrizione delle pene, Dante inserisce una riflessione personale che funge da esortazione universale. In questo punto, Virgilio incoraggia il poeta, stanco e sfiduciato, a non arrendersi davanti alla fatica del viaggio. L’immagine della pigrizia non è dunque soltanto un rimprovero morale astratto, ma una spinta concreta a proseguire nel cammino.
In questo senso, i versi assumono un doppio valore: da un lato diventano ammonimento contro l’inerzia, dall’altro si trasformano in un invito motivazionale, utile a chiunque si trovi davanti a una difficoltà.
La pigrizia come peccato e come limite umano
Per Dante la pigrizia, o accidia, era un peccato grave: non tanto per il semplice “non fare”, quanto per il rifiuto dell’impegno e della responsabilità. L’accidioso è colui che, pur avendo la possibilità di agire, si ritrae, si lascia vivere, diventa spettatore passivo del mondo. In termini religiosi, l’accidia rappresenta l’indifferenza verso Dio e verso il bene; in termini laici, è la mancanza di energia vitale, di desiderio di costruire e di lasciare un’impronta.
Dante traduce questa condizione interiore in immagini forti: il fumo nell’aria e la schiuma sull’acqua sono metafore di ciò che non ha consistenza, che appare e subito svanisce. Così è la vita di chi sceglie di consumarsi nel torpore: non resta memoria, non resta contributo.
Attualità del messaggio
Il monito dantesco non ha perso vigore nei secoli. Anzi, in un’epoca come la nostra, segnata dall’abbondanza di stimoli ma anche da una diffusa tendenza alla distrazione e alla procrastinazione, questi versi assumono una rilevanza particolare.
Oggi la “piuma” e la “coltre” possono essere viste come simboli delle molte comodità offerte dalla tecnologia e dal benessere materiale. È facile lasciarsi cullare dalla passività, consumando contenuti senza produrne, assistendo senza partecipare, vivendo vite secondarie nei mondi digitali senza affrontare le sfide concrete. Ma, avverte Dante, chi vive così non lascia traccia: il suo passaggio è rapido e inconsistente.
Il valore dello sforzo
La riflessione di Dante contiene anche un insegnamento positivo: solo attraverso lo sforzo, la fatica e l’impegno costante si può conquistare la fama, intesa non soltanto come notorietà pubblica, ma come dignità e compimento della propria esistenza. La vita umana trova senso nel movimento, nell’agire, nella capacità di generare opere, relazioni, idee.
Il poeta stesso è l’esempio più evidente di questa verità: la Commedia non sarebbe mai nata senza un impegno titanico, senza la forza di volontà di continuare a scrivere e a riflettere anche nelle difficoltà dell’esilio e delle delusioni personali.
L’universalità della lezione dantesca
Ogni epoca ha conosciuto forme diverse di pigrizia, ma l’essenza non cambia. Nel Medioevo, la pigrizia era l’inerzia di chi rifiutava la vita attiva e la disciplina religiosa. Oggi può assumere i contorni dell’apatia, della fuga nella virtualità, della dipendenza dalla comodità. In ogni caso, il risultato è lo stesso: una vita che non incide, che non costruisce, che non lascia memoria.
Questa riflessione si collega a molte tradizioni filosofiche. Aristotele, per esempio, aveva già sottolineato come la vita buona fosse quella dedicata all’attività (energeia), al compimento delle proprie potenzialità. Più tardi, filosofi moderni come Nietzsche hanno insistito sull’importanza dell’azione creativa come antidoto al nichilismo. Dante, con la sua forza poetica, dà voce a un principio universale: l’uomo si realizza solo attraverso l’impegno e l’azione.
I versi del XXIV canto dell’Inferno dedicati alla pigrizia ci consegnano una verità semplice ma profonda: chi si adagia nell’inerzia vive invano, lasciando dietro di sé soltanto il ricordo evanescente del fumo e della schiuma. Non c’è vera dignità né compimento senza fatica, senza la scelta di affrontare il mondo e di imprimere su di esso il segno della propria esistenza.
In questo senso, Dante non parla solo agli uomini del suo tempo, ma a ciascuno di noi. Ci ricorda che la vita non si compie nella comodità, ma nello sforzo creativo, nel coraggio di agire. Solo così si lascia un “vestigio” che resiste al tempo e che trasforma la nostra esistenza da fugace comparsa a testimonianza duratura.