I versi di Dante Alighieri pieni d’amore verso il suo maestro
Leggiamo questi sempiterni versi tratti dalla chiusura del XV canto dell’Inferno, momento in cui Dante Alighieri saluta il suo maestro Brunetto Latini.
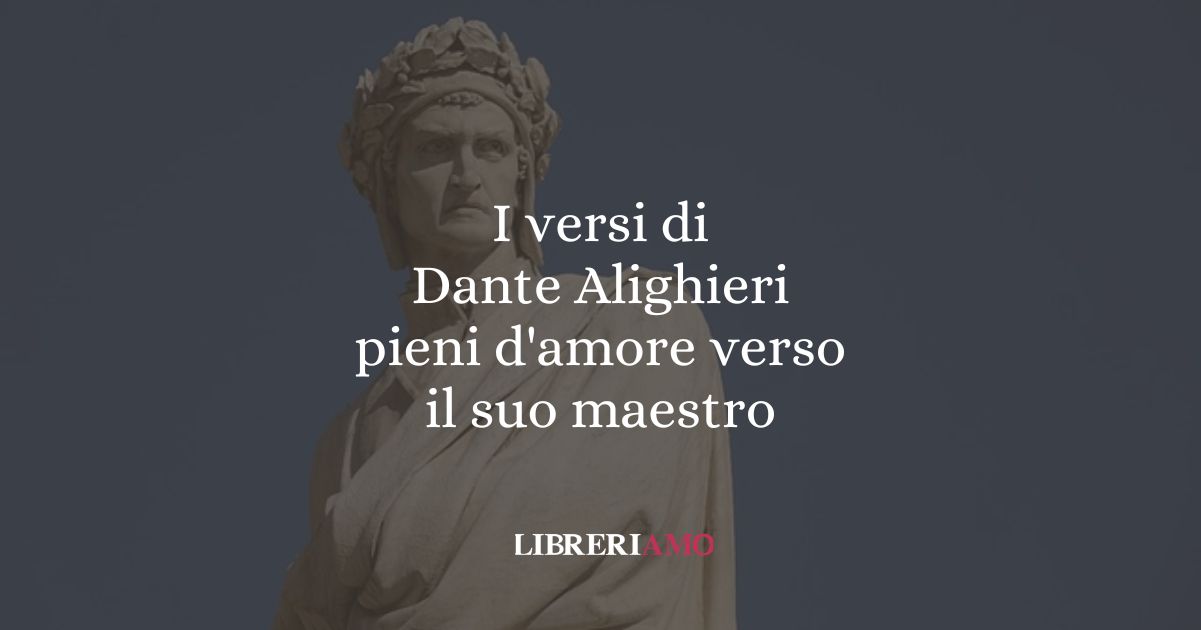
Nel XV canto dell’Inferno di Dante Alighieri, l’incontro con Brunetto Latini si distingue per la sua eccezionale carica emotiva e poetica. Il discepolo Dante si trova di fronte a colui che fu per lui più di un maestro: una figura paterna, guida intellettuale e morale della giovinezza. Eppure, quella figura tanto amata si trova tra i sodomiti, sotto la pioggia infuocata, tra i dannati dell’Inferno. Il paradosso tragico di questo incontro risiede proprio nella coesistenza, negli stessi versi, di grandezza morale e dannazione eterna, di affetto umano e giudizio divino.
Dante Alighieri e il commuovente addio al suo maestro
La sequenza che chiude il canto è tra le più celebri e significative dell’intera Commedia:
“Poi si rivolse, e parve di coloro
che corrono a Verona il drappo verde
per la campagna; e parve di costoro
quelli che vince, non colui che perde.”
Con queste parole, Dante descrive l’addio del maestro. Brunetto si allontana per tornare nella sua pena, ma l’immagine che ne resta non è quella del dannato sconfitto. Al contrario, Dante lo paragona al giovane vincitore che corre nella corsa del drappo verde, una gara veronese che si teneva tradizionalmente nella campagna fuori città, dove i corridori correvano nudi per conquistare il premio.
Questo paragone con il vincitore, e non con lo sconfitto, è profondamente simbolico. Brunetto, agli occhi di Dante, non ha perso. Nonostante la condanna, nonostante l’eterna pena, egli conserva un’aura di dignità e vittoria. Il discepolo, pur pienamente consapevole della dottrina teologica che lo obbliga a collocare Brunetto tra i peccatori, non può rinunciare all’umanità dell’incontro, né all’amore filiale che lo lega a lui. In questa figura si intrecciano la memoria personale e il giudizio universale.
Il dramma morale del canto
In questo canto si manifesta con forza quel doppio registro – etico e teologico – che percorre l’intera Divina Commedia, ma che qui si esplicita come in pochi altri momenti. Da un lato, Dante riconosce a Brunetto un valore umano, civile e culturale: lo considera l’ispiratore della sua vocazione letteraria e dell’impegno politico. Lo stima, lo onora, lo ama. Dall’altro lato, come poeta e teologo, non può sottrarsi al giudizio morale che lo condanna per il peccato contro natura, punito nella settima cerchia infernale.
Questa lacerazione interiore è esplicita nel verso:
che ‘n la mente m’è fitta, e or m’accora…
ovvero: quel volto amato è impresso nella memoria, e proprio per questo provoca un dolore più acuto. Dante non nasconde nulla: né l’orrore della pena, né il rispetto profondo per l’uomo che vi è soggetto.
Brunetto Latini e il senso della gloria terrena
La figura di Brunetto assume anche un altro significato simbolico. Egli, ormai condannato, raccomanda a Dante il suo “Tesoro”, opera enciclopedica in volgare francese che doveva raccogliere il sapere umano. Il Tesoro è il simbolo della gloria mondana, quella che si conquista con le opere dell’ingegno, della politica, della cultura. Ma per Dante, che ha ormai intrapreso il viaggio verso Dio, non basta. Il destino umano non si compie nel solo agire terreno, per quanto nobile: deve essere orientato a Dio, verso la beatitudine eterna.
In questo senso, la corsa del drappo verde diventa metafora ambivalente. Brunetto appare come il vincitore di una gara terrena, onorato, glorioso, ammirato; ma tale vittoria non gli assicura la salvezza. La sua corsa si conclude dentro l’Inferno. Eppure, Dante lo celebra. Gli riconosce una vittoria morale, almeno agli occhi di chi guarda con gli occhi dell’affetto e del ricordo.
L’eredità spirituale del maestro
La presenza di Brunetto nel XV canto non è solo biografica, ma ha una funzione profetica e simbolica. Egli è il ponte tra passato e futuro, tra la Firenze della giovinezza e il destino futuro del poeta. Nel momento in cui lo incontra, Dante riceve da lui una profezia del proprio esilio e del suo glorioso compito. È proprio Brunetto, il maestro del bene civile, colui che ha introdotto Dante alla humana civilitas, a indicargli il cammino dell’esilio e della solitudine, che sarà però anche cammino verso la verità e la gloria.
Così, attraverso le parole del maestro, si compie la transizione di Dante da allievo della cultura cittadina a profeta della verità cristiana. Ed è in questa transizione che si comprende fino in fondo il senso dell’addio: Brunetto si allontana nella pena, mentre Dante continua il viaggio verso la salvezza.
Il finale del XV canto è una sintesi perfetta di pietas e giustizia, affetto e condanna, memoria e profezia. La figura di Brunetto Latini, che si allontana come un vincitore, resta incisa nella memoria del lettore come icona della nobiltà umana che non basta a salvarsi, ma che merita rispetto. E Dante, pur non potendolo salvare, gli dona una forma di eternità, affidandone il ricordo al poema più grande della nostra letteratura.
Non il Tesoro, ma la Commedia, sarà la vera eredità immortale del maestro.