I versi di Charles Baudelaire sul coraggio di guardarci dentro
Leggiamo assieme questi splendidi versi di Charles Baudelaire in cui il poeta cerca di vedere senza timore un luogo impervio: sé stesso.
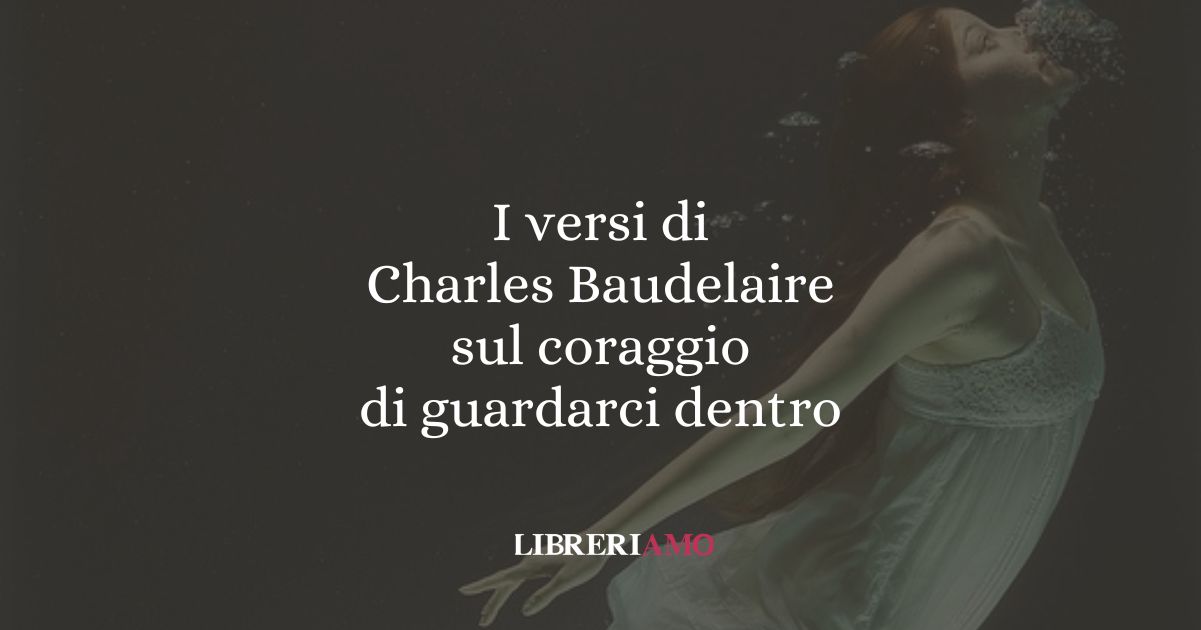
Questi versi di Charles Baudelaire, tratti dalla sezione Les Fleurs du mal, condensano uno dei nuclei più drammatici e profondi della poetica dell’autore: il confronto impietoso con se stesso, con la propria interiorità e con la propria carne, nella consapevolezza che ciò che si scopre non è sempre fonte di piacere, ma spesso di disgusto e di angoscia.
«O Dio, dammi il coraggio, la forza di guardare / senza provar disgusto il mio corpo e il mio cuore!»
(Un voyage à Cythère).
Il contesto della poesia di Charles Baudelaire
La lirica Un voyage à Cythère evoca, sin dal titolo, un immaginario antico e mitico. Citera, isola greca, è tradizionalmente associata al culto di Afrodite, dea della bellezza e dell’amore. Per i poeti e gli artisti, soprattutto del Settecento e dell’Ottocento, il viaggio a Citera era sinonimo di pellegrinaggio verso la terra del desiderio e del piacere, della giovinezza e della grazia. Celebre è il dipinto di Watteau, L’embarquement pour Cythère, che mostra coppie eleganti e sorridenti in un paesaggio idilliaco.
Charles Baudelaire, però, ribalta completamente questa tradizione. Il suo viaggio non è un’esperienza gioiosa ma una discesa nell’orrore: Citera non appare come un paradiso amoroso, ma come un luogo di decomposizione, segnato da un’impiccagione macabra che diventa simbolo del destino umano. Così il poeta trasforma un mito di bellezza in un’esperienza di disincanto, coerente con il tono cupo e provocatorio delle Fleurs du mal.
Il disgusto di sé
I due versi citati sono una preghiera disperata: il poeta invoca Dio non per ottenere salvezza o gloria, ma solo la forza di guardare se stesso senza nausea. È un’immagine di straordinaria potenza, perché mette al centro il tema dell’auto-rifiuto. Baudelaire avverte in sé un doppio degrado: quello del corpo, destinato alla corruzione, e quello del cuore, contaminato da pulsioni oscure, da colpe e desideri inconfessabili.
Questa percezione non è soltanto individuale, ma riflette un clima storico e culturale. L’Ottocento europeo, tra rivoluzioni, industrializzazione e nascita della società borghese, è un’epoca di crisi e di contraddizioni. Baudelaire, con la sua sensibilità estrema, si pone come testimone e interprete di questa frattura. Il disgusto verso se stesso diventa simbolo del disgusto verso un mondo che ha perso purezza e innocenza, ridotto a meccanismo spietato di mercificazione e di morte.
La duplicità di corpo e cuore
Il riferimento al corpo e al cuore mette in luce due dimensioni inseparabili: la fisicità e l’interiorità. Per Baudelaire il corpo non è un tempio armonioso, ma un involucro segnato dal tempo, soggetto al decadimento e alla corruzione. Il cuore, inteso come sede dei sentimenti e delle passioni, non appare migliore: anch’esso è fonte di colpa, di desiderio morboso, di contraddizione.
Questa visione rompe con l’ideale classico-romantico di unità e armonia. Nell’universo baudelairiano non vi è conciliazione, ma conflitto permanente: l’uomo è diviso, lacerato, incapace di riconciliarsi con se stesso. È qui che si avverte l’eco del pensiero agostiniano e della tradizione cristiana del peccato originale, che vede nella natura umana una radice corrotta e bisognosa di grazia. Ma, allo stesso tempo, la modernità di Baudelaire sta nel rifiuto di una consolazione definitiva: il suo Dio non risponde, resta lontano, e l’invocazione resta sospesa.
Dal mito di Citera alla modernità della disillusione
Il rovesciamento del mito di Citera è particolarmente significativo. Dove la tradizione collocava eros, piacere e bellezza, Baudelaire scopre solo putrefazione e dolore. È un gesto poetico radicale, che segna il passaggio dalla visione idilliaca del mondo alla consapevolezza moderna della sua crisi.
La preghiera finale, con il desiderio di non provare disgusto per se stesso, rappresenta un atto di estrema sincerità. Baudelaire non maschera la sua fragilità: anzi, la esibisce come segno di verità. In ciò si avvicina a una dimensione quasi esistenzialista, anticipando la tensione di autori novecenteschi come Sartre o Camus, che vedranno nell’uomo un essere gettato nel mondo, costretto a fare i conti con il nulla e con l’assurdo.
Il coraggio dello sguardo
Il termine chiave dei versi è “guardare”. Baudelaire chiede il coraggio di sostenere lo sguardo sul proprio corpo e sul proprio cuore. È un invito a non distogliere gli occhi, a non fuggire di fronte alla verità, per quanto sgradevole essa sia.
Guardarsi davvero significa accettare la propria condizione, smascherare le illusioni, rinunciare ai miti di bellezza eterna. Ma questo guardare è doloroso, perché comporta la perdita di ogni appiglio rassicurante. Per questo serve coraggio: la forza non di cambiare, ma semplicemente di reggere il peso della realtà.
Attualità del messaggio
A distanza di oltre un secolo e mezzo, questi versi restano sorprendentemente attuali. In un’epoca dominata dall’immagine, dalla ricerca ossessiva della perfezione fisica e dalla rappresentazione di sé nei social network, il disgusto per il proprio corpo e per la propria interiorità è esperienza diffusa. Il mito contemporaneo non è più Citera, ma la bellezza patinata delle fotografie e dei video, dove i corpi sono filtrati, corretti, resi irreali.
La preghiera di Baudelaire suona allora come un monito: avere il coraggio di guardarsi senza filtri, senza idealizzazioni, senza rifugi nell’apparenza. E accettare anche ciò che suscita disgusto, come parte integrante dell’essere umano.
«O Dio, dammi il coraggio, la forza di guardare / senza provar disgusto il mio corpo e il mio cuore!» è un grido che viene dal profondo, e che non ha perso la sua urgenza. Baudelaire, poeta del male di vivere, ci consegna la sfida di un viaggio a Citera che non è evasione, ma discesa nell’abisso della verità interiore. Lì scopriamo la fragilità, il degrado, la colpa, ma anche la possibilità di un’autenticità senza veli.
In questo sta la forza universale della poesia: nel trasformare il disgusto in parola, l’angoscia in bellezza, e nel chiedere a ciascuno di noi il coraggio di non fuggire da se stesso.