I versi di Cesare Pavese sull’inutilità della sofferenza
Leggiamo questi versi di Cesare Pavese scritti sul suo diario poi edito col titolo “Il mestiere di vivere”, segnati alla data del 28 ottobre 1938.
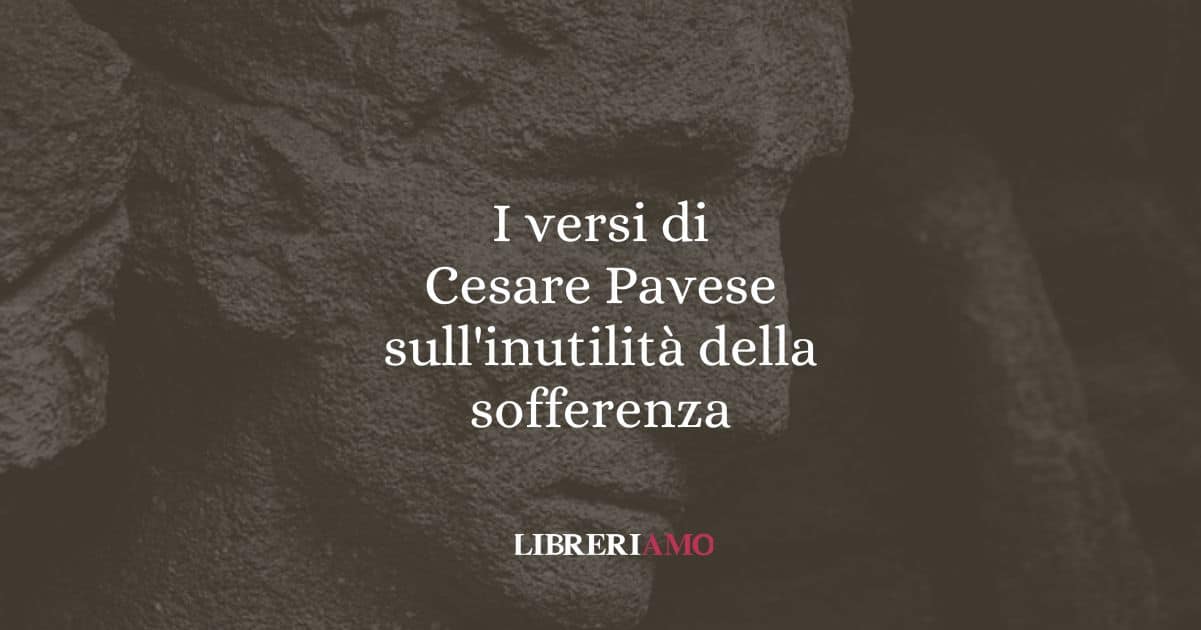
Il 28 ottobre 1938 Cesare Pavese annota nel suo diario, Il mestiere di vivere, una riflessione in versi che sorprende per la sua durezza e il suo carattere quasi aforistico:
«Soffrire non serve a niente.
Soffrire limita l’efficienza spirituale.
Soffrire è sempre colpa nostra.
Soffrire è una debolezza.»
Queste parole, scritte in un periodo di forte tensione personale e storica, rappresentano uno dei momenti più radicali del pensiero pavesiano. Il giovane scrittore, immerso in un clima politico oppressivo e in difficoltà interiori che lo accompagneranno fino alla tragica conclusione della sua vita, sembra qui voler negare ogni valore redentivo alla sofferenza, contraddicendo implicitamente una lunga tradizione culturale che, dalla religione alla filosofia, aveva spesso esaltato il dolore come via di purificazione o di elevazione.
Cesare Pavese e il rifiuto della sofferenza come “valore”
La prima affermazione – «Soffrire non serve a niente» – è secca e lapidaria. Cesare Pavese respinge ogni interpretazione del dolore come esperienza formativa, pedagogica o salvifica. Non vi è alcun senso intrinseco nella sofferenza, essa non porta con sé conoscenza né redenzione. In un certo senso, Pavese qui si oppone a una visione cristiana tradizionale, che vede nel dolore una partecipazione al sacrificio divino, e al tempo stesso si distanzia dalle filosofie che individuano nel patimento un passaggio necessario verso la saggezza.
Per lui, il soffrire non ha utilità pratica né spirituale: è un fatto sterile, che non arricchisce ma consuma. Si tratta di una posizione che ha il sapore del disincanto e che può essere letta come protesta contro la tentazione umana di giustificare a posteriori le proprie ferite con una narrazione consolatoria.
Nella seconda frase, Pavese afferma che «Soffrire limita l’efficienza spirituale». Qui il pensiero si fa ancora più netto: non solo il dolore è inutile, ma è dannoso. L’anima, appesantita dalla sofferenza, perde lucidità, perde forza creativa, si indebolisce.
In questo senso Pavese anticipa una visione moderna che tende a considerare il benessere interiore come condizione necessaria per l’attività creativa e per la crescita personale. L’idea romantica dell’artista che trae ispirazione dalla sua sofferenza viene qui ribaltata: non è il tormento che produce arte, ma anzi il tormento è una zavorra che riduce le possibilità dello spirito.
La confessione è ancora più significativa se si pensa che Pavese stesso è stato un autore che ha vissuto in una costante dialettica con la propria angoscia. Nei suoi romanzi e nelle sue poesie la malinconia e il senso di solitudine sono temi centrali, eppure egli stesso riconosce, almeno in quel momento, che il dolore non è una fonte vitale ma una ferita che indebolisce.
La responsabilità individuale del soffrire
Ancora più provocatoria è la terza affermazione: «Soffrire è sempre colpa nostra». Con queste parole Pavese introduce un elemento morale nel discorso. Il dolore, secondo lui, non è solo un fatto accidentale che accade dall’esterno, ma è il risultato di una nostra scelta, di un nostro atteggiamento, di un nostro errore.
Questa posizione si avvicina a certe filosofie stoiche, secondo cui non sono le cose in sé a farci soffrire, ma il giudizio che noi diamo su di esse. In altre parole, la sofferenza non dipende tanto dagli eventi quanto dal modo in cui li affrontiamo. Pavese sembra assumere, almeno per un attimo, questa visione radicale di responsabilità individuale, che però, se da un lato libera da una visione vittimistica, dall’altro rischia di diventare un peso insopportabile: se il dolore è sempre colpa nostra, allora chi soffre è doppiamente colpevole, sia per la sua condizione, sia per non averla saputa superare.
Infine, la frase conclusiva: «Soffrire è una debolezza.» Qui la riflessione si fa quasi impietosa. Pavese non concede alcun riconoscimento al dolore, ma lo considera un difetto, una mancanza di forza, un segno di vulnerabilità. Questa posizione richiama l’etica della forza tipica del pensiero nietzschiano, secondo cui la vita autentica si afferma non nel pianto ma nella potenza vitale.
Eppure, nel caso di Pavese, questa condanna della debolezza sembra rivelare un’autoaccusa. Pavese si sapeva fragile, soggetto a crisi interiori e a una sensibilità che spesso lo travolgeva. Definire la sofferenza come debolezza equivale quasi a colpire sé stesso, a un atto di autocritica spietata.
Un pensiero in tensione con la vita dello scrittore
Queste righe, se lette nel contesto della biografia di Pavese, acquistano un significato ancora più drammatico. Egli, che ha scritto dell’inutilità del soffrire, sarà segnato per tutta la vita proprio da quella sofferenza che dichiarava sterile. La sua morte volontaria nel 1950, dopo l’ennesima delusione amorosa, mostra quanto profonda fosse la contraddizione tra la consapevolezza teorica e la realtà esistenziale.
In questo senso, l’appunto del 1938 non è tanto una verità assoluta quanto un tentativo disperato di autodifesa: convincersi che soffrire non serva a nulla per imparare a respingerlo, per opporsi alla tentazione di lasciarsi consumare.
Le righe de Il Mestiere di vivere del 28 ottobre 1938 mostrano un Pavese lucido e insieme tormentato. Nega ogni funzione al dolore, lo giudica dannoso, lo attribuisce alla colpa individuale e lo riduce a segno di debolezza. Sono parole che rivelano tanto un pensiero filosofico vicino allo stoicismo quanto una drammatica condanna di sé stesso.
Più che un manifesto, esse appaiono come una confessione amara: l’ammissione di un uomo che vede nella sofferenza non una via di conoscenza, ma una catena che immobilizza lo spirito. E tuttavia, proprio questa lotta contro la sofferenza diventerà la materia viva della sua opera letteraria, facendo di Pavese un autore capace di trasformare in parole universali le ferite più intime.