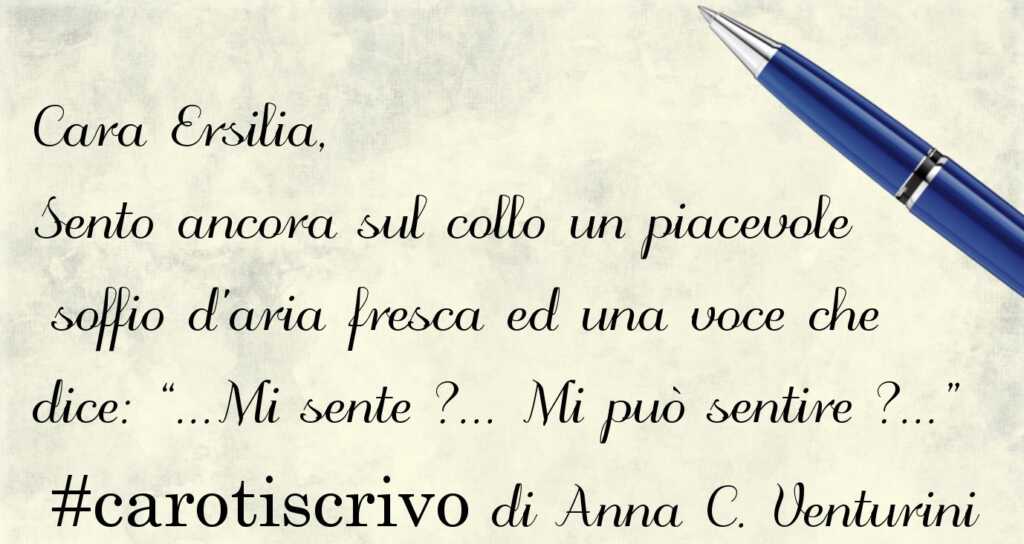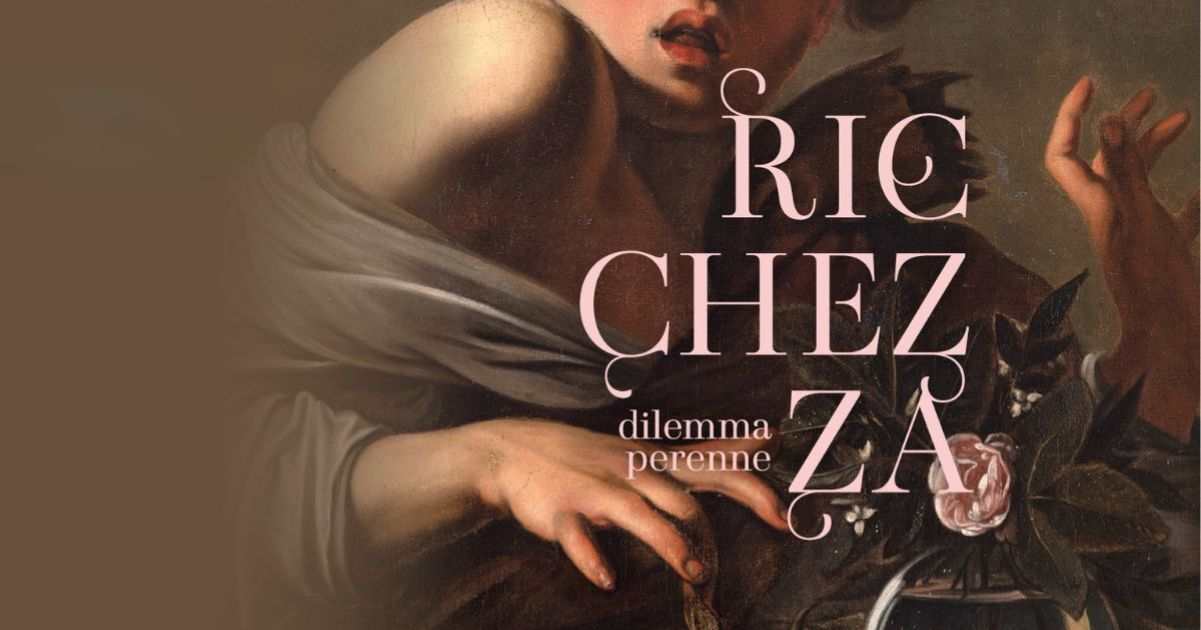Cara Ersilia,
Sento ancora sul collo un piacevole soffio d’aria fresca ed una voce che dice: “…Mi sente ?… Mi può sentire ?……….”. Quando mi sono svegliata dopo l’anestesia, cercavo di ricordare perché mi trovassi lì. Avevano detto che dentro di me c’era qualcosa che era meglio togliere, perché a lasciarla così quella cosa avrebbe fatto solo danni. Il peggio era quindi passato, la degenza sarebbe stata breve salvo complicanze. La fragilità di quei momenti costringe a pensar meglio. Ero circondata da pareti bianche, lenzuola bianche, camici bianchi, tutto sapeva di bianco eccetto l’orribile pavimento di linoleum aragosta, un pugno negli occhi. Quando si è allettati, anche i rumori diventano un lusso per l’immaginazione. Le ore di degenza sono scandite da drenaggi, visite dei medici, dosaggi e farmaci, ma la speranza di mettere qualcosa sotto i denti viene sempre rimandata.
Poi sei arrivata tu, Ersilia, un donnino con cui ho ho condiviso la stanza nei giorni di ricovero. Capelli bianchissimi e dritti come una spazzola rovesciata, da far invidia ad un adolescente punk. Dentro ai tuoi 87 anni, un sorriso garbato, ringiovanito da una bianchissima dentiera, con quei tuoi due occhietti vispi dietro la montatura dorata che ti dava un tocco vintage.
Ricordi? ci salutammo con un cenno del capo, rimandando la conoscenza a più tardi. Sapevi che ero appena stata operata. Te n’eri accorta subito per via dei riflessi rallentati. Ne sapevi eccome di ricoveri e di ospedali, molto più di quanto immaginassi, ma lo capii dopo.
L’infermiera ti sistemò il letto mettendo i vestiti nell’armadio. Quando mi svegliai del tutto tu invece ti addormentasti. Non era più orario di ricevimento e i parenti se ne erano andati. Chi tra i ricoverati aveva potuto farlo, aveva già consumato la cena. Io, con la fame che mi ritrovavo, avevo un assillante miraggio di fumanti tagliatelle col ragù. Piano piano, mente e corpo tornarono amici e guardai il groviglio di fili della flebo e del drenaggio. Ero incerta se assomigliavo di più ad una centralina elettrica o ad un palo della luce.
Sul tuo comodino avevi appoggiato un rosario di perline azzurre, la settimana enigmistica e una di quelle penne che -mi spiegasti poi più tardi con dovizia di particolari- usano i cruciverbisti, un compromesso fra la bic e la matita, con il gommino in cima al cappuccio. Ti guardavo in controluce mentre dormivi, avevi il respiro leggero di una bambina, ansimavi tenendo il risvolto del lenzuolo all’altezza del naso. Nel sonno non parlasti, forse non sognasti neppure, tossivi e facevi gnam gnam come se stessi assaggiando un lecca lecca. Assomigliavi a tutte le nonne belle del mondo.
Allungai lo sguardo oltre la finestra: il nulla, perché quell’ala dell’ospedale in cui eravamo ricoverate stava tra due torri di cemento. L’unica luce proveniva da un altissimo riflettore che faceva giorno anche quando era buio.
Ti svegliasti e mi salutasti. Tu, chiusa nel tuo pigiama con quelle minuscole giraffe, lanciate al galoppo nel tessuto come coriandoli su un corpo senza più rotondità, facevi tenerezza. Ai piedi, un paio di calze di lana sottile e ciabatte rosa. Ti infilasti la vestaglia bordeaux, venendoti a sedere sulla poltrona di fianco al mio letto. Cercavi un primo contatto e mi chiamasti per nome. La cosa mi sorprese poi capii che l’avevi letto sulla cartella clinica lasciata dall’infermiera. Mi chiedesti se avevo bisogno di qualcosa. Ti tranquillizzai. Cominciasti allora, e senza che te l’avessi chiesto, a parlarmi di te, dei tuoi acciacchi e della tua famiglia, di una vita spesa fra dolori, la perdita degli affetti più cari, un lavoro da contadina che ti aveva visto impegnata ogni giorno, dall’alba al tramonto, nei campi dietro casa, massacrandoti le spalle al punto da smettere di lavorare la terra, badando solo ai figli e alle amate galline, che regalavano uova fresche senza chiedere nulla in cambio. Mi raccontasti di tuo marito Luigi. So che, se la vostra vita avesse mai avuto un colore, sarebbe stato rosso come la rosa che avevi sfilato dal mazzo che tuo figlio ti aveva portato in ospedale e che, mentre ancora dormivo, avevi sistemato in un vaso improvvisato, tagliando a metà una bottiglia di plastica. Ti piaceva l’idea di farmela trovare al mio risveglio.
Mi raccontasti di tuo nipotino di cinque anni, dei suoi abbracci e delle insperate soddisfazioni. Mi dicesti che c’erano sere in cui ti chiamava al citofono e ti invitava a salire. Abitavate uno sopra l’altra. Apparecchiava sempre anche per te, mettendo il cucchiaio col manico azzurro a pois bianchi che ti piaceva tanto quando in tavola c’era zuppa di fagioli. Ti guardai mentre raccontavi e ti commuovevi, stringendo forte il rosario tra le dita.
Guardando il tuo profilo, mi accorsi che avevi l’apparecchio acustico e allora capii il perché del tono forte che usavi. Forse in quei momenti i tuoi racconti li avranno sentiti anche i ricoverati delle stanze vicine: pazienza, male non gli avrà fatto, perché le cose che stavi dicendo erano cose vere, vissute, piene di amore. La miglior medicina era ascoltarle.
Insieme abbiamo capito che le necessità fanno incontrare e il nostro dialogo continuò a lungo. Ti facevo domande, mentre la goccia della flebo scendeva, lentamente, lentamente, giocando all’infinito con la mia pazienza. Apprezzavi che qualcuno ti ascoltasse parlare. Eri rimasta vedova e avevi perso da poco anche l’unica sorella, cui eri legatissima. Mi mostrasti due santini chiusi nella bustina delle medicine sul comodino. Erano stropicciati e li lisciasti con le mani, coprendoli di baci. Il tono della tua voce era rotto dalla commozione.
Ti ricordi quando dalla porta della stanza spuntò il chirurgo che mi aveva operato per sentire come stavo? Complessivamente in risalita, gli dissi. Lui mi strizzò l’occhiolino e ti salutò e tu lo ricambiasti con prontezza e cortesia.
Là dentro le ore passarono lentamente come i tuoi passi, quando ti avvicinavi al letto per chiedermi come andava. Il mattino dopo provarono ad alzarmi, avevo bisogno di sgranchirmi gambe e braccia. Mi sedettero sul letto, ma la testa mi girava troppo. Mentre ti voltavo le spalle, sentivo i tuoi occhi fissi sulla mia schiena, uguali a quelli di una madre per la figlia.
Se la sente davvero di alzarsi? Mi domandò l’infermiera. Dondolai la testa per dire no, non riuscivo a fare altro, ero frastornata e debolissima. La voce di chi mi stava interrogando si faceva sempre più lontana e una cascata di sudori freddi mi aggredì schiena, collo e viso. Sto svenendo, tenetemi gente, tenetemi. Mi riadagiarono sul letto con le gambe sollevate. Nessuna preoccupazione, mi dissero che era naturale dopo l’intervento. Adesso si riposi e più tardi ci riproveremo. E tu sei rimasta a guardare, immobile, con le gambe a penzoloni giù dal letto. Quando mi ripresi, ti ringraziai e tu mi rispondesti che era il minimo che avresti potuto fare per me. Avere in stanza una persona più giovane ti faceva dimenticare tutti i guai. Ti chiesi perché ti avevano dimessa dal reparto geriatrico, trasferendoti al chirurgico, e tu mi rispondesti che avevano individuato uno strano alone scuro vicino al tuo colon e che dovevano fare ulteriori accertamenti. Tu avresti voluto tornare a casa, ma avevi deciso di restare per non creare trambusto ai tuoi familiari. Lo dicesti con tono rassegnato, privo di luce.
Da quel momento e per tutte le ore nelle quali rimanemmo insieme non sei più stata la stessa, perché cominciasti a parlare di te come di una povera persona, condannata a finire i propri giorni in ospedale, a non vedere più le tue galline. Ti commiseravi dicendo che la mia operazione, al confronto di quella che ti avrebbero dovuto fare, era stata niente e che dovevo ritenermi superfortunata. Che potevo dirti, cara Ersilia, incassavo e me ne stavo zitta, in fin dei conti avevi ragione. Piangevi ed eri preoccupata. Ti tornavano in mente le parole di tuo figlio “Mamma, la casa è vuota senza di te. Torna a casa al più presto”, come se dipendesse da te, con il risultato che parlavi ancora di te come di una povera vecchia, incapace di stare al mondo senza creare problemi e che avrebbero dovuto aiutare per sempre perché stavi diventando troppo distratta. Ti promisi che, appena fossi riuscita ad alzarmi da quel letto, saremmo andate a fare due passi nei corridoi del reparto, sognando i larghi viali parigini, giusto per distrarci un po’.
Poi parlammo di cucina e dei tuoi piatti forti. Quando più tardi entrò il chirurgo, ci sorprese mentre parlavamo di ragù, di carne buona da condire con un goccio di vino rosso. Ti chiese la ricetta perché la voleva dare alle ragazze del suo staff, accanite frequentatrici di Mcdonald’s, del tutto incapaci di tenere in mano un mestolo. Glielo promettesti immediatamente e il chirurgo ti strappò un sorriso. Mi disse che l’indomani mi avrebbero dimesso. Alla mia felicità non corrispose la tua, che ti facesti seria. Restare per te voleva dire che le cose non erano ancora iniziate, senza sapere cosa avrebbero potuto trovare dietro quell’ombra del colon e quando saresti tornata a casa da tuo nipotino.
Mi venne spontaneo abbracciarti, piccola come eri nel tuo pigiama di giraffe rosa e azzurre. Ti augurasti, nelle successive giornate di ricovero, di avere un’altra compagna di stanza come me, giovane e piacevole perché così -mi dicevi- ti ero sembrata fin dal primo momento. Ma continuavi ad essere preoccupata per l’esame che ti dovevano fare l’indomani. Quando arrivò l’infermiera, per provarti la pressione, ti trovò agitata e in lacrime. Allora la presi in disparte e le dissi che eri in ansia per l’esame in programma. L’infermiera capì la situazione, si avvicinò al tuo letto, spiegandoti con calma e professionalità in cosa sarebbe consistito l’esame, che era diverso dal precedente, meno invasivo. Ti avrebbero fatto una panoramica all’addome, nient’altro che una fotografia. Sembrava averti convinto e smettesti di piangere. Adesso che sapevi, eri molto più tranquilla.
Pienamente in forma e rifocillata, ti chiesi se avevi voglia di accompagnarmi a fare una passeggiata nei corridoi del reparto. Sulle prime dicesti di no, ma insistetti. Non puoi rifiutarti, perché con quella vestaglia e quelle babbucce rosa farai sicuramente innamorare qualcuno degli infermieri di guardia! Alla fine ti lasciasti convincere, ti presi sotto braccio e cominciammo la nostra passeggiata nei corridoi dell’ospedale, con la stessa eleganza di due demoiselles impegnate in una promenade sui Champs Elisées di Parigi. E la tua depressione sembrò svaporare. Trovammo il tempo di scherzare sulla circostanza. Ci fermammo di fronte alla macchinetta di bevande per fare la classifica di quelle più buone. Vincesti tu con l’Oransoda, di cui eri golosa. Mi confessasti che ne bevevi una di nascosto con tuo nipotino, quando lo andavi a prendere da scuola.
Tornammo in stanza per prepararci per la notte. Tu non avevi sonno ed uscisti. Mi sembrò strano perché da quando ci eravamo conosciute, cara Ersilia, non avevi mai messo naso fuori dalla porta. Ti chiamai, ma non ti fermasti, riuscii però ad intravvedere nell’espressione del viso di nuovo quella luce spenta, figlia della depressione.
Ti ricordi quanto fermento c’era stato quella sera in reparto? Ricoverarono anche un uomo in fin di vita. Tu tardavi a rientrare in stanza e non ero affatto tranquilla, ma non volevo creare problemi agli infermieri, che vedevo assorbiti nel soccorso, perciò non li chiamai. Mi rimisi in verticale, indossai la vestaglia pensando dove venirti a cercare. La struttura ospedaliera aveva ballatoi esterni in ogni piano, che si affacciavano per molti metri di altezza sui parcheggi sottostanti, dove solitamente andavano a fumare. Ti assicuro, Ersilia, che in quel momento mi assalì un pensiero pesantissimo, rivedevo quel velo di depressione sul tuo viso, di chi non vede più futuro davanti a sé.
Uscii dalla stanza e cominciai a sbirciare in quelle vicine, pensando che magari potevi essere andata lì a dare la buonanotte a qualche altro ricoverato, ma non ti trovai e pensai al peggio. Ersilia dove sei, non fare sciocchezze. Mi allungai verso la macchinetta delle bevande, niente. Tornai indietro accusando ad ogni passo sempre più stanchezza, sentivo i punti tirare, le gambe deboli. Mi allungai fino alla sala d’attesa del reparto con la porta semichiusa. Eri lì, Ersilia, eri lì, seduta sulla poltrona rossa, che guardavi la televisione. Sprofondata nei cuscini, emanavi una dolcezza che ti restituiva bambina ai miei occhi e ai tuoi anni. Non ti disturberò pensai, tirando un dannato respiro di sollievo.
Tornai in camera scivolando sotto le lenzuola con movimenti impacciati e qualche dolore in più. Ritornasti dopo neanche dieci minuti, silenziosissima. Non le racconterò che mi ha fatto preoccupare pensai e feci finta di dormire. Ti sfilasti la vestaglia, tuffasti la dentiera nel bicchiere ed entrasti nel letto. La luce del corridoio era già stata abbassata e tu non ti accorgesti che ti stavo guardando. Cominciasti a sussurrare qualcosa, a bassa voce, sotto il lenzuolo. Sul momento non riuscii a decifrare nulla, poi catturai al volo una frase familiare: “…angelo santo vegliami accanto… copri con le ali ..salva dai mali…nel suo lettino il tuo bambino…” . Stavi recitando le preghiere, più tardi riconobbi l’Ave Maria, il Padre Nostro e un cantilenante Eterno riposo, che chiuse il tuo bisbigliare. Nella stanza calò il silenzio, interrotto solo dal tuo stanco respiro. Al mattino sostenevi di non aver chiuso occhio e di essere andata dentro e fuori dal bagno. In realtà avevi dormito molto più di me. Mi sembrasti rilassata.
Arrivò il momento delle mie dimissioni. Ero pronta e rivestita, senza più fili di flebo. Ti salutai con un abbraccio, lasciandoti alle parole crociate, seduta sul tavolino mentre bisbigliavi le domande e anticipavi le risposte riempiendo con la matita magica le caselle vuote del cruciverba.
Chissà se tuo nipotino questa sera apparecchierà la tavola anche per te, mettendo il cucchiaio col manico azzurro che ti piace tanto quando in tavola c’è zuppa di fagioli? Sono sicura che lo farà, aspettando l’Oransoda. Contaci, cara Ersilia.
Ti abbraccio forte.
Costanza