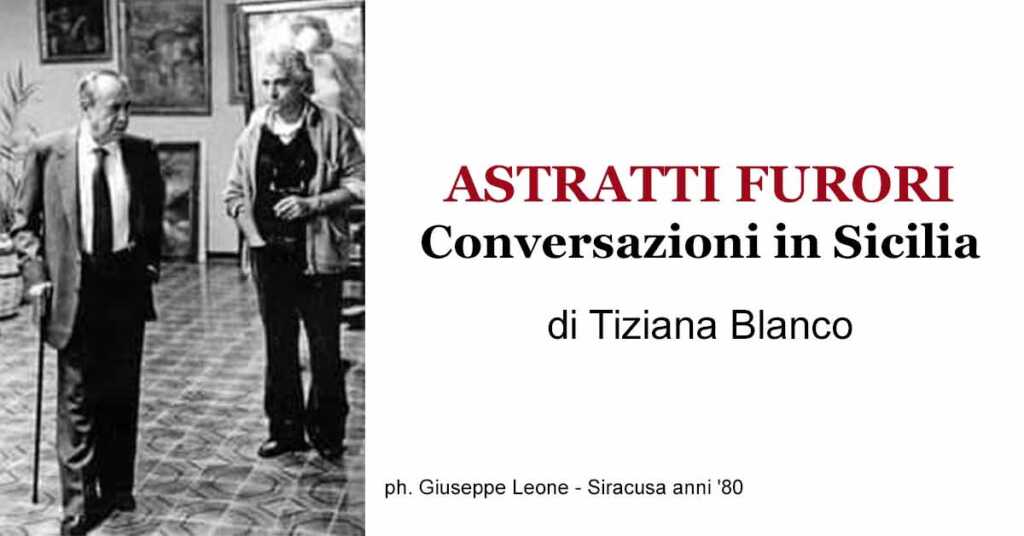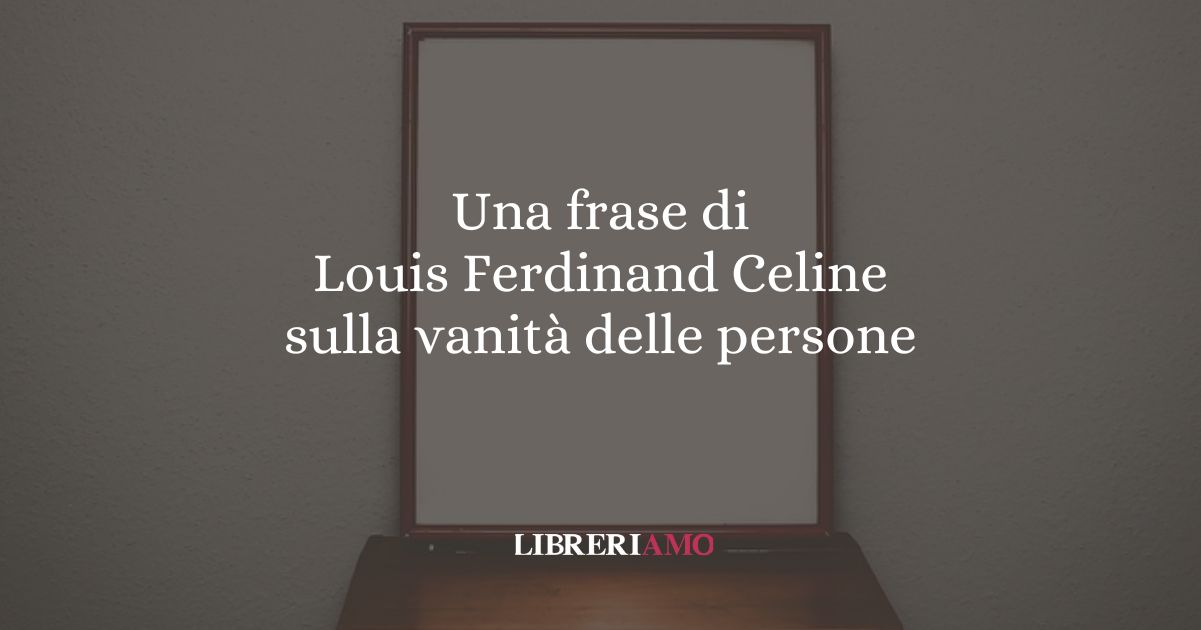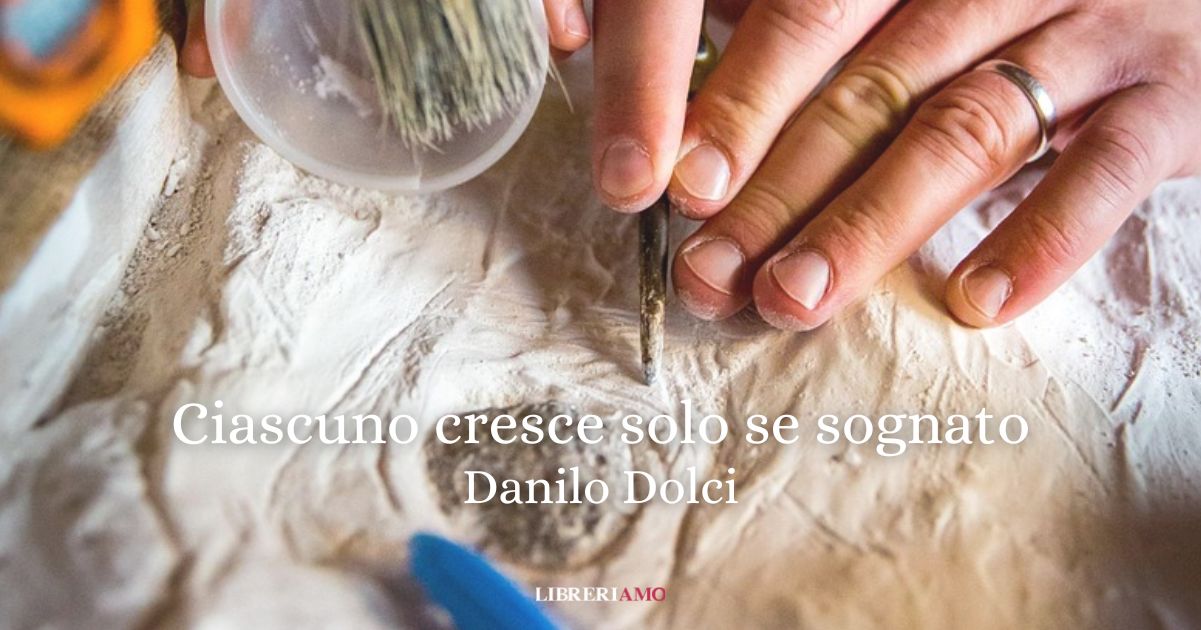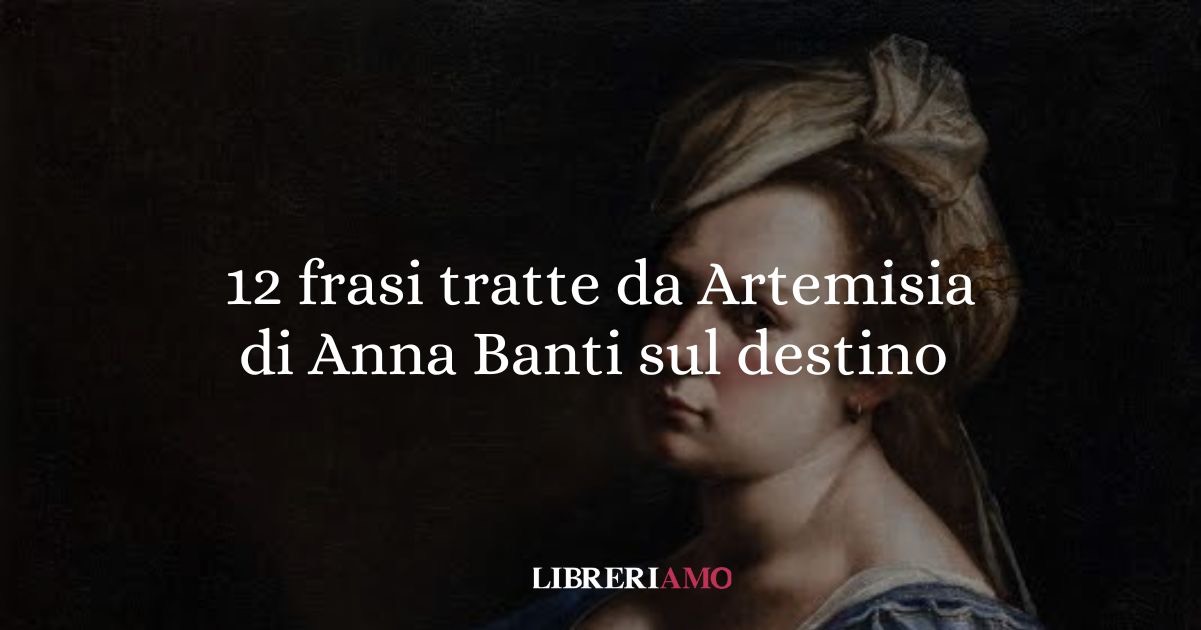Gaetano Tranchino, classe 1938, nasce a Siracusa. Fatta eccezione per le fughe più o meno lunghe per studio, vacanza, mostre sue e di altri artisti, ritorna sempre nella sua città d’origine. Ad Ortigia per l’esattezza, l’isola nell’isola.
Io e Tranchino siamo due dilettanti. E forse appunto da ciò nasce l’attenzione, il sodalizio, l’amicizia che ci lega: dal reciproco riconoscerci dilettanti, proprio nel senso di chi si diletta. E non che il dilettarsi escluda la ricerca, l’inquietudine, il travaglio, il guardarsi dentro a volte con sgomento e il guardar fuori con prensile attenzione e a volte avidamente: ma in una sfera sempre di divertimento, di gioco esistenziale.
Un gioco in cui ha gran parte la memoria, il suo trasmutarsi o mutarsi in mito, favola, ad avvertimento del presente.(L.Sciascia)
Ed è proprio lo stendhaliano rifiutare la noia, la banalità e dilettarsi della vita a cui faceva riferimento Leonardo Sciascia che segnerà tutto il percorso lavorativo ed esistenziale del pittore Tranchino.
Vi abita serenamente, ma rivive i suoi miti lontani e quelli dell’infanzia: tra mare e campagna, nei dissepolti splendori di una civiltà incomparabile. Senza inquietudini che non siano quelle della ricerca, dell’approfondimento e perfezionamento dell’arte sua: sereno, appagato, senza nessuna ansietà ed affanno ad inseguire la notorietà, il successo. (L. Sciascia)
Gaetano Tranchino, il pittore letterario
La sua produzione pittorica può richiamare lo stile naif di Rousseau, la metafisica di De Chirico e Savinio, il surrealismo di Magritte, o ancora i temi realisti di Hopper. Tutti artisti che ha senz’altro studiato ed amato molto. Tuttavia la sua idea di pittura si è nutrita soprattutto di riferimenti letterari, Borges e Conrad in testa. Arte e lettura danno quindi luogo ad un personalissimo racconto di vita: immagini che coniugano l’essere e l’apparire.
Tranchino avrà fatto i suoi “latinucci”, le sue prove, i suoi sperimentalismi; avrà cercato, rifiutato, scelto, ma è infine approdato a una pittura sua, originale, coerente, sicura. Una’ recherche’ siciliana. Una pittura europea. (L.Sciascia)
Ed ancora Franco Russoli, critico d’arte, nel 1964 scrisse che Tranchino non è un ennesimo caso di pittore naif ma un vero artista che entra nel panorama delle nuove ricerche di figurazione.
L’incontro con Gaetano Tranchino
Un artista a tutto tondo, un purista. Mi riceve nel suo studio: maglietta blu semplicissima, chioma bianca un po’ arruffata, colori, tele e pennelli disseminati qua e là in un ordinatissimo disordine. Lì si lavora, ogni giorno, ci si sporca le mani, ma solo quelle: l’anima resta candida come quella di un bimbo.
Trovo che Tranchino sia capace, come pochi oggigiorno, di trasportarci in luoghi d’incanto e meraviglia. Luoghi che ignorano il dio Crono e che vengono espressi come in un racconto non scritto, narrato, bensì egregiamente dipinto. Scorrendo le opere presenti nei suoi cataloghi si susseguono scene legate le une alle altre in un ininterrotto filo dello sguardo. Uno sguardo il suo sempre pronto a catturare i sogni, perché i sogni non finiscono mai.
Incontrandolo di persona, avendolo ascoltato, scrutato, ho avuto la netta sensazione che quando lui entra nel suo studio (che pur avendo accesso direttamente dalla strada tiene chiuso) pare si voglia lasciare alle spalle l’ordinarietà del quotidiano. Lui lì con la sua arte, le sue tele, i suoi pennelli e il mondo fuori.
Nei suoi dipinti troviamo un mondo semplificato, dai colori accesi e decisi, nel quale ad esempio gli aerei e le macchine sembrano giocattoli. Non importa si riconosca il modello di automobile raffigurata ma è il concetto che conta, il mezzo che porta dove deve portare, sia esso di lusso o no.
Una certa leggerezza, se vogliamo, nel vedere la vita che non è superficialità ma, come diceva Italo Calvino è planare sulle cose dall’alto. La realtà che si fonde egregiamente con la fiaba in una dimensione trasognata, in cui vengono sovvertite le regole dello spazio e del tempo. Memorie infantili, ironia a tratti malinconica, il tempo percepito da chi osserva come una sorta di personalissimo flusso di coscienza, misurabile in senso soggettivo. Potrebbe infatti espandersi e contrarsi in base alle esperienze individuali. Non sense, elementi incongrui tra loro nella tela, difficilmente coniugabili nella realtà, ma che lì si fondono e convivono come lambiti da un incantesimo. Un mundus imaginalis in cui tutti vorremmo perderci.
Si ha come la sensazione che l’artista voglia abbandonare l’apparenza esterna o naturale che racchiude le realtà interiori o nascoste, come la mandorla è nascosta nel guscio. Il dove si trova al suo interno, un luogo al di fuori dello spazio, in un non luogo.
Questa è a mio avviso la ricerca dell’essenza di Tranchino, il saper togliere elementi superflui e donarci vibranti emozioni.

In dipinti come Quasi Niente (2004), ad esempio, troviamo un uomo che studia, riflette, che tenta di dare risposte.
Molto ricorrente nella sua produzione. Figure umane senza occhi-bocca-orecchie che non possono interagire col mondo. Una sintesi drammatica della difficoltà che spesso tutti noi proviamo nel comunicare col prossimo. Rimandi celati ad un passato intriso di una raffinata gentilezza che vorrebbe insegnarci qualcosa incurante del fatto che potrebbe non riuscirci.
Sul libro poi…anche il libro è una cosa, ma se lo apri e leggi diventa un mondo (L. Sciascia)
L’intervista a Gaetano Tranchino
Ultimamente alla mostra di Ferdinando Scianna a Milano, a Palazzo Reale, in una sezione dedicata a Leonardo Sciascia ho scorto tra i vari scatti alcuni con lei presente. Si percepivano una certa familiarità e complicità. Ma come nasce l’amicizia con Sciascia?
Siamo nella metà degli anni sessanta e lui era già uno scrittore famoso, grazie a Il giorno della civetta, A ciascuno il suo ed altri, pubblicati tra il ’61 e il ‘66. In casa avevamo tutte le prime edizioni dei suoi scritti. Peccato siano poi andate perdute.
Leonardo vide un giornale con la foto di un mio quadro riguardante una mostra che facevo in quel periodo e volle conoscermi. Un giorno infatti, tramite lo scrittore comune amico Natale Tedesco, vennero a trovarmi con Dominique Fernandez, uno scrittore francese che passava le estati nella sua villa a Pachino, e alcuni ragazzi della Rai.
Il mio primo studio era all’interno della villa di mio nonno che era stata trasformata e ampliata per poterci vivere e lavorare. Lui non era uno che parlasse tanto, io nella mia emozione parlavo ancora meno, però la cosa bella era che non c’era bisogno di tante chiacchiere; si creò da subito una certa intesa. Lo spessore di Leonardo, la qualità della persona, la sensibilità erano particolari. Andavo a trovarlo spesso a Palermo, oppure in campagna alla Noce, dove lui passava l’estate.
Il nostro è sempre stato un rapporto di stima reciproca, ma soprattutto per me era un riferimento. E’ sempre stato un’indicazione in tante cose, intanto nella scelta delle letture, anche se lui non era il tipo che ti diceva ‘’leggi questo libro’’. Le sue conversazioni, le sue disquisizioni, avevano sempre dei riferimenti che citavano un certo testo e a quel punto a me veniva poi naturale andarmelo a cercare. Quello è stato il modo in cui veramente io mi sono arricchito.
C’è la famosa frase di Sciascia ‘’ io non leggo, rileggo’’
Verissimo, e questo è stato un grande insegnamento perché devo dire che non per mera imitazione ma per constatazione di cos’è la lettura e la grandezza della letteratura, mi sono col tempo reso conto che è proprio la rilettura quella che ci dà la misura vera.
E’ facile che un artista si ritrovi nella letteratura. Vive certe emozioni e vibrazioni continue che non riesce a chiarire nemmeno a se stesso. Solo con la ricostruzione di certe immagini si riconosce.
Da poco ad esempio ho finito di rileggere un testo che avevo letto dieci anni fa, ebbene l’ho scoperto e rivalutato totalmente. Di certo in virtù del fatto che in questi dieci anni io abbia aggiunto delle conoscenze e sensibilità varie, tali da farmelo apprezzare ancor più di allora.
Quando nomina Leonardo Sciascia le brillano gli occhi, cosa ha amato di quest’uomo?
Io mi ritengo un privilegiato. Aver conosciuto e frequentato per circa vent’anni una persona della levatura di Leonardo non può non esser stata una grande fortuna. Ritengo sia stato uno degli scrittori più grandi del ‘900, e per molti di noi che ne abbiamo letto ogni rigo, una guida in mezzo a un labirinto, un diletto per la mente.
Comunque, potrà sembrare strano, ma lui c’è sempre, è come se fosse vivo perché è nei suoi scritti, soprattutto nei saggi. Io infatti, quando gli amici mi chiedono cosa leggere di Sciascia dico loro di soffermarsi a leggere e rileggere i saggi. Lui è più noto per i romanzi, ma Cruciverba, Nero su nero, La corda pazza, Fatti diversi di storia letteraria e civile, etc. sono l’esatta essenza di quello che lui realmente pensava e diceva nella vita di tutti i giorni; lì c’è tutto il suo spessore intellettuale. Chi vuole conoscerlo a fondo, a mio modesto parere, deve quindi analizzare i suoi saggi.
Avendolo conosciuto bene, quando legge un suo libro sa cosa avrebbe detto e cosa avrebbe pensato in determinate situazioni. Sente echeggiare nella mente le diverse intonazioni della voce o ne immagina le espressioni del volto.
Sì certo, ma non sempre, non per tutto, perché lui era capace di sorprendere sempre. Aveva la grande facoltà di intelligere, di leggere dentro l’apparenza delle righe del discorso che stava dietro, cosa stava nascondendo, e trovava la verità quella vera, al di là di quella apparente. Oggi, o forse è sempre stato così, viviamo a contatto di verità apparenti mentre la verità vera ci spaventa e forse siamo noi i primi a far finta di non vederla.
Certo il dolore è nel non potere chiedergli più niente, non potere sentire una sua opinione sulle cose che sono venute dopo e che lui forse ha intuito prima. Manca tantissimo. Ma io lo tengo sempre vicino, ho sempre un suo libro sul comodino, praticamente come il breviario per il prete.
Mi accennava a questi incontri d’estate nella sua casa di campagna alla Noce, vicino Racalmuto: chi eravate di solito?
Allora, tengo a precisare che il gruppo era molto ristretto, in quanto lui amava circondarsi di amici sinceri e disinteressati coi quali disquisire, ovviamente, di libri. Quando c’ero io di solito c’erano anche Gesualdo Bufalino e Ferdinando Scianna, tutti con le rispettive signore.
Oggi vedo in televisione gente che vanta grandi frequentazioni con Leonardo, ma non credo siano reali.
Si è sempre parlato delle sue doti culinarie, lui infatti diceva sorridendo ‘’non faccio niente senza gioia’’. Ho letto che le pietanze che preparava spesso erano le uova con il pomodoro, il rognone al Cointreau e un sugo particolare all’aragosta. Di fondamentale importanza era non ritrovarsi in 13 a tavola. Ricorda un suo piatto in particolare?
Del tredici sì, eccome. Ci raccontò di un suo amico morto a Roma dopo aver cenato la sera prima in tredici. Noi infatti non superavamo mai la decina di persone. Una volta ci preparò una pasta squisita al sugo di asparagi selvatici, raccolti da lui in campagna. Ricordo come fosse ieri che mia moglie gli chiese come avesse preparato quel sugo e lui, con il suo sorriso sornione le disse: ‘’l’ho sorvegliato’’.
C’è una sua frase che le è rimasta scolpita nella mente?
Un pomeriggio, eravamo seduti nel suo studio, a Palermo, lui al solito non è che parlasse tanto, fumava. Ad un certo punto, tra una lenta boccata e l’altra, spezzò il silenzio con un ‘’mah!’’(lui era quello di grandi mah), ‘’pensa Gaetano: fra cinquant’anni sarà come se non fossimo mai esistiti!’’
Io gli risposi che forse tutti noi correvamo il rischio della polverizzazione, ma non lui!
Di Bufalino invece che ricordo ha?
Di una persona deliziosa, estremamente colta e sensibile.
Grande amico di Leonardo, si confrontavano su mille argomenti, dalla politica ai temi esistenziali; ma i libri erano sempre al centro dei loro discorsi. So che ne parlavano anche in interminabili telefonate.
Credo avessero letto tutto, o ci mancava poco. Ed io non potevo non venir totalmente rapito da tanto sapere.
Apprendere della sua morte in un incidente stradale mi colpì molto. Allo stesso tempo però, per la nettezza e la rapidità del modo, mi son detto che è stato meglio così rispetto ad altre morti lunghe e dolorose.
Lei è stato spesso definito naif, con riferimenti a Henri Rousseau, ma io vedo anche molto altro. Nei suoi quadri oltre a quel quid di fiabesco e onirico, si evince tanta riflessione dietro, una vera indagine introspettiva.
Sì senz’altro, ma vede, Rousseau è molto più interessante e profondo di come appare a prima lettura. Mi piace molto e magari c’è davvero una certa assonanza tra noi.
Io alle catalogazioni credo poco, la pittura è una cosa molto intima, difficile, molto egoistica, privata, personale, quindi alla fine ogni cosa che si fa è una sorta di autoritratto. Questo lo diceva anche Guttuso, ‘’anche se disegno una mela è un autoritratto, ci sono dietro io e la mia Sicilia’’. La pittura è un mezzo molto strano e complesso. Amo follemente Francis Bacon, come anche Pollock, Hopper, Paolo Uccello, Botticelli, De Chirico, Rembrant, ma poi alla fine dipingo a modo mio. Ad ognuno il suo stile.
Cerca qualcosa in particolare nel dipingere?
Per me il mezzo di espressione è la pittura, alla fine quello che cerco è che sia identica a me stesso, valuto le scelte e le varie soluzioni affinché sia il più possibile simile a me stesso. Lungi da me lanciare messaggi o dare indicazioni. Cosa significa questo non lo so nemmeno io e non voglio saperlo. Devo essere soddisfatto io in primis.
Io credo che l’espressione più importante di quella che è la nostra cultura, le nostre idee, le possiamo ritrovare nella letteratura perché lì l’idea viene messa perfettamente in chiaro, scritta nero su bianco.
Nella pittura invece c’è un accenno, c’è una indicazione, ma sempre molto vaga; c’è molto del non detto.
Incredibile come la sua curiosità e la voglia di sperimentare sempre cose nuove, per diletto appunto, l’abbiano portata a Parigi per imparare la tecnica dell’acquaforte, a Venezia per lavorare il vetro, per poi continuare con la pittura, l’incisione e persino la fotografia. Tutto come se fosse un gioco nuovo da imparare. Il pascoliano fanciullino è in lei anche oggi. Vero?
Sì, verissimo, io spero sempre che da grande farò qualcosa di buono!
Forse perché il mio è un lavoro che si fa con le mani e allora è estremamente gratificante, non so.
Il lavoro frutto delle proprie mani è per l’uomo una grande gratificazione. Adesso per esempio mi piace anche incidere, ultimamente sto realizzando delle xilografie, sul legno, ed è davvero entusiasmante.
In quel frangente le mani lavorano e la mente inventa dei mondi che cercano di passare attraverso le mani in una maniera assolutamente non programmata, e non c’è un meccanismo, uno schema, c’è un susseguirsi di sensazioni. Quelle piccole scelte che si fanno in corso d’opera (mai niente è casuale) sono volute, anche se apparentemente casuali vengono comunque vagliate. Alla fine tutto ha il suo piccolo significato.
Una cosa che mi manca è un corso di grafia giapponese, se trovassi dove farlo…
La nave sta a Tranchino come la ballerina sta a Degas o l’orologio molle a Dalì…
Le sue opere sono immediatamente riconducibili all’autore, sia per la tecnica che per i colori, ma la nave, leit motiv nei suoi quadri, è davvero ciò che più la rappresenta.
Come mai proprio la nave?
Innanzitutto perché amo molto il mare. Vivo in una città circondata dal mare e fino a qualche anno fa ho anche avuto una barca a vela. Uscire da solo e ascoltare il silenzio in mare aperto è meraviglioso.
Le navi invece hanno iniziato ad interessarmi negli anni ’70, le vedevo ormeggiate alla marina, enormi, gigantesche, e fantasticavo. Mi affascinavano. Non saprei neanche spiegare il perché di tanto interesse, è un mezzo che ti contiene, ti porta e ti riporta. Ma anche gli aerei, le automobili. E’ sempre un viaggio, che sia di andata o di ritorno, di evasione o no, poco importa.
Riflettendo sull’amicizia tra lei, Bufalino, Scianna e Sciascia, verrebbe da pensare che tutti e quattro avete avuto una cosa in comune: raccontare storie. Chi con le parole, chi con le immagini, siano esse congelate da un obbiettivo fotografico o da pennelli, il fine ultimo era il medesimo. Cosa ne pensa?
Forse è davvero così, nel senso che ho sempre pensato di voler fare letteratura con la mia pittura, raccontare storie. Progetto molto ambizioso, lo ammetto, ma molti mi dicono che ci riesco, io non lo so per certo. Comunque ci provo e mi diverto.
In un film ad esempio cerco sempre le scene con poco dialogo, mi piace che siano le immagini a parlare.
A degli studenti che studiano arte cosa consiglierebbe?
Gli direi una cosa soltanto: leggete e rileggete!
Tornando a Sciascia, e all’epitaffio che scelse per la sua tomba ‘’Ce ne ricorderemo, di questo pianeta’’. Disse di aver così partecipato alla scommessa di Pascal, cioè che se Dio esiste, si ottiene la salvezza, se invece non esiste, si è vissuto un’esistenza lieta pur nella consapevolezza di finire in polvere.
E lei maestro, crede in Dio e in una vita oltre la vita?
No, io penso che quando si spengono le luci finisca tutto e Dio…
Dio brilla per la sua assenza!
[ngg src=”galleries” ids=”46″ display=”basic_slideshow”]
Questa rubrica darà occasione a quei siciliani che si muovono nell’ambito culturale, vivendo nella loro terra o altrove, di raccontarsi e mostrare quella sfera privata fatta di incontri, ricordi, famiglia, letture, viaggi, riflessioni. Delle chiacchierate con scrittori, musicisti, giornalisti, pittori, fotografi, che hanno dato e hanno voglia di continuare a dare ancora tanto alla loro Sicilia, se pur tra mille ostacoli…
E se Elio Vittorini in Conversazione in Sicilia con la sua ‘quiete della non speranza’ scriveva:
‘’Ero in preda ad astratti furori. Ero come se non avessi mai saputo che cosa significa esser felici, come se non avessi nulla da dire, da affermare, negare, nulla di mio da mettere in gioco, e nulla da ascoltare, da dare …” a me piace ribaltare quella visione. Darò a quei furori un’accezione squisitamente positiva, tramutando quel concetto negativo in un acceso impalpabile fermento, intangibile ma vivissimo in molti di noi e intorno a noi.
La Sicilia è stata per molti secoli uno dei luoghi di nascita del pensiero, della scienza e dell’arte, in una parola: della cultura dell’occidente. Ma anche luogo di incontro e di scambio di questa cultura con quella di civiltà diverse. Alla corte del re Federico II di Svevia, a Palermo, si ebbe una fioritura culturale mai vista prima.
L’elenco di coloro che dall’inizio del novecento in poi hanno portato la Sicilia nel mondo, da Pirandello a Guttuso, da Tomasi di Lampedusa a Zichichi, sarebbe lunghissimo e pleonastico.
Bertolt Brecht asseriva che Tutte le arti contribuiscono all’arte più grande di tutte: quella di vivere. Ed io aggiungerei e quella di raccontare ciò che si è vissuto…
Tiziana Blanco è nata a Siracusa nel 1968. Ha studiato fotografia allo IED di Roma e da un trentennio si occupa di fotografia a trecentosessanta gradi. Ha iniziato come fotoreporter per il Giornale di Sicilia, ha insegnato sei anni teoria e tecnica della fotografia all’Accademia di Belle Arti “M.Minniti” di Siracusa e realizzato delle mostre tra Ragusa, Siracusa, Venezia ed Emirati Arabi.
Una fotografa con la passione della scrittura e la letteratura noir d’oltralpe.
La curiosità è il focus del suo mondo, osservare quanto la circonda e raccontarlo con le immagini o con le parole, anzi le ‘conversazioni’.