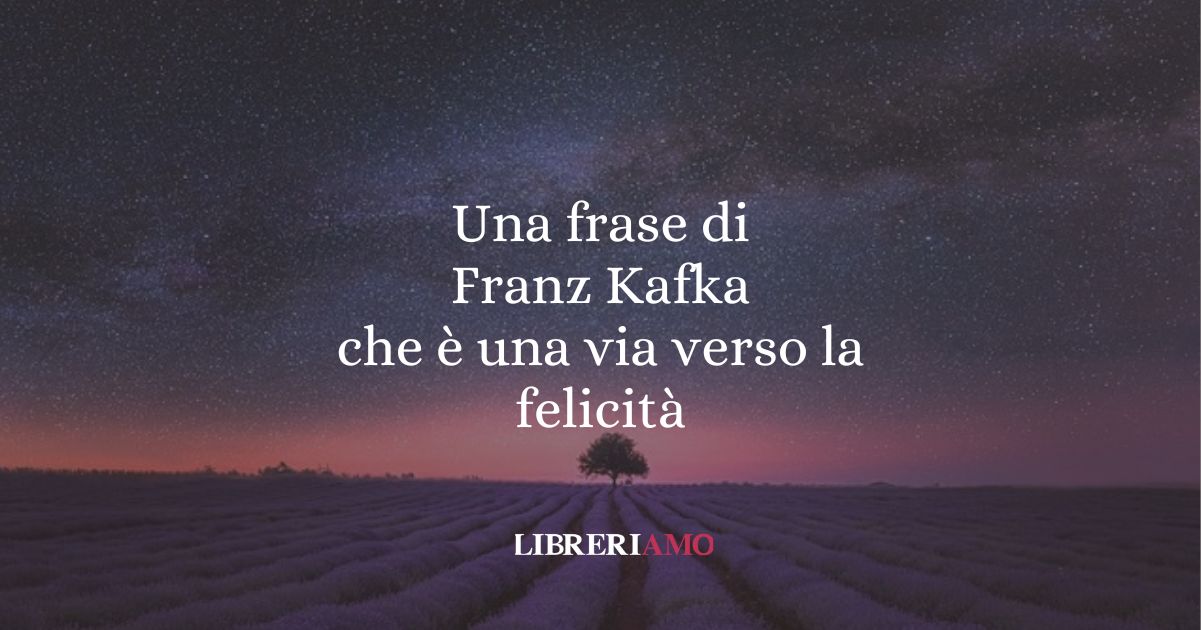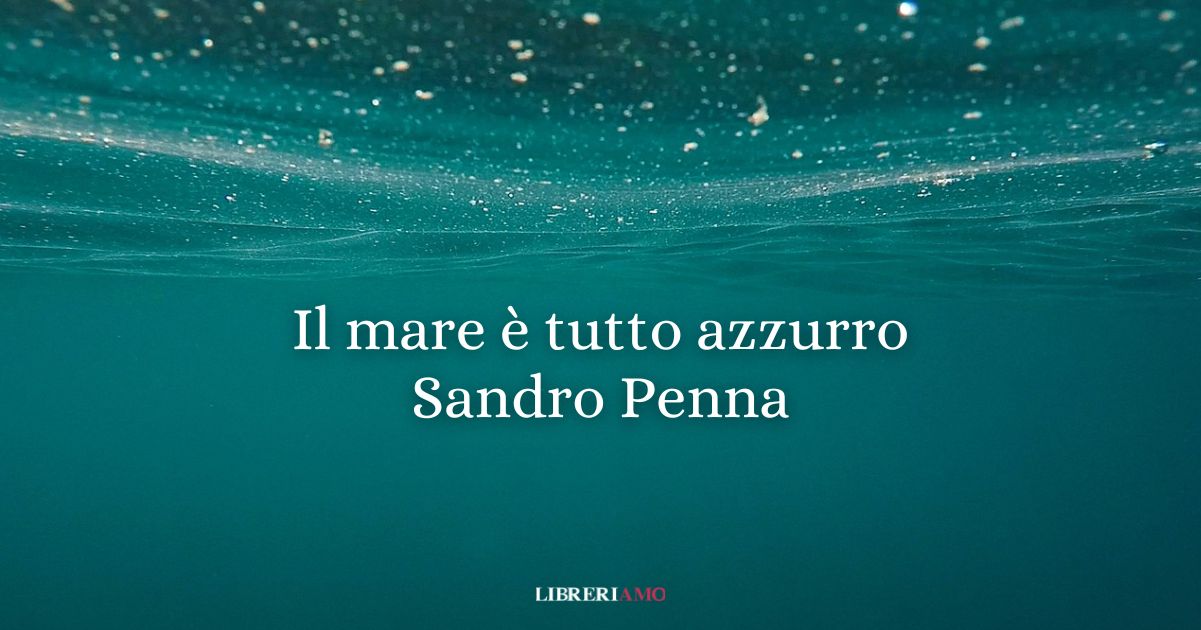“Giuditta decapita Oloferne” è uno dei quadri di Artemisia Gentileschi , artista simbolo dell’emancipazione femminile nell’arte e nella società che nelle sue opere ha voluto sempre celebrare l’indipendenza e la forza delle donne in un’epoca (sia quella rappresentata nel quadro, sia quella in cui visse l’artista) dominata da uomini.
Nel dipinto oggi esposto al Museo degli Uffizi (1620 circa), Artemisia Gentileschi affronta il momento dell’uccisione di Oloferne per mano di una determinata e vigorosa Giuditta che, con astuzia, riesce a farsi ricevere nell’accampamento di Oloferne, farlo ubriacare fino a tenerlo in sua completa balìa. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Giuditta decapita Oloferne
Giuditta, una giovane ebrea di Betulia, commenta con queste parole il suo coraggioso gesto narrato nella Bibbia, che portò alla liberazione di Israele dall’assedio dell’esercito di Nabucodonosor: “Dio lo ha colpito per mano di donna”. Giuditta si presentò al campo del crudele Oloferne, comandante dell’esercito nemico, vestita con i suoi abiti migliori e fingendo di volersi alleare con lui. Oloferne, affascinato dalla bellezza di Giuditta, la invitò a un sontuoso banchetto nella sua tenda. Dopo aver mangiato e bevuto, il generale assiro, ubriaco, si addormentò nel suo letto, offrendo così a Giuditta l’opportunità di prendere la sua scimitarra e infliggergli un colpo mortale.
Nell’imponente dipinto degli Uffizi (circa 1620), Artemisia Gentileschi raffigura il momento in cui Giuditta uccide Oloferne con determinazione e forza. L’effetto complessivo del quadro è impressionante e terrificante: il corpulento generale, ubriaco e sdraiato sul letto, viene afferrato per i capelli mentre la spada di Giuditta penetra nel suo collo. Artemisia non esita a mostrare dettagli cruenti come il sangue che schizza copiosamente fino a macchiare il petto della stessa Giuditta.
Artemisia Gentileschi e la sua Giuditta
Il dipinto fu completato a Roma, dove Artemisia era tornata dopo sette anni a Firenze. A Roma, poté riprendere contatto con le opere di Caravaggio. La rappresentazione, con la sua cruda e naturalistica “virilità”, suscitò reazioni severe quando fu inviata a Firenze, impedendo al dipinto di ottenere una collocazione di rilievo nella Galleria. La pittrice riuscì a ottenere con grande difficoltà il compenso precedentemente concordato dal Granduca Cosimo II de’ Medici, morto nel 1621 subito dopo il completamento della grande tela, grazie all’intervento dell’amico Galileo Galilei.
Il dipinto fu controverso per la sua rappresentazione realistica e cruda della violenza. La difficoltà di ottenere il compenso e la mancanza di una collocazione di rilievo nella Galleria riflettono le difficoltà che le artiste donne affrontavano in un mondo dominato dagli uomini, ma al contempo, pur vivendo in un’epoca così proibitiva, riflettono una realtà che pure esistette, ovvero quella in cui donne forti cercavano di sottrarsi all’ottuso dominio degli uomini.
Artemisia Gentileschi
Artemisia Gentileschi (Roma, 8 luglio 1593 – Napoli, 1653 circa) è stata una delle pittrici più notevoli e influenti del Barocco italiano. Nata in una famiglia di artisti, era la figlia di Orazio Gentileschi, un pittore affermato che la introdusse all’arte e le trasmise la tecnica della pittura.
Artemisia Gentileschi mostrò presto un talento straordinario e iniziò a lavorare nel laboratorio del padre, imparando i segreti della pittura a olio e della prospettiva. La sua formazione fu influenzata dall’incontro con Caravaggio e dallo studio del suo stile drammatico e realistico. A soli 17 anni, dipinse “Susanna e i vecchioni” (1610), un’opera che già mostrava la sua abilità nel rappresentare la figura umana e nel trasmettere emozioni intense.
Nel 1612, Artemisia fu vittima di uno scandalo quando fu violentata dal pittore Agostino Tassi, amico e collaboratore del padre. Nonostante la brutalità dell’esperienza e il processo pubblico che ne seguì, durante il quale Artemisia fu sottoposta a torture per verificare la sua testimonianza, riuscì a emergere come una figura resiliente e determinata.
Dopo il processo, Artemisia si trasferì a Firenze, dove continuò la sua carriera artistica e ottenne il supporto di importanti mecenati, tra cui Cosimo II de’ Medici. Fu la prima donna a essere ammessa all’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Durante questo periodo, realizzò opere significative come “Giuditta che decapita Oloferne” (circa 1620), un potente quadro che riflette il suo vissuto personale e la sua capacità di esplorare temi di violenza e vendetta con profondità emotiva.
Artemisia Gentileschi tornata a Roma nel 1620, continuò a dipingere opere commissionate e a mantenere contatti con figure influenti come Galileo Galilei. Successivamente, si trasferì a Napoli, dove la sua carriera prosperò ulteriormente e divenne una delle pittrici più richieste. In questo periodo realizzò molte delle sue opere più celebri, continuando a esplorare temi mitologici e biblici con uno sguardo unico e una tecnica impeccabile.