Contro l’ansia da Intelligenza Artificiale bisogna tornare a “sporcarsi le mani”
Il malessere che genera l’intelligenza artificiale non è stanchezza: è astinenza da realtà. Richard Sennett aveva previsto la scissione tra mente e corpo.
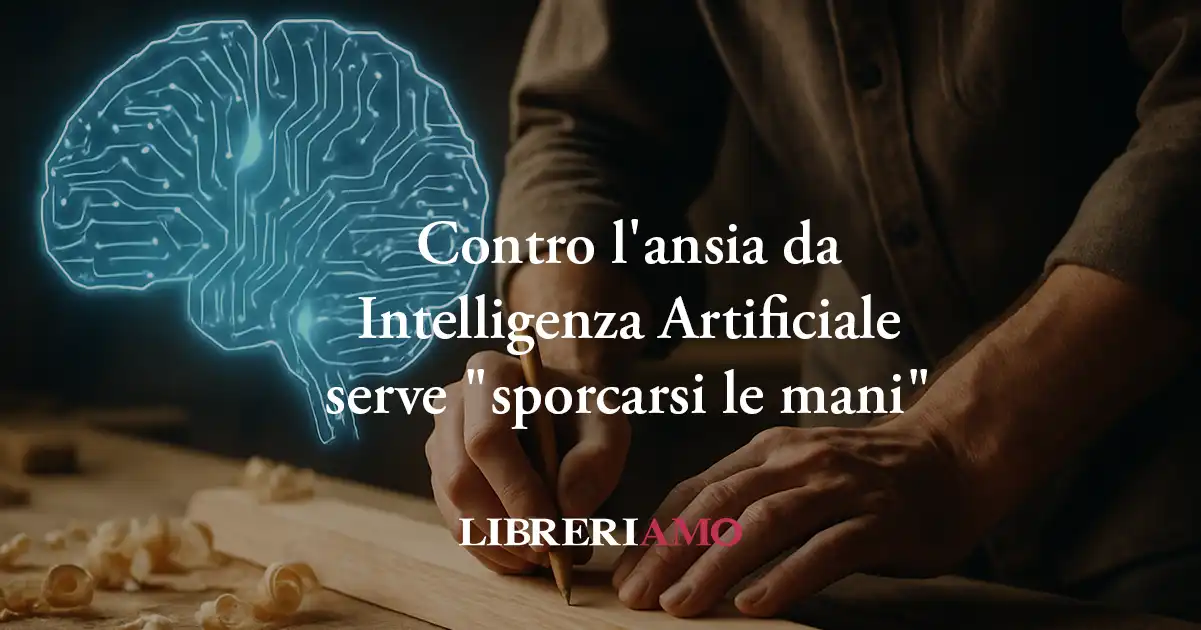
L’Intelligenza Artificiale ha promesso alla società contemporanea il risultato senza lo sforzo. Immagini perfette generate in un secondo, testi complessi elaborati senza digitare e soluzioni immediate a problemi intricati. Eppure, in modo apparentemente paradossale, i dati sulla salute mentale tracciano una curva opposta. Nell’era della massima facilità tecnologica, i livelli di ansia, senso di vuoto e stress percepito toccano i massimi storici.
La domanda sorge spontanea e riguarda il motivo per cui l’essere umano si senta così svuotato proprio nel momento in cui è diventato più produttivo. La risposta non va cercata nell’algoritmo, ma nella profezia sociologica di Richard Sennett, presente nel suo libro The Craftsman (L’uomo artigiano – 2008) a lungo ignorata che oggi trova piena conferma nella biologia.
L’avvertimento di Richard Sennett e la necessità di sporcarsi le mani
Il monito lanciato dal sociologo americano Richard Sennett, che si è occupato soprattutto dei temi della teoria della socialità e del lavoro, dei legami sociali nei contesti urbani, degli effetti sull’individuo della convivenza nel mondo moderno urbanizzato, oggi appare sempre più evidente.
Nel suo capolavoro L’uomo artigiano (Feltrinelli, 2008), Sennett individua l’errore fatale della civiltà occidentale nell’aver creduto che la mente potesse operare in un vuoto asettico, separata dal corpo che la ospita. L’autore scrive testualmente che «la storia ha tracciato false linee di divisione tra la testa e la mano, l’ars e la tecnica, l’arte e l’artigianato».
Questa frattura, secondo il sociologo, ha impoverito la capacità umana di comprendere il mondo. L’Intelligenza Artificiale rappresenta l’apice di tale scissione poiché offre la pura elaborazione mentale priva di qualsiasi contatto fisico. Tuttavia, Sennett ricorda che
Il termine “maestria”, con il suo rimando ai maestri artigiani, evocherà forse un modo di vivere tramontato con l’avvento della società industriale; ma questo è fuorviante. La maestria designa un impulso umano fondamentale sempre vivo, il desiderio di svolgere bene un lavoro per se stesso. E copre una fascia ben più ampia di quella del lavoro manuale specializzato; giova al programmatore informatico, al medico e all’artista; anche la nostra attività di genitori migliora, se è praticata come un “mestiere” specializzato, e così pure la nostra partecipazione di cittadini.
L’Intelligenza Artificiale generativa attacca esattamente questo impulso fondamentale. Fornendo il risultato immediato, l’IA soddisfa la necessità di finire un compito, ma elimina il desiderio di svolgerlo, privando l’individuo di quella soddisfazione profonda che nasce solo dalla cura del processo.
Sennett avverte inoltre che la crescita interiore avviene attraverso il confronto con i limiti, scrivendo che
le macchine moderne sono progettate per non opporre resistenza […] ma la resistenza è un’esperienza fondamentale per lo sviluppo del carattere.
Il legno che si spacca o l’argilla che crolla non sono errori da cancellare, ma maestri silenziosi. Eliminando questa resistenza, la tecnologia disconnette l’operatore dalla realtà tattile, causando quel progressivo impoverimento mentale che il sociologo aveva previsto con lucidità.
La conferma delle neuroscienze e il circuito della ricompensa
Se la sociologia offre la spiegazione culturale, le neuroscienze forniscono la prova biologica. Il cervello umano rischia di andare in crisi se le mani restano inattive. Questa evidenza arriva dagli studi della neuroscienziata Kelly Lambert, autrice di Lifting Depression, la quale ha isolato il “Circuito della ricompensa guidato dallo sforzo”.
La Lambert scrive una frase definitiva per comprendere il malessere digitale:
Il nostro cervello è programmato per provare un senso di soddisfazione e benessere solo dopo aver esercitato uno sforzo significativo che coinvolge le mani.
L’Intelligenza Artificiale interrompe questo processo virtuoso offrendo il premio senza la fatica.
Basta osservare l’Homunculus di Penfield, la mappa che illustra come il cervello visualizza il corpo, per notare che le mani occupano un’area enorme della corteccia cerebrale. Smettere di usarle per manipolare il mondo equivale a spegnere la parte più vitale della mente, generando quella sensazione di vuoto che nessuna produttività digitale può colmare.
Ancorarsi alle cose manuali contro la corrosione della modernità liquida
Zygmunt Bauman chiarisce l’urgenza esistenziale del contesto attuale e dell’umanità immersa nell’ipertecnologia. L’Intelligenza Artificiale agisce come l’acceleratore definitivo della “Modernità Liquida”, portando alle estreme conseguenze quella che il sociologo polacco definiva la “sindrome dell’impazienza”.
In Vita Liquida (Laterza, 2006), Bauman analizza una condizione umana in cui le abitudini, le competenze e le certezze diventano handicap se mantenute troppo a lungo. L’IA rende questa obsolescenza istantanea: ciò che si impara oggi rischia di essere inutile domani. Bauman scrive con lucidità chirurgica:
La vita liquida è, insomma, una vita precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza. Le preoccupazioni più acute e ostinate che l’affliggono nascono dal timore di esser colti alla sprovvista, di non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si muovono velocemente, di rimanere indietro, di non accorgersi delle «date di scadenza», di appesantirsi con il possesso di qualcosa che non è più desiderabile, di perdere il momento in cui occorre voltare pagina prima di superare il punto di non ritorno.
L’ansia contemporanea nasce proprio da qui. L’individuo, di fronte alla velocità di calcolo dell’IA, teme di diventare lui stesso uno “scarto”, un elemento superfluo. La tecnologia digitale spinge verso un tempo puntillistico, fatto di istanti slegati e privi di storia, dove conta solo l’immediato. In questo scenario, l’artigianalità non è un hobby, ma un atto di resistenza esistenziale contro la logica dello scarto. Costruire un oggetto fisico, riparare ciò che è rotto o tessere una trama significa riappropriarsi del proprio tempo.
Mentre la società liquida, come osserva Bauman, “non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo”, l’opera artigianale è per definizione durevole. Sporcarsi le mani diventa così l’unico modo per generare “durata” in un mondo che evapora, restituendo all’essere umano la dignità di Homo Faber (creatore) e sottraendolo al destino di puro consumatore passivo di contenuti generati da macchine.
La via d’uscita: tornare all’opera, non al risultato
L’enigma del nostro tempo, cioè la promessa tecnologica della facilità che genera ansia invece di liberazione, non è un mistero ma la conseguenza di un errore di prospettiva. La società ha confuso il risultato con l’esperienza, l’efficienza con il senso, la velocità con la profondità.
Richard Sennett lo aveva intuito prima di molti altri. L’essere umano non è progettato per vivere in un mondo dove tutto è immediato. La mente ha bisogno di incontrare la resistenza del reale per costruire significato. Kelly Lambert lo conferma con la precisione della biologia. Senza il coinvolgimento delle mani il cervello si spegne, perde direzione, desiderio, motivazione. Bauman completa il quadro. Un’esistenza priva di durata, costretta a ricominciare di continuo, non può che generare angoscia.
La tecnologia non è l’avversario. L’Intelligenza Artificiale può essere uno strumento straordinario solo quando non sostituisce del tutto quel processo di trasformazione interiore che nasce dall’impegno, dal tentativo e dalla cura.
La posta in gioco non è il lavoro, né la creatività, né la produttività. È la capacità dell’essere umano di restare umano.
Per questo la risposta al malessere digitale non è demonizzare l’IA né rifugiarsi in un nostalgico ritorno al passato. Serve recuperare l’unità tra testa e mano, ricostruire quella continuità che permette all’essere umano di sentirsi artigiano di sé stesso e del proprio mondo.
Riparare un oggetto. Impastare un pane. Curare un giardino. Disegnare una linea storta. Prendersi il tempo di imparare, accettare la difficoltà, attraversare l’attrito, respirare nei dettagli. L’esperienza concreta restituisce alla mente ciò che la tecnologia, con tutta la sua potenza, non potrà mai offrire. La sensazione di essere coinvolti nella vita e non soltanto di assistervi.
In un’epoca di simulazioni perfette la vera rivoluzione è tornare al reale.
Nel reale, quasi sempre, le mani arrivano prima della mente.