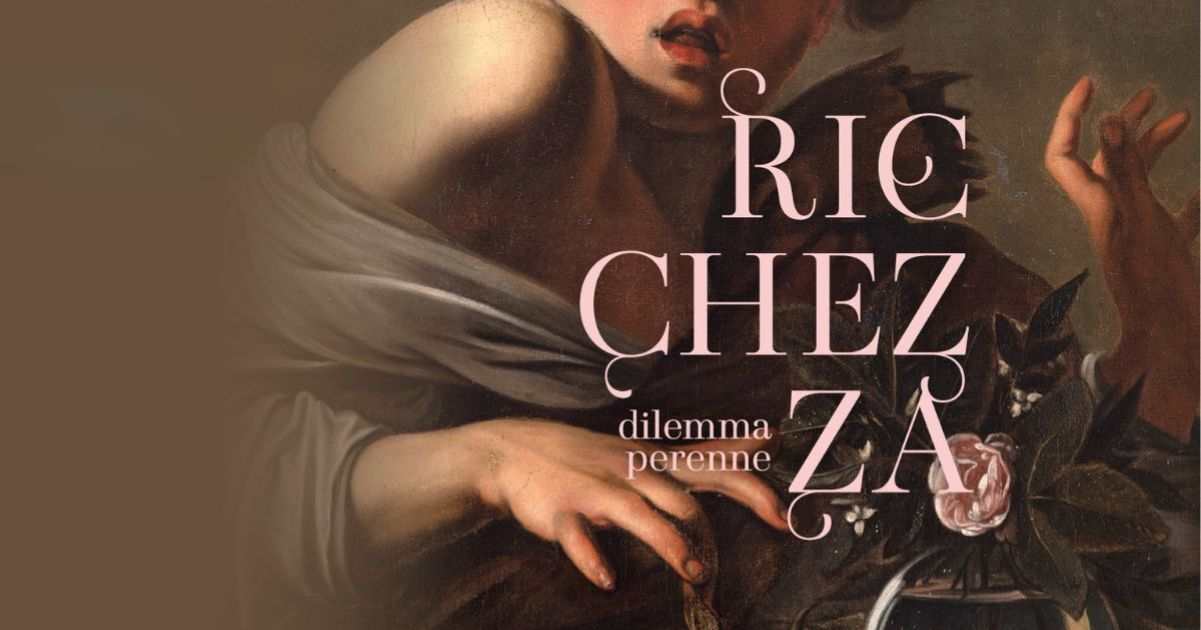Mio padre ci radunò in salotto, eravamo io e le mie due sorelle, Katrin e Jenna. Avevamo rispettivamente 10, 6 e 5 anni. Lui si sedette sul divano, le mani unite si stringevano mentre i gomiti poggiavano sulle ginocchia, la schiena leggermente curvata in avanti e la testa penzolava in avanti; osservandolo bene si poteva notare il suo lento ondeggiare.
Mio padre ci radunò in salotto, era quasi ora di andare a dormire; a cena ci aveva detto con tono serio: “Non appena avrete finito sedetevi in salotto, posizionate i cuscini davanti al divano e aspettatemi lì. Devo raccontarvi una storia”.
Le mie sorelle ingenue credevano che il loro amato babbo, volesse raccontarle una favola prima di andar a dormire; io, invece, più grande anche se di poco, capì dal tono della sua voce che non si trattava di quello. Mio padre, a suo modo, voleva raccontarci qualcosa di speciale.
Quando ci fummo accomodati e le mie sorelle ebbero fatto silenzio, l’uomo innanzi a noi alzò la testa e ci guardò negli occhi.
“Sto per raccontarvi qualcosa di molto difficile da comprendere, e ho deciso di farlo ora, affinché possa rimanere per sempre nella vostra testa, magari impresso fortemente nei meandri più nascosti. Ascoltatemi, senza interrompermi. Non ci metterò molto.”
Le mie sorelle guardavano incuriosite il volto e le labbra di mio padre che si muovevano piano, scandendo ogni parola con lentezza. Lo guardavano non comprendendo affatto ciò che stava per accadere, ma il timore provato nei confronti di quell’uomo dalla scorza dura ma dal cuore così buono e grande, impose loro di restare nel più assoluto silenzio.
Ricordo ogni dettaglio di quella sera, di quel racconto, proprio come aveva sperato mio padre: quell’episodio si era impresso in modo indelebile nel mio cervello. Ovviamente non compresi subito, ma crescendo, accumulando esperienza, vivendo, mi accorsi che la “storia” di mio padre e il suo significato si ripresentava insistentemente in ogni momento della mia esistenza. Così ricordai, così compresi.
Mio padre con un sospiro iniziò:
“Eravamo giovani, avevo 15 anni. A quell’età vidi per la prima volta Enrico. Era una ragazzo particolare, figlio di una famiglia poverissima, irruente, solitario, molto folle, ma un bravo ragazzo. Enrico entrò nella nostra scuola al terzo anno di liceo, in un ambiente non proprio adatto alla sua condizione. Non era ben visto. Il classico ragazzo fuori dai normali canoni in una cittadina che viveva solo per rispettarli. Marinava spesso la scuola e non riusciva ad integrarsi pur provandoci: ogni volta, innanzi a sé, trovava solo porte sbarrate, volti silenziosi e sospettosi, isolamento. Io ero giovane, a quell’età non si è abbastanza maturi per comprendere. Seguivo la massa, e come gli altri anch’io mi comportai allo stesso modo. Nonostante tutto ciò Enrico non sembrava arrendersi, andava avanti continuando a provare, continuando a suo modo a “chiedere aiuto”, a conquistare la fiducia degli altri, ma nulla. La testa dei giovani è difficile da modificare e ancor peggio quella degli adulti.
Crescemmo e furono gli anni dell’Università, Enrico ovviamente non ci andò, era troppo povero per poterselo permettere. Non avendo amici e poche possibilità lavorative, cercò di mantenersi nel migliore dei modi lavoricchiando qui e lì, e vivendo a casa dei suoi genitori: il padre era morto e la madre, malata, stentava ad andare avanti. Nonostante questo Enrico non demordeva e continuava nella sua vita, normalmente, provando a far quadrare le cose. Ogni tanto ci vedeva passare sulla strada della stazione, noi i suoi “vecchi compagni”, ci salutava con sincerità, con piacere, i più di noi lo ignoravano, io con loro, anche se iniziavo a pormi dei dubbi sul mio, sul nostro, modo di comportarci. Era giusto? Davvero quel ragazzo era da considerarsi un poco di buono unicamente per via della sua condizione? Iniziavo a pensarci, ma quasi ostinatamente, non facevo nulla per cambiare la mia idea. Trascorsero dieci anni, molti di noi misero su famiglia, comprarono case, vivendo il sogno di una vita tranquilla, felice. Enrico no. Morta la madre, il fisco gli aveva tolto tutto, anche la casa, non riuscendo a trovar lavoro era rimasto solo: un barbone di strada. Ma continuava a sorridere, salutandoci quando ci incontrava, dicendoci di non dimenticarsi di lui, che avrebbe fatto qualsiasi cosa, solo non voleva essere un peso. Ma nessuno lo ascoltava. Alcuni promettevano, ma quelle parole di speranza restavano fumo al vento. E io con loro.
Era inverno, Enrico senza una casa, senza un lavoro, si arrangiava come poteva: mangiava alla mensa della Caritas, e dormiva in un container semidistrutto gettato nella vicina discarica che era appartenuto all’ex-guardiano, morto anche lui. Enrico aveva approfittato della morte di quel vecchietto, a cui non avevano ancora staccato gas e corrente, per trovare un riparo per l’inverno. Quella stagione faceva molto più freddo del solito, tanto che ad un certo punto Enrico non poté più mostrare a nessuno il suo sorriso dato che lo sbattere i denti glie li aveva consumati tutti. Un giorno però sorrise di nuovo, sembrava l’uomo più felice al mondo. Aveva trovato, vicino ad un cassonetto in città, una vecchia stufa a gas con una bombola ancora semi piena. Aveva trovato quel calorifero lì, buttato per strada e pensò che fosse quasi un segno inviato dal cielo, una speranza caduta dalle stelle che gli avrebbe permesso di sopravvivere ancora, ancora un po’. Era così felice che prese quella stufa e la bombola e la portò nella sua nuova “casa”, quel vecchio container malandato. Lì l’accese, felice. Lì, nella povertà, rimase immobile il suo sorriso perenne.
Enrico era morto. La stufa era difettosa, e aveva riempito l’intero container di gas. Enrico era morto di asfissia. Enrico era morto.
La notizia fece il giro del paese e arrivò anche alle mie orecchie. Quando lo seppi piansi. Piansi a lungo, e qualcuno disse senza motivo. Io piansi pensando che avevamo ucciso un sorriso, un uomo che non aveva fatto altro che chiederci aiuto dignitosamente, con onore, e noi stolti, ciechi, maledetti, lo avevamo lasciato morire, tutto per uno stupido pregiudizio da bambini.
Enrico era morto. Il suo sorriso era morto. Con lui era morta la nostra umanità, la nostra speranza.”
Finita la storia mio padre si alzò e andò via, le mie sorelle in silenzio non capivano, si guardavano tra loro. Io ricordo bene di aver visto una lacrima scendere dagli occhi del mio vecchio. Aveva voluto insegnarci qualcosa.
Lo ricordo bene, ora che sono qui in questo container e ho trovato questa stufa. Posso finalmente riscaldarmi…
Sergio Mario Ottaiano