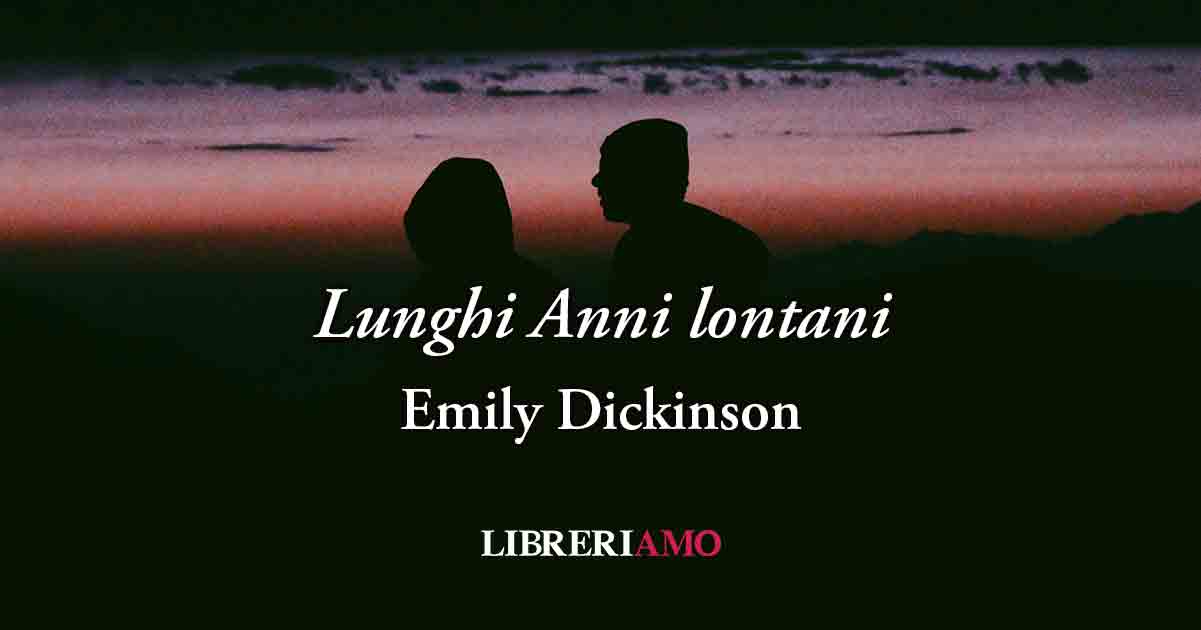Oggi domenica, giorno di riposo e quindi niente sveglia, mi alzo e, tra uno sbadiglio e uno stiramento di arti, metto i piedi a terra. Il rimmel e l’ombretto della sera prima hanno lasciato delle evidenti sbavature sul mio viso che, al solito, ho dimenticato di struccare; l’utilizzo di latte detergente e tonico, non rientra, quasi mai, nelle mie priorità. Pazienza, vorrà dire che la pelle non respirerà, i pori avranno di che nutrirsi e forse prenderanno ossigeno da quella poca aria che sovrasta il mio spazio, fa sempre bene condividere qualcosa con gli altri e, perché no, con una parte di me. Non sono egoista, vero? A passi lenti, anzi lentissimi mi avvio verso la cucina, ho bisogno del mio caffè, della mia prima dose di caffeina per non dare la possibilità alle palpebre di chiudersi di nuovo. La notte, come il solito, ha divorato con avidità una buona parte dei miei pensieri, trasmutati in sogni, li avrei riportati nel nuovo giorno. Parlare di luce proiettata nell’istante in cui la visione sì apre allo spostamento delle lancette, può significare solo una cosa: benvenuta nel mondo dei vivi. Vivi? Ecco, se per vivi s`intende una figura con tratti delineati, presumibilmente armonica, che veste di superficialità ogni fibra e che si lascia abbagliare dai flash di luce artificiale, che recita con cura il suo copione, allora io sarei una figura spettrale che rifiuta il suo passo in terra. Negli occhi la luce di chi ancora è intrappolato nella sfera del sogno, in quella dimensione astratta dove anche l’irreale assume una forma tangibile.
Con i gomiti appoggiati su tavolo e con la testa inclinata su un palmo della mano, ripensavo ad Adrian e al suo grande amore verso Miriam, avevo fatto tardi per finire di leggere la loro storia – quel libro mi aveva colpito già dalla copertina – due mondi completamente opposti ma uniti nella magia dell’amore assoluto, puro, incontaminato da ogni possibile elemento tossico; rivedevo tutto quello che avevano dovuto superare per viversi e coronare la loro storia.
Riduttiva la mia sintesi, ma in fondo mi sono appena svegliata e voglio sentire dentro ancora un po’ di quella magia, prima che la routine mi trascini nel suo vortice.
Non potevo fare almeno di pensare a Fabio e alla sua spregiudicata irriverenza, al giorno in cui era entrato nella mia vita, alla nostra storia fuori da ogni logica, al mio rifiuto che con il tempo era diventato febbre arsura desiderio che si espandeva fino alla radice di quel pensiero fisso, che dilaniava la mia anima fino nel profondo. Ebbra mi aggiravo in un angolo distratto di quell’eterno sentire. Lo sentivo dentro tanto da patire male nel muscolo che batte senza tregua togliendomi il respiro. Mi ero persa nella profondità del suo sguardo, immersa nei meandri nascosti alla vista, smarrita nell’abbraccio dell’anima. Avevo accarezzato la meraviglia di quella superficie con delizia di gesti leggeri e sinuosi. A occhi chiusi avevo seguito la mappa d’inchiostro, con mano sfiorato l’abisso, condanna e libertà, in quel luogo avevo toccato la vetta più alta. Una passione, la nostra, che ci univa nel flusso di sangue di un’unica vena. Il richiamo, l’odore di corpi che aspettavano il momento giusto per unirsi. Avevamo deciso di fare un viaggio a Parigi, tutto era pronto, ogni cosa organizzata, per rendere meraviglioso il nostro soggiorno nella città dell’amore, un imprevisto fece saltare tutto, non avevamo calcolato un’eventualità del genere. Fabio si sentì tradito, non volle sentire ragioni e mi fece sentire come se fossi niente.
I giorni seguenti trascorsero in un’attesa logorante, in una telefonata che tardava ad arrivare, ognuno di noi si disperava come e dove voleva. Tutto questo segnò la nostra storia fino a farla naufragare nel mare dell’incomprensione, tra le onde di un misero orgoglio. Nonostante tutto non era la fine, perché nulla può cancellare un segno così profondo come l’appartenersi. Un tempo di attesa che varcava i confini dell’irrazionalità, come quella sera in cui, nella penombra della stanza, seduta su quella sedia, con lo sguardo rivolto alla finestra, persa nella solitudine di quella strada vuota e debolmente illuminata dalla luce gialla di un lampione, con gli occhi fissi su un punto indefinito quasi a voler cercare a tutti i costi qualcosa che, probabilmente, la pioggia aveva cancellato. In quel silenzio ovattato, tra le ombre sinistre della notte, riuscivo a percepire un battito irregolare, una fitta allo sterno dolorosa, sentivo il cuore frantumarsi e non potevo nulla, non aveva nessun senso ricomporlo, ero nuda e inerme al cospetto di colui che abitava il cuore ma non il perimetro visivo.
Bloccata in quel vicolo poco illuminato, un senso di smarrimento profondo mi costringeva a restare immobile, a ogni tentativo di fare un passo avanti ero afferrata da una mano invisibile e trattenuta contro quella fredda parete in mattoni a vista, quel muro delimitava lo spazio occupato dalla mia vista. Non ero andata mai oltre quell’estensione, quella limitazione stabilita dalla mia paura di vivere la vita che non conoscevo, troppo forte quel senso di razionalità che mai mi aveva permesso di ascoltare, almeno per una volta, il cuore. Fabio era il cuore, era quella dolce carezza che apriva l’Infinito, era l’abbraccio in cui mi sarei voluta perdere. Un’oasi nel deserto della mia esistenza. Prima di allora non avevo mai voluto dare un volto all’amore, lo avrei voluto vivere solo nella mia fantasia, nell’irreale consistenza dell’essere. Un viaggio immaginario tra le dune bianche di un quadro perfetto. Amare significava soffrire, questo avevo imparato nel corso della mia vita.
Il tempo della magia di luce del sogno era finito ed io ritornavo nel mio nuovo giorno con tutto il pesante bagaglio che mi portavo dietro. Oggi però voglio uscire da casa e andare al mare, voglio respirare la vita, cercare di non pensare.
Sara era sulla spiaggia, quel giorno in cui tutto sembrava non avere più senso; camminava scalza sulla sabbia ancora fredda, in fondo non sentiva nessuna sensazione che andava oltre quel suo pensiero fisso, intrappolato tra i reticoli della mente. Ascoltava, distratta, il fragore delle onde sulla riva e il loro rotolare, osservava i gabbiani librarsi in volo e disegnare libere figure. Aveva atteso invano un gesto, una parola che potesse, realmente, farle sentire la sua appartenenza. Folle, era quello che provava, folle, era il suo reclamarla. Era usurato il freno che la teneva inchiodata a quel grigio manto di una strada senza uscita. Era doloroso stargli vicino, rischiando di cadere nella banalità di frasi fatte, o lontano incolpando la distanza che li separava e il vuoto che pesava più di un macigno. “ Aiutami a non amarti- continuava a ripetere a se stessa- cancella ogni parola che ti ho donato, uccidi il desiderio che si espande nel mio corpo, fa che il presente si tramuti nell’incantevole bellezza di un ricordo”. Aleatorio il suo pensiero si espandeva come fumo, impercettibili fili galleggianti nell’aria di quel piccolo spazio, dove viveva, rarefatto, dilatato in quel tempo fermo. L’onda continuava a lambire la sua riva, Sara smarrita attendeva di esserne travolta.
Forse non era quello il luogo, continuavo a ripetermi con forza.
Laura Di Vincenzo