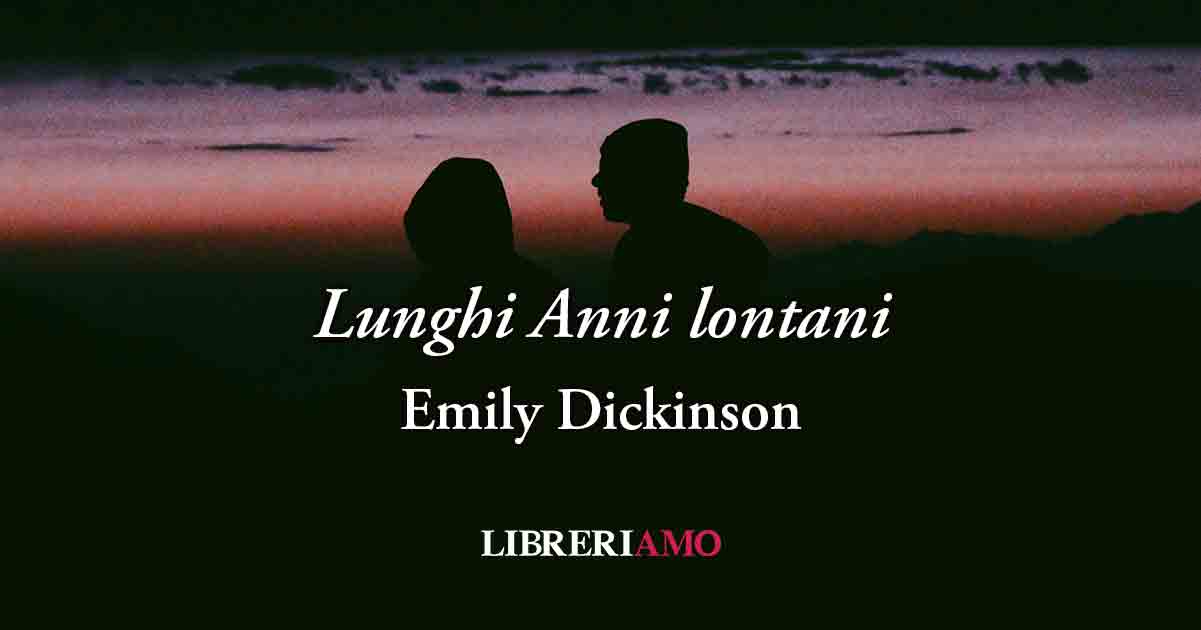Stavo cercando me stesso sul fondo della mia tazza di caffè quando la vidi.
Non m’aspettavo niente nemmeno da quell’altro lungo pomeriggio di meditazione. Sarei finito a farmi prediche sull’incapacità di accettare me e gli atri, mi sarei rimproverato il vizio di giudicare poco interessanti gli argomenti altrui e sarebbero ricominciate le domande, interminabili file di perché costruite sull’unica diagnosi che alla fine mi costringevo a dare: ero un inguaribile sociopatico.
Quel pomeriggio invece lei era lì e leggeva. Fu la prima cosa di cui m’innamorai.
Era immersa nella poltrona che aveva scelto tra le altre in quel bar dalle luci soffuse, un po’ retrò e quasi fuori dal tempo. Ogni oggetto sembrava essere l’antitesi dell’altro, arrivava da un tempo diverso, da una vita che voleva raccontare. Ma la visione d’insieme era bellissima: ognuno aveva la sua logica e la propria storia.
Io ero seduto al posto di sempre. Un altro dei miei vizi era seguire la linea retta delle giornate. Significava ogni buongiorno con la stessa canzone, il solito posto sul bus, in aula e al bar, almeno venti pagine di un buon libro ogni sera, e così via. Piccoli riti quotidiani che servivano per calcolare le dimensioni di me stesso.
Lei era seduta di fronte. Con una mano teneva il libro nel cono di luce disegnato dalla lampada sopra di lei, che faceva brillare il biondo dei capelli, mentre con l’altra ne torturava le punte e quel gesto mi rapiva. Aveva un abito a fiori leggero che le lasciava scoperte le spalle e le gambe e la sua pelle mi ricordava il candore delle fiabe. Sotto gli occhiali, gli occhi scorrevano veloci da sinistra verso destra, poi a capo, e di nuovo sinistra e destra. Così stava divorando il suo libro, mentre io ero divorato dalla curiosità di conoscerne il titolo.
Quando riuscii a intuire il titolo semi nascosto dalle sue dita, quando realizzai che stava leggendo “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, il primo istinto fu quello di alzarmi e raggiungerla, di dirle smetti adesso di leggere e parliamone insieme.
Sai, è il mio libro preferito. L’avrò letto almeno una decina di volte e ogni volta ne ho tratto qualcosa di nuovo. Forse l’unico che mi ha aiutato a capire un po’ di me stesso perché ci sto provando, ma dentro è un tale caos che ho preferito vivere a schemi. Lo so, ti stai chiedendo cosa vuol dire.
Dai, non guardarmi con quegli occhi curiosi che continuo ad innamorarmi altrimenti. Sì, perché mi sono innamorato di te la prima volta appena ti ho visto. La seconda quando ho capito che stavi leggendo proprio questo libro e la terza ora che mi guardi così.
Non alzarti, resta. Ho solo voglia di sapere chi sei e dopo vorrei che mi aiutassi a capire chi sono perché la mia solitudine ha avuto come risultato la sola crescita esponenziale dei miei dubbi. Quando t’ho vista invece ho subito creduto che tu avresti potuto aiutarmi. Ora ne sono certo. Qualcuno m’ha detto che soffro d’insicurezza, mi hanno consigliato di partire dall’analisi dei miei limiti. Ma non sono ancora riuscito a calcolarli tutti. Ogni limite di cui divento consapevole restringe i miei confini, nei quali sono rimasto intrappolato. Così quel consiglio si è trasformato nel suo estremo negativo e io sono ancora alla ricerca di quello che non so fare, che non posso fare e non posso essere.
Allora ho provato a fare il contrario, cioè a pensare a tutte le cose che so fare. Ma non è servito a nulla ignorare le consapevolezze a cui con fatica sono giunto, né posso mentire a me stesso. E mi ritrovo sempre al punto di partenza. Sono sicuro che esistano ancora milioni di cose al mondo che non so fare, che non capirei, ma come posso avvicinarmi ad esse se non so nemmeno avvicinarmi a me stesso? È che mi manca la strumentazione adatta a cominciare qualsiasi tipo di ricerca. E quella serve se non voglio raccogliere solo un numero sconfinato di dati banali. E io non lo voglio.
Poi un giorno ho letto che bisogna prendere le cose con leggerezza, “che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, senza avere macigni sul cuore”. Ora vorrei dire a Calvino che io ho un macigno sul cuore, grande, enorme, e che non ne conosco la natura, che è tanto grande che è impossibile ignorarlo. Prima di conoscere le cose, vorrei imparare a conoscere la lente che le guarda. Me stesso. Come posso dire di conoscermi se tutto quello che faccio è il contrario di quello che penso? Questo è insostenibile, perché vuol dire avere a che fare con due profondità dello stesso abisso, e spiegarsi contemporaneamente l’una e l’altra, e poi dare spiegazioni all’una dell’altra, e viceversa.
Come inizia un approccio all’Altro, se non so ancora dire Io? Se non conosco ancora, davvero, l’Io che mi fa parlare? Credo di non possedermi mai abbastanza da poter dire di conseguenza “questa cosa è mia, l’ho capita e guadagnata”.
Sono sempre più convinto di quello che non ho, cioè di quanto benessere si possa provare ad appoggiare soltanto lo sguardo sulle cose, fermarsi prima di chiedersi quale ne sia il senso. Quest’interminabile corsa verso l’essenza prosciuga le forze che potrei investire a fare altro. Ma ho bisogno di conoscere ogni cosa con cui sono in contatto, al di là del puro significante, oltre tutte le soggettività, provare a scoprire se c’è, alla fine, un fondo “comune”, che non è conformismo ma, al contrario, un posto dove ci si può riposare, senza tentare di essere a tutti i costi originali, di essere a tutti i costi. Questa potrebbe essere, forse, l’unica Lode alle istituzioni che posso concepire.
Tu non mi dirai che ho mille nevrosi che bloccano il fluire dei miei istinti, non mi dirai che sono volontariamente intrappolato in un posto dentro me stesso al riparo da me stesso perché ho paura di conoscermi, per paura di rimproverarmi, e non accettarmi e tutto il resto delle cose eccezionali che mi hanno già lungamente attribuito.
Io credo tu possa capire la sostanza del dilemma che mi ritrovo a vivere: che insostenibile non è la leggerezza dell’essere quanto invece la pesantezza del mio stato di non-essere, che mi trascina dietro di sé e che viene prima di me. E il tuo sorriso è la marca della tua comprensione.
Smisi di far dialogare con sé stesso l’Io che non sarei mai stato. Mi alzai e mentre mi avvicinai al banco per pagare il mio caffè, urtai involontariamente contro la lampada che faceva splendere quella ragazza bellissima. Vacillò alcuni secondi, giusto il tempo di ritrovare l’equilibrio. Pensai che facevo bene a continuare a calcolare i limiti del mio corpo, perché il mio esser goffo era prova di quanto ne fossi ancora inconsapevole.
Uscendo, provai ad incontrare i suoi occhi che erano rimasti incastrati nelle parole.
Nulla.
Mi rimisi lo zaino, passò il bus di sempre e, seduto al posto di sempre, aspettai che la strada si accorciasse fino a riportami a casa.
Lucy Nappa