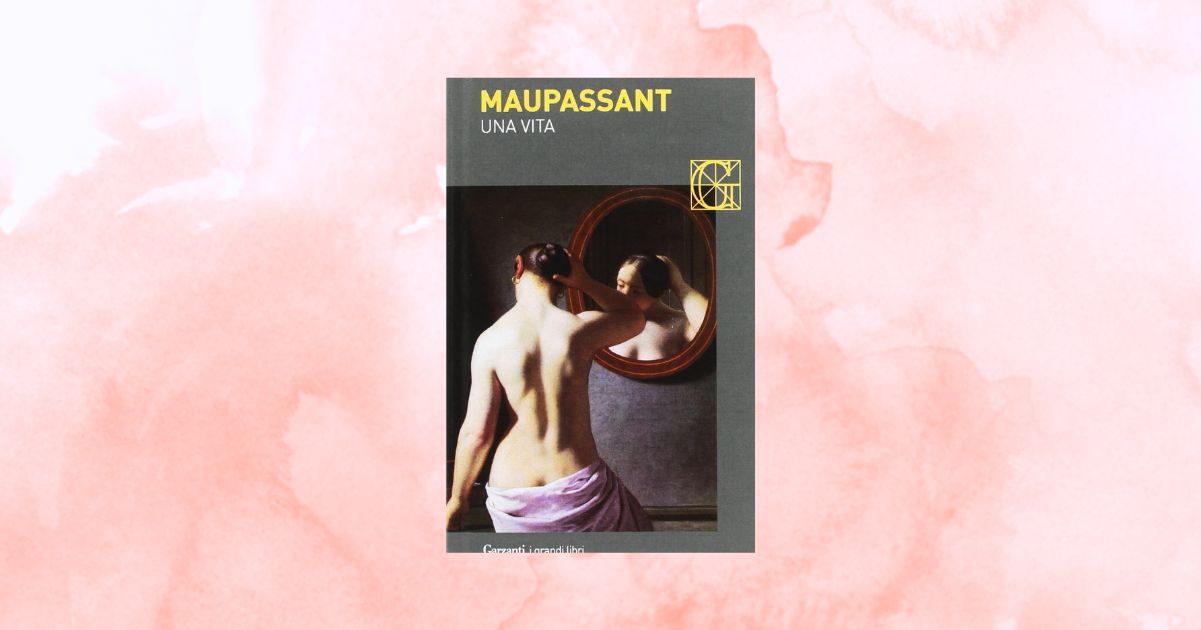Nelle grigie giornate piovose, quando l’umidità e il freddo erano particolarmente insidiosi, ci si andava a sdraiare dietro ai tecnigrafi, coperti da cappotti, giacche, sciarpe e guanti ammucchiati apposta per garantire riparo dalla luce e per ammorbidire il giaciglio.
La voce del professore giungeva da lontano, come una ruvida ninna nanna che parlava di cavi elettrici, isolanti, resistenze, alternatori e differenze di potenziale anziché di lupi neri, cappucci rossi, nonne malate… selve oscure.
Mancando orditi e tessuti, assecondavamo il suono e ci addormentavamo alla svelta recuperando le ore della notte; ore macilente, perse nel buio a girovagare senza una meta precisa, senza obiettivi, sospinti solo dal desiderio di far tardi, di rimandare il rientro a casa quanto più possibile, perché sapevamo bene che rientrare significava serrare le fila, farsi compatti e riprendere la divisa. Insomma, si rimandava ad oltranza e così come il muoversi era un casuale peregrinare, anche il parlare si risolveva spesso in un vuoto fanfalucare. Mica avevamo grandi cose da dirci, né ci piacevano troppo i discorsi seri, quelli che pretendono di essere veri. C’erano già i nostri genitori per questo e non solo loro. Vuoto, buio e fanfaluche, queste erano le nostre coordinate, ma soprattutto il buio, che smorzava i contorni delle cose e rendeva tutto omogeneo. Il buio assecondava e garantiva il silenzio, le parole uscivano sporadiche e incerte solo quando i fari di una macchina o la tenue fiamma di un accendino rischiaravano d’attorno per pochi secondi. Niente a che vedere con la luce dell’astro luminoso che al mattino arrivava con fare tracotante e qualcuno ti costringeva a scendere dal letto che dovevi andare a scuola. Non contava dire che avevi sonno e avresti voluto dormire… no, vieni a letto prima la sera se hai sonno, forza, giù dalla branda, stropicciati il muso prendi le tue cose e schiodati!
Consolava solo il fatto che a scuola c’era lui, il nostro sospite, l’ancora di salvezza, l’insegnante mandato da qualche divinità generosa e partigiana. Epicuro diceva che della morte non ci si deve preoccupare perché quando c’è lei non ci siamo noi e viceversa; la stessa relazione valeva anche con il nostro prof preferito: dopo l’appello ognuno per la sua strada, lui a far lezione, noi a combattere la nostra suzzacchera e il nostro tedio da qualche altra parte. Che poi si combinasse poco o niente, questa era un’altra storia.
C’erano mattine, però, in cui il senso di vuoto della sera precedente continuava a mordere e nemmeno restarsene imboscati e al caldo riusciva a far superare il disagio…
Allora si usciva e si andava al bar .
Dove andate, ragazzi? Chiedeva quello.
Al bar! Si rispondeva noi, perentori.
Ma…, faceva lui titubante e incerto.
Torniamo presto, vuole qualcosa da bere prof.? Rispondevamo noi, gagliardi e strafottenti.
No, no, grazie, ma… sbrigatevi eh?
Non si preoccupi, facciamo in un attimo.
Così le prime due o tre ore passavano, o le ultime due o tre, a seconda della giornata; non che al bar si facessero cose più interessanti, si fumava qualche paglia, si beveva una birra, magari un panino, una partita a carte un po’ di trivialità giusto per tenere basso il livello della conversazione poi si tornava a finire la mattina con qualche altro insegnante che se non ti vedeva in classe ti metteva assente e tutte quelle cose lì.
Ma con lui erano altri polsini, altra storia; la classe era sempre semideserta e lui apparentemente imperturbabile; alcuni dormivano, altri giocavano a carte negli ultimi banchi in fondo all’aula, altri ancora vagavano per la scuola alla ricerca di qualcosa d’interessante, poi c’era chi andava al bar, chi non veniva nemmeno a scuola, e lui spiegava le sue cose al primo della classe sempre seduto in prima fila, o a qualcun altro che vincendo tutte le tentazioni si sforzava e cercava di ascoltare la lezione, ma non durava mai più di dieci minuti dieci. Parla parla, scrivi scrivi, la lavagna si riempiva di formule, la classe di parole, ma si vuotava di tutti i candidati a leggere quei simboli e ad ascoltare quei suoni. Destino infame.
Il suo sguardo sembrava non oltrepassare le lenti degli occhiali e le pupille erano sempre pronte a dirigersi verso qualche diversivo quando l’interlocutore lo guardava fisso negli occhi.
Era timido? Troppo buono? Entrambe le cose? O forse era un pavido, un codardo, un uomo di poco polso e con poco pelo, tutto il contrario del villoso Satanasso, forte, audace temerario e grancornuto!
Una mattina…
Una mattina ebbe un attimo di lucidità, gli si aprirono le porte del reale e vide la situazione, il paesaggio deserto che gli si parava innanzi. Lo sguardo prese a vagare oltre le lenti e notò quattro ragazzi quattro seduti in fondo all’aula con alcune carte in mano, altre sui banchi, certune fiches gialle e certe altre rosse, talune verdi e altre blu in forme queste rotonde, quelle quadrate e quell’altre rettangolari.
Una lucida consapevolezza di nullità l’invase e l’attribuì erroneamente a sé e non ai bambocci assenti e presenti. Mosso dall’errata convinzione, si avvicinò risoluto ai quattro balordi e, stravolgendo un rituale più che ossidato, disse:
– Adesso basta.
Prese le carte, le lanciò per aria e con la sua esile figura cominciò a danzare su quelle che cadevano a terra, pestandole coi tacchi e colla punta delle scarpe in una danza apotropaica che da tempo premeva per uscire e sbirciare le cose del mondo.
Il pugno gli arrivò all’improvviso, il tempo necessario ai gaglioffetti per riprendersi dallo stupore; gli occhiali caddero a terra e schizzarono lontano, poi seguì una brevissima colluttazione nella quale il disgraziato professore ebbe la peggio da subito perché il più grosso del gruppo, dopo averlo strattonato ben bene, gli avvinghiò il collo col braccio destro villoso e nerboruto, strinse forte fin quasi a metterlo in ginocchio e in un rigurgito infantile gli disse: ti arrendi? E? Ti arrendi adesso?
Quasi soffocato, il povero missionario del sapere tossicchiò che sì, si arrendeva al cospetto di tanta forza.
Gli ordinarono di raccogliere le carte e di rimetterle sul tavolo, cosa che fece senza protestare, gliele fecero contare per verificare che ci fossero tutte, e finalmente gli dissero di togliersi dai piedi che avevano da fare, loro! Dovevano finire la sfida ai quattro.
Mesto, il professore cercò gli occhiali, che fortunatamente non si erano rotti, li inforcò nonostante un leggero tremore nelle mani e chiuse la sua finestra riportando la vista al di qua delle lenti.
Poi riprese la lezione, esattamente da dove l’aveva interrotta.
Massimo Mora