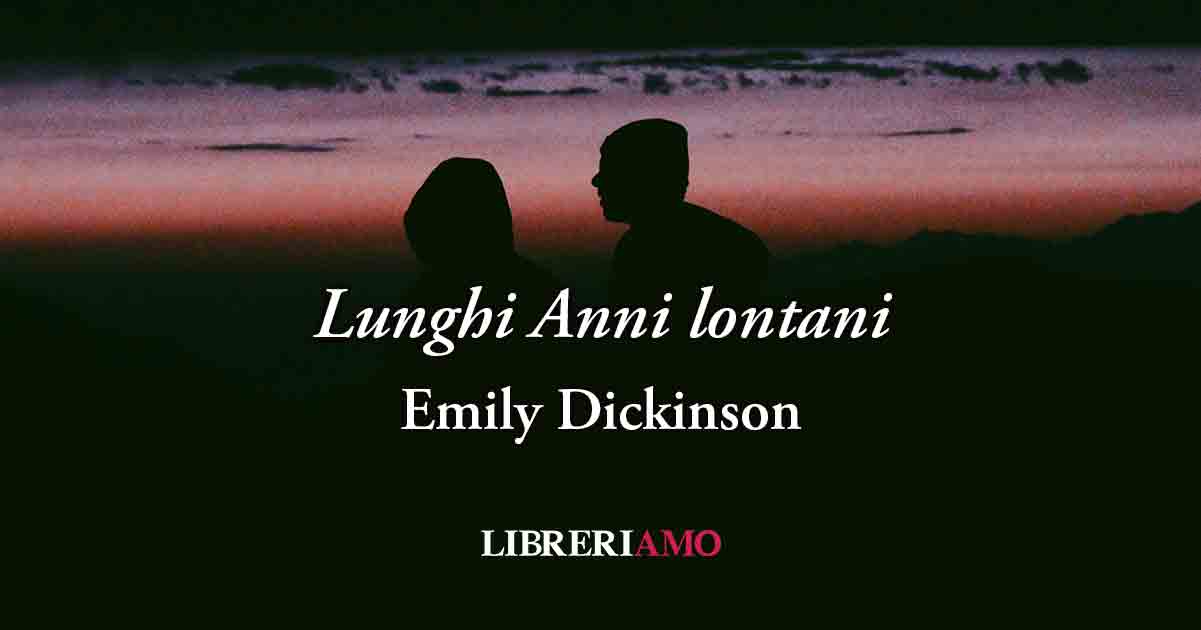Il vecchio Abir faceva il lustrascarpe, un mestiere che a Cracovia erano ormai rimasti in pochi a fare in quegli anni. La sua bottega si trovava nei pressi del castello di Wawel, proprio sotto la grande statua in bronzo del drago. Non era una vera e propria bottega considerato che era all’aperto: una sedia di legno, un cuscino con una stampa a fiori, un vecchio sgabello e una cassetta piena di spazzole e lucidi. C’era anche una valigia, ma che non facesse parte dell’arredo era opinione diffusa. Era una vecchia valigia di cartone con tante fotografie di posti lontani incollate sopra. Perché il vecchio Abir aveva viaggiato tanto prima di arrivare a Cracovia, lo sapevano tutti. Quello che non si sapeva era che fine avesse fatto la sua famiglia. Lui, il vecchio Abir, non ne parlava volentieri.
Si racconta che non accettasse mai soldi per il suo lavoro. Si limitava a chiedere un giornale, non importava quale. Alcuni credevano che lo facesse perché a Kazimierz, l’antico quartiere ebraico dove Abir abitava, i soldati irrompevano negli appartamenti, svuotavano i guardaroba, strappavano gli oggetti di valore dalle dita e dal collo. Pertanto in quegli anni accumulare ricchezza non aveva alcun senso, anzi era addirittura sconsigliato. Altri ritenevano che fosse un collezionista. Del resto durante l’occupazione tedesca tutti i giornali dell’anteguerra erano stati chiusi e la stampa era stata ridotta a poche dozzine di pubblicazioni. Altri ancora pensavano che amasse semplicemente leggere e tenersi informato. Solo quando lo portarono via, tutti capirono cosa c’era in quella vecchia valigia di cartone e cosa se ne facesse di tutti quei giornali.
Chi non lo aveva mai visto prima e di lui aveva solo sentito parlare, passando da quelle parti lo riconosceva subito. Era sempre vestito di nero, fatta eccezione per la camicia bianca indossata sotto la giacca. Aveva una lunga barba, bianca anche quella, e dal cappello scendevano due riccioli laterali. A fine giornata, quando il sole scompariva nella Vistola, raccoglieva le sue cose e andava via, non prima però di aver raccontato una favola, sempre la stessa, ai bambini che erano soliti giocare lungo la sponda del fiume.
“In un tempo non molto lontano, tutti coloro che erano considerati diversi venivano catturati e rinchiusi in un luogo che incuteva terrore anche solo a pensarci”.
“Era un campo circondato da filo spinato e a guardia c’erano dei soldati sulle torrette. Una mattina i bambini si svegliarono, si guardarono intorno e non videro più i soldati. Così saltarono giù dalle assi di legno su cui erano costretti a dormire e andarono di corsa al cancello. Lo trovarono aperto. Poi corsero a casa, dove trovarono i loro genitori”.
“Ognuno aveva un compito preciso all’interno del campo e quello dei bambini era di trasportare mattoni. Quattro mattoni. Ognuno doveva trasportare quattro mattoni per volta. Quando i più piccoli non ce la facevano più, i soldati ordinavano di portarne tre, poi due. La sera i bambini erano sempre sfiniti, ma non avevano nemmeno il tempo di riposarsi che già si dovevano alzare perché iniziava una nuova giornata di lavoro. Una mattina si svegliarono e tutto era diverso. Avevano dormito tanto, il giorno era ormai chiaro e non c’era stata la campana per la sveglia. Così si alzarono dal pagliericcio, si avvicinarono alla porta e guardarono fuori. Non c’era nessuno. Allora uscirono dalla baracca e guardarono in direzione della torretta. Si accorsero che era vuota. E anche quell’altra e quell’altra ancora. Tutte. Ecco che iniziarono ad urlare per tutto il campo che non c’erano più i soldati, che erano scappati e che finalmente erano liberi. Si diressero verso il magazzino del cibo, lo aprirono e trovarono ceste stracolme di pane. Nella cucina invece c’erano ancora tre calderoni di zuppa per i soldati, con la pancetta e le patate. Ognuno mangiò fino a saziarsi e solo in quel momento corsero verso il cancello. Il campo era pieno di gente. Erano tutti felici, cantavano e si abbracciavano. Uscirono tutti fuori e si incamminarono sulla strada che correva lungo il filo spinato. Ad un certo punto sentirono qualcuno chiamare: . Yosef si voltò. Era la mamma che correva verso di lui. Si abbracciarono e insieme andarono in direzione di Oswiecim, dritti verso casa”.
“Il viaggio non fu lungo. Scesero alla stazione e attraversarono il campo vicino alla fabbrica di oggetti smaltati. C’erano molte case bruciate, ma non la loro. Una volta entrati in casa, Yosef inciampò sul cavalluccio a dondolo che aveva dimenticato lì la notte in cui furono fatti uscire di corsa. Sul tavolo della cucina trovarono un grande tegame di patate e un’intera pagnotta di pane”.
“Mangiarono tanto e dopo Yosef non andò subito al parco. Prima doveva fare i compiti”.
“All’improvviso entrò dalla porta il papà di Yosef. Lo abbracciò e lo baciò”.
Proprio mentre Abir finiva di raccontare la favola, arrivò una camionetta a tutta velocità. Scesero due soldati e lo prelevarono a forza, davanti allo sguardo attonito dei bambini. Lui, mentre veniva trascinato via, iniziò a recitare a gran voce alcuni versi:
“E finisce così la storia,
ma voi bambini conservatene la memoria.
Di noi traccia non resterà,
se non questo grido estremo di libertà”.
Proprio in quel momento si alzò una folata di vento. La vecchia valigia di cartone andò a sbattere contro il piedistallo della statua, si aprì e quelli che sembravano tanti aeroplani fatti con fogli di giornale si dispersero per l’aria. Il drago emise una di quelle fiammate che servivano a dilettare gli spettatori e che per un istante sembrò inghiottire tutto quanto. In realtà gli aeroplani di carta si trasformarono in colombe e punteggiarono di bianco il cielo di Cracovia. Si racconta che una di queste colombe si sia fermata a bere da una pozzanghera all’ingresso di Kazimierz e che oggi crescano lì dei bellissimi fiori di loto.
Sofia Schito