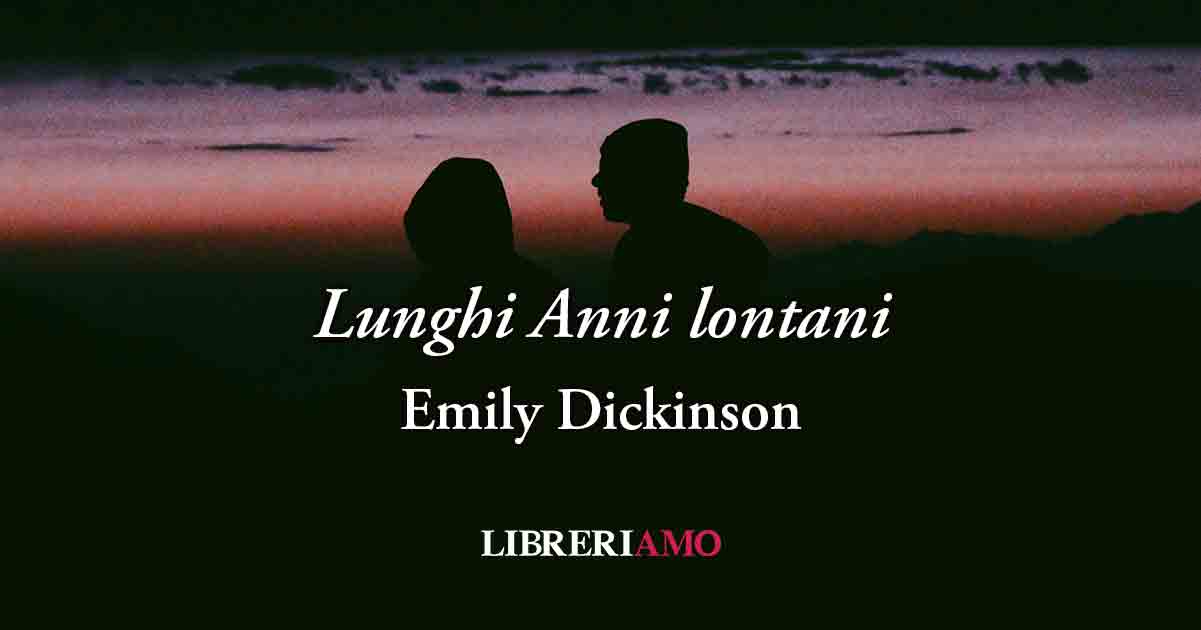Ero lì.
Seduto davanti a lui che a malapena respirava.
La maschera dell’ossigeno si spostava ogni volta che lo sforzo d’inspirare l’aria gli faceva irrigidire i muscoli della faccia.
Ecco: era tutta lì la morte?
L’ultimo estremo sforzo di perpetuare un corpo è ancora vita?
Non era cosciente forse dal giorno prima, ultimo epilogo di una settimana in cui aveva cominciato a spegnersi. Fin dal ricovero si era avviato ad un peggioramento graduale ma veloce che avevo già visto in altri umani: meno fame, difficoltà a bere, energie che si spengono.
E’ sempre cosi.
Tutti sperano e dicono: si riprenderà.
No, caspita!
L’avete visto mille volte, non mentite.
È sempre uguale, tutti sanno che va a finire male… e mentono.
Il giorno che lo avevo portato in quel letto d’ospedale, evitandogli un trasporto in ambulanza che a quell’ora della notte, magari con la sirena, fa ancora più paura di qualsiasi viatico… quella notte mentre io guidavo, in fretta, prima che potesse accadergli qualcosa in macchina, noi soli nel buio d’una strada deserta, fuori città… mi disse:
– Dovete essere pronti…-
Non risposi, non avrei saputo cosa dire.
– Pronti a cosa? – sarebbe stata la mia unica risposta.
Pronto a cosa? Io non sono pronto a nulla.
– Non sono pronto alla mia morte, ma nemmeno alla tua…– avrei detto.
Non sono pronto alla morte di nessuno, di sconosciuti ma meno che mai di chi mi sta vicino. Di te, mio fratello, nato qualche anno prima di me. Vissuto finora più di me bambino. Io non sono pronto a questo perché NON SONO PRONTO A NIENTE…. non sono pronto a vivere, a fare scelte definitive, che anche quelle sono una morte, la morte di ciò che lasci per scegliere qualcos’altro . No, a me no puoi dire dovete essere pronti.
Non ero pronto nemmeno alla morte di mamma, appena un anno prima.
Chissà se ci stai pensando ora, coi tuoi dolori, seduto in macchina mentre ti porto al tuo ultimo letto d’ospedale, a mamma.
Certo, lei era vecchia, tu te ne vai con una porzione di vita ancora davanti e mille problemi che non hai risolto, mille cose sospese da rivedere, da decidere, di quelle che ti dici no, no… a questo ci devo pensare bene.. più avanti.
Quando non c’è più tempo dove finiscono le cose sospese?
Quella sera, più tardi, dalla sala d’attesa del pronto soccorso spiavo dalla porta semiaperta i discorsi col medico, un tuo collega che perciò ascoltava più che chiedere e magari tra se pensava se immaginavi di essere oramai arrivato.
Mi tornò in mente la scena di poche ore prima, quando ancora la crisi doveva venire, quando prendesti me e tua moglie in un unico abbraccio con le nostre fronti unite in un significativo gesto di intima solidarietà. In quel momento pensavo che ce l’avresti fatta, che ce l’avremmo fatta tutti a venirne fuori. Invece solo poche ore dopo eravamo li, in un freddo pronto soccorso.
Con signore preoccupate per una slogatura, uomini con botte in testa e punti di sutura da applicare.
Eccoci li ora. Io a guardare la morte in faccia, tu a resistere… forse solo qualche minuto, magari giorni invece.
Resistere cosi in uno stato che è già morte.
Senza sentire, senza dire o guardare… ogni energia tesa a mantenere un faticoso respiro che ogni volta pare spegnersi.
E invece si riprende, si riprende un misero lembo di tempo.
Pensavo al dopo… il dopo subito e più in la.
Al cimitero, ai pianti e alle mani strette di tanti che vedo quasi mai.
Appena l’anno prima alla morte di mamma. Li rivedrò tutti a ripetere quel rito in un cimitero ancora arso dal sole.
Siamo tutti destinatari di dolore.
Tutti.
Il dolore.
Il dolore è un rubinetto aperto sopra la testa.
L’acqua scorre giù, fino alla schiena.
Fredda. Ora è un brivido, ora nulla … ma c’è.
Scorre. Attraversa tutto, scolora le cose e offusca la vista, la distorce.
Perso nei miei pensieri non distoglievo la vista: dal suo viso, dal letto, dal suo respiro. Attento a coglierne ogni modifica, sospeso nell’attesa del respiro successivo:
– è vivo – pensavo ogni volta.
Il sole era alto, da fuori arrivava la sensazione del gran caldo. Allungai lo sguardo verso la finestra oltre il suo letto quando il respiro si arrestò.
Mi alzai di scatto dalla sedia. Prima che potessi capire si riprese, con una scossa. Aprì gli occhi e con la mano si spostò la maschera dell’ossigeno dalla bocca. Non sapevo che fare…
– Chiamo l’infermiera – dissi.
– No – rispose lui e in qualche modo tentò di afferrarmi un braccio, per fermarmi.
– No – ripeté.
Aveva gli occhi aperti ma non mi guardava, credo non vedesse. Lo sguardo era perso verso il soffitto ed era quello di un cieco.
– Ascolta, io sto morendo. Non c’è bisogno di dirlo. Si capisce. – disse.
Fece una pausa.
– Non vorrei… – aggiunse
– e non sono pronto –
Cosa avrei potuto dire?
– Non lo è nessuno – risposi
– Nessuno è pronto. Mai –
Continuava a guardare il soffitto, passava le mani nervosamente sul lenzuolo che lo copriva.
– Come si fa – disse
– Cosa si può fare? È tutto buio. È solitudine…- aggiunse.
In realtà nessuno sa nulla della morte.È esserci e poi non esserci più, è deserto e presenza. È pensare che eri li e che poi tutto continua come prima ma senza di te. Questo avrei dovuto dirgli?
– Nessuno sa nulla di questo, non lo sa nessuno – gli dissi.
Era come dirgli: tu morirai presto e nessuno può fare nulla. Nulla per farti stare sereno o meno solo. Nulla.
La morte è una grande solitudine per chi va e per chi resta. Solo che per chi resta poi passa, fino alla morte successiva, propria o di altri. Chi muore scompare in una grande solitudine, l’ultima senza ritorno.
Intanto si era sdraiato, più quieto. Anche non avere via d’uscita serve a rassegnarsi.
Non è un problema di religione, di coscienza, di pensiero. Qualsiasi credo è un’opzione o una speranza. La morte è solo certezza.
Si rimise la maschera sul viso, da sé.
Poi le braccia furono di nuovo abbandonate lungo il corpo.
Gli occhi chiusi.
Era di nuovo in premorte.
Provai a prendergli la mano. La strinse un attimo con la sua, o almeno cosi mi sembrò.
Poi di nuovo nulla. Inerme.
Mi rimisi seduto. Come prima. Davanti a lui. La finestra e il suo caldo estivo oltre. Il lenzuolo bianco. Il respiro di nuovo faticoso e i miei vestiti addosso che avrei voluto strappare via, tanto avevo fastidio.
Nulla. Passarono forse dieci minuti. Uguali. Pensavo a quella strana breve resurrezione . Alle parole. Al fatto che non ne avrei parlato con nessuno. Che fosse successo davvero o solo immaginato.
Altri dieci minuti ed entrarono altre persone. Troppe. Intorno al letto parlavano tra loro, a voce bassa quasi per non disturbare il suo sonno. Io stavo sempre li, seduto, senza partecipare a quella danza intorno al suo letto, a quel musicare di parole sulla sua malattia, il suo stato e i giorni a venire.
D’improvviso il respiro si fermò. Il volto divenne immobile. Fermo. Mi alzai soltanto senza avvicinarmi. Improvviso si fece silenzio. Un attimo. Qualcuno urlò – NO – si sollevò il pianto, più d’uno.
Non mi avvicinai.
Uscii dalla stanza. Il corridoio era lungo, bianco e diventava tunnel.
Stretto da togliere il respiro. Mi venne in mente un film di Brian De Palma.
– Io non voglio morire – pensai.
– Mai -.
Prefigurai il da farsi ora e il dopo che sarebbe stato.
Arrivai all’infermeria. Mi arrestai davanti alla prima infermiera che incontrai. Rimasi in silenzio un momento a guardarla poi le dissi:
– È morto –
Aventino Loi