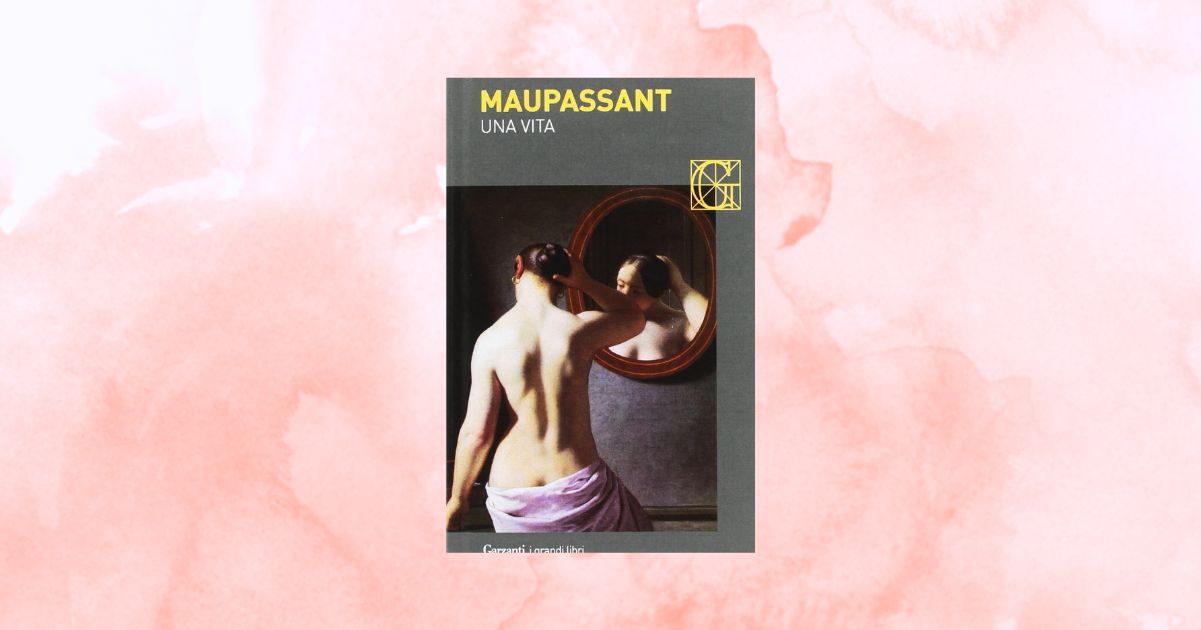Una goccia rossa solletica l’interno delle mie cosce fredde e sporche, la vedo scendere e colorarmi la pelle fino a ricoprire le nude caviglie. La pancia è molto gonfia, la stringo tra le mani ma fa tanto male. La maledizione è già arrivata, mi distendo nella pozza di sangue. L’uomo dalla lunga barba aveva ragione, forse è davvero questo il modo in cui è punita una bambina che non obbedisce alla legge dei potenti. I potenti, s’intende, sono gli uomini dai denti d’oro che alitano tabacco e menta, quelli che commerciano con ottanta mucche per averci. Per me ne sono bastate molto meno, io non valgo così tanto bestiame, ho poca carne intorno le ossa. Se chiudo gli occhi posso assaporare l’odore del cibo, se mi concentro posso sentirlo sotto i denti e non ho più fame. No, è una bugia e lo stomaco me la urla in faccia con un boato. Taci. Devi stare zitto. Smettila di dar voce al silenzio, per natura egli è vuoto come te e me.
Una brava donna deve chinare il volto dinanzi al suo padrone, adorarlo al par di un Dio. Deve imparare a lavare i piatti, a cucinare. Non importa quanti anni abbia, non ha importanza che sia piccola, adolescente o adulta. Il numero non conta, non ha significato per chi non sa contar bene, io però so leggere e ho imparato a scrivere il mio nome prima dei sei anni. Lo vedo da sempre sulla striscia bianca che mio zio mi lega al polso. Dice che tutte queste donne lo mandano in confusione, che è troppo vecchio per ricordare chi siamo. Avrebbe voluto del bestiame, con quello non gli sarebbe di certo mancato il pane. Guardo l’albero di pesco e suoi sterili rami, ne sento ancora il profumo disperdersi nel vento e tra i capelli. Erano i fiori preferiti di mia madre, amava raccontare che la loro nascita era dovuta ad un vecchio pescatore che dopo aver tirato a riva con fatica un grosso pesce, trovò custodito al suo interno uno strano e grosso nocciolo. Incuriosito decise di piantarlo, dopo qualche tempo vi nacque un alberello che nei mesi primaverili si vestì di graziosi fiori dalle sfumature rosee.
Così immagino quegli uomini dalle mani callose e dalle reti a parete, in cerca di quel seme che possa dar vita a ciò che debba vestire con straordinaria bellezza le proprie città. Lei è morta arsa dalle fiamme del peccato, così c’hanno detto. Io non l’ho più vista, forse l’ho sentita imprecare o forse l’ho sognata. Ashim è il piccolo della famiglia, la sorte lo ha baciato rendendolo uomo, riesco ancora a guardarlo senza essere impaurita dall’ombra che un giorno proietteranno le sue larghe spalle, gli prendo la mano ed eccoci fuori a giocare. Mi piace sentire i piedi sfiorare i sassi sulla strada che porta al fiume. Tolgo le scarpe calciando il pallone con forza, chinandomi verso le dita livide nel tentativo di sfiorarle. Percepisco appena la stretta che come una morsa rinchiude il mio braccio. Con il volto emaciato e gli occhi incavati e spenti, mia sorella stringe qualcosa tra le braccia. Mi fermo ad osservarla mentre continua imperterrita nella morsa sperando di richiamare la mia attenzione, forse quell’uomo dall’aspetto tetro e malandato che l’ha comprata e che oggi rivedo al suo fianco, le ha concesso qualche bambola per giocare.
Un gemito si scaglia contro i sogni infantili che lascio cadere tra la sabbia e le mie impronte, riportandomi con forza alla realtà di quel ghetto che chiamo casa. Assente e priva di qualsiasi sensazione, giaccio immobile, incantata da quella creatura così piccola che ricorda in qualche modo il grosso nocciolo della storia di mia madre. Fatima accenna un sorriso ricoprendolo di una finta felicità, ma fugge lo sguardo mostrandosi rea confessa della menzogna a cui le sue labbra si sono lasciate andare. L’istinto mi porta a respingere la creatura che le ho visto ospitare nel prematuro ventre per molti mesi, la stessa fiorente di vita che avvolge qui davanti, quella che in cambio l’ha uccisa nel corpo e nell’anima.
Maledico il tono di voce fioco con cui accompagna la preghiera, colpevole nel sentirmi troppo ingenua e non abbastanza grande per comprendere il muto dolore che porta con sé, celato dietro la lunga stoffa che accarezza i lineamenti induriti, catino di innumerevoli pianti amari. Mi sollevo abbandonando l’isola di salvezza che rappresenta il mio letto; la notte è l’unica parte del giorno che sembra rendere questa vita migliore. Spesso mi fermo ad osservare la luna così superba nell’aspetto, donna persino nella rotondità delle sue forme, nonché madre delle infinite stelle del firmamento. Il sole potrà anche beffarsene tutto il giorno, non renderà mai vana la speranza che la spinge a donare quella flebile luce, quasi a voler dire a ciascun viandante dell’oscurità: “Io son qui e ti proteggo da coloro che fuggi, abbi fede e la salvezza ti sarà mostrata.” Troppe volte, maestosa luna t’ho guardata, convincendomi che quel tuo dire fosse di certo rivolto a me, ma altrettante volte ti sei lasciata coprire dalle nubi ed io dalle mie paure e morivamo insieme come le arabe fenici, con la promessa che saremmo risorte ancora e per sempre.
Uno sciame di voci disturba il riposo che avrei desiderato prolungare di qualche ora, poso i talloni in terra lasciando dietro di me la stanza da letto. I suoni si materializzano nei corpi di giovani fanciulle che riempiono la casa nei piccoli spazi, come formiche che percepiscono l’arrivo delle
pioggia corrono impazzite da una parte all’altra. Fatima si rivela a capo delle laboriose ancelle che seguono fedeli ogni comando venga loro rivolto. Un senso di colpa mi invade, scaraventando la pesantezza che chiude pian piano le dormienti palpebre, la stringo forte per scomparire in un abbraccio, quasi a sentirmi figlia di quel gesto rubato. Circondata da una strana felicità che ha il volto di ogni singola premura che mi viene rivolta, concedo le mani ad una vecchia signora che posa una stringa dal beccuccio in plastica sulla pelle. Al suo interno intravedo una pallida polvere che emana odore d’arancio. Non conosco l’identità dell’artista che dipinge il mio corpo, malgrado ciò respiro la storia della sua vita, di cui se ne fanno schermo gli occhi nel loro giallo intenso che richiama quello del grano appena maturo o magari per via delle rughe che si irraggiano intorno sono l’astro calante al tramonto. Le linee decise, i solchi profondi che cadono dagli angoli dalle labbra al mento mi parlano e lo fanno attraverso una lingua che conosco, un dialetto soffocato che ti squarcia in viso e che pertanto non puoi nascondere.
Il temporale che ha distrutto per anni la città del mio essere vede la fine e il suo principio è la linea ricurva di un sorriso, quella d’un arcobaleno sospeso tra gli svariati riflessi di luce, specchio di calma e di speranza. Impedisco il percorso che una lacrima riversata sarebbe sul punto di compiere, per non cadere nella banalità del gesto, che renderebbe vana l’unicità dell’evento. La notte che precede il giorno della rinascita mi trova sveglia e con poca quiete. Nei minuti da dormiente sono veggente d’incubi zuppi d’angoscia. Con la testa bagnata annego nel basso cuscino bianco, attendendo il miracoloso salvataggio che arriverebbe con l’elevarsi del mattino. Giunto il momento della partenza, chiusa nella prigione velata, sono pronta ad abbandonare il grembo materno che m’ha accolto per una notte che è parsa durare interi mesi. Sono rivolta al mio amore, così grande d’età, gobbo nella statura eppure ardente nelle palle degli occhi e muta assisto a quell’infame addio che me lo nega. Le anime ferite non hanno bisogno di riverenze né di complimenti, s’intrecciano e danzano fino all’estremo, lasciando in disparte le nostre persone, troppo terrene per comprendere il riconoscimento che raggiunge veloce i gonfi precordi del cuore e che tace ogni rovente passione.
Fatti stretti i lacci del mio andare, il piccolo mondo che qualche Dio m’ha messo ad abitare mi fa largo tra la folla. D’improvviso c’è una luce di speranza, è una luce che reclama sottovoce, che mi invade per metà e mi fa sua. L’aria nel respiro è fresca, non ha peso ed è leggera come un soffio a portar oltre qualche petalo di fiore. Scintille infuocate s’innalzano a sfiorare i tetti della piazza, migliaia di donne sollevano niquab tra le dita, strepitando ed agitando parole volanti, spediscono drappi scuri nel vortice di fiamme che nelle fauci scintillanti danno inzio alla sparizione. Sono dinanzi ad un rogo e al fervore della popolazione che ne alimenta la durata. Capelli lunghi e curve piene avanzano tra cantilene sonanti, che sembrano aver ingurgitato quella parte maschile posta, bigotta e sbigottita, ai soli margini della faccenda. L’astuzia vorrebbe eclissarmi facendo uso della furia, ma quel grido di protesta è una guerra senza armi più allettante da ascoltare. Ignara delle ragioni che le hanno condotte fin qui sono vicina all’olocausto disperato e sono attratta da quel mantra che rivela ad una ad una le guerriere nella loro identità, possibile solo nella liberazione concessa da quel gesto. Come quelle anch’io ho desiderato strappare l’elmo posto in difesa del mio io, ed è avvenuto al nostro primo incontro, quando il suo ruolo m’avrebbe condotta nel letto d’un padrone. Le gambe cedono e senza averne cura, sono parte di quel tutto: via la copertura, via l’insensato sgomento. Occhi scuri su un viso apparentemente tumefatto mi raggiungono in sogno. Il coltello del trascinatore batte forte sul torace, fa rumore.
Nell’opposizione che rivelo sento male ad un braccio, preme forte fino a pungere le ossa. Sono sveglia e il mio padrone è qui. La provocazione lo colora di rabbia, la violenza gli invade il volto. Resa visibile all’inseguitore segno la mia stessa condanna. -Perdonami mio grande amore se sono stata io a tradirci. Adesso il cuore s’è fermato, ho tentato di sentirlo nel volteggio naturale ma non c’è. Mi domando se gli angeli che vegliano le spalle siano ancora in vita o stan toccando il cielo insieme a me: “Aleikum salam angeli miei, aleikum salam.”
La carne anestetizzata dal gelo si schianta sulla corteccia dall’albero che mi crocefigge, il legno graffia senza tregua l’intera schiena. Il diavolo sputa in terra la palla verde di erba e con le mani chiudo la bocca nel tentativo di fermare quella scossa dallo stomaco. È su di me, sento il respiro affannoso divorare la pelle morta. Solleva le braccia sulla sua testa ed apre le gambe strappando quel che mi copre. Un viscidume si spalma addosso e mentre grido di avere pietà, il motore del cuore aziona l’ingranaggio. Speri che quel meccanismo si fermi, cerchi un appiglio in tutti i modi che conosci ma è sordo alla supplica: ti dà vita nella morte ricercata. Mi schiaffeggia e sono detta peccatrice e così prega. Sì lui prega, come un uomo giusto alla Moschea, lui m’uccide e grida Allah. Le ultime parole che ho lasciato entrare nel mio corpo recitavano più o meno: Credo d’essere svenuta o aver perso i sensi per il forte dolore che mi premeva di sotto. Mi riapre gli occhi con un dito tirando quasi il bulbo di fuori, vuole che assista al processo di creazione che mi farà madre di sangue del mostro che cerca di mettermi dentro. Ho visto l’assassino respirare un’ultima volta e m’ha persino sputato addosso una parte di sangue grumoso che porto ancora sulla lingua. È stata mia madre a scendere su di me, s’è impossessata della mia anima sfranta, ha preso il ciondolo maledetto e gliel’ha conficcato nel petto. Lo spingo via dall’oggetto del martirio udendone il tonfo finale. Qualche centimetro fatto sulle punte, priva di scarpe non poso nemmeno i talloni in terra. Sedutami vedo il sangue in ogni dove.
Nella nostra lingua “Aidha” è un nome parlante. Non so se mia madre abbia scelto per me la sorte che m’avrebbe accompagnato, mi piace pensare che sia stato così. Ho vissuto due volte e nel mio secondo tempo ho attraversato luoghi che immaginavo esistere nelle fandonie di chi attende la morte per avere un meritato premio d’arrivo. Ho camminato per l’inferno, visionando uomini legati a rupi esser divorati da feroci belve assatanate e nei loro lamenti il rimbombo dei sorrisi risorti di bambine scomparse che, disposte sui loro capi, prendevano per mano fanciulli alati e intonavano canzoni, cantilene di un’infanzia allontanata. È buffo, siamo condannati a non avere memoria del momento in cui chi ci ha generato esala quella spinta che ti butta fuori: sei proiettile che agisce al contrario, non colpisci ma fuoriesci dal corpo ferito.
Il sangue versato è lo stesso d’un omicidio, le ossa rotte sono quelle che puoi avere dopo una baruffa, forse è per questo che non ricordiamo, perché basti il tocco di una madre a farti sentire in vita, a far scattare una memoria tattile che ti farà riconoscere quell’odore anche dopo milioni di anni. Io quel profumo l’ho sentito, era quello dei fiori rosa che galleggiano nel vento di marzo, eppure siamo ad ottobre. Un morso tira via il cordone e schizzo fuori dalla palude di anime.
Venuta al mondo ancora una volta, ho riaperto i fanali appannati e sfioratami sono genitrice di me stessa. Il vagito ha schiuso i polmoni, il pianto è sceso abbondante. Ho sentito gocce di rugiada venir via dalle ciglia affrante, ami uncinati pronti a sradicare la pena, mi hanno pulita e lavata con spugne di fogliame sparso e mentre la pelle infiammata chiedeva perdono, la psiche malata s’accucciava nel disonore. Prigioniera del reato che m’hanno portata a compiere, mi sono ritrovata a scontare una legge interiore che finisce per accusarti e punirti in una segregazione che sembra abbattere anche la folle idea di riportarti a casa. Quale difesa m’avrebbe liberato dalle colpe di un’assassina, quale testimone avrebbe annunciato l’illibatezza e il candore d’un omicida?
Aidha è “colei che parte ma ritorna”, forse un giorno tornerò.
Marika Vista