Salvatore Quasimodo e la disillusione urbana “In questa città”
Una poesia urbana che è anche una poesia sulle tragedie della guerra. Salvatore Quasimodo, si apre con versi liberi: “In questa città”.
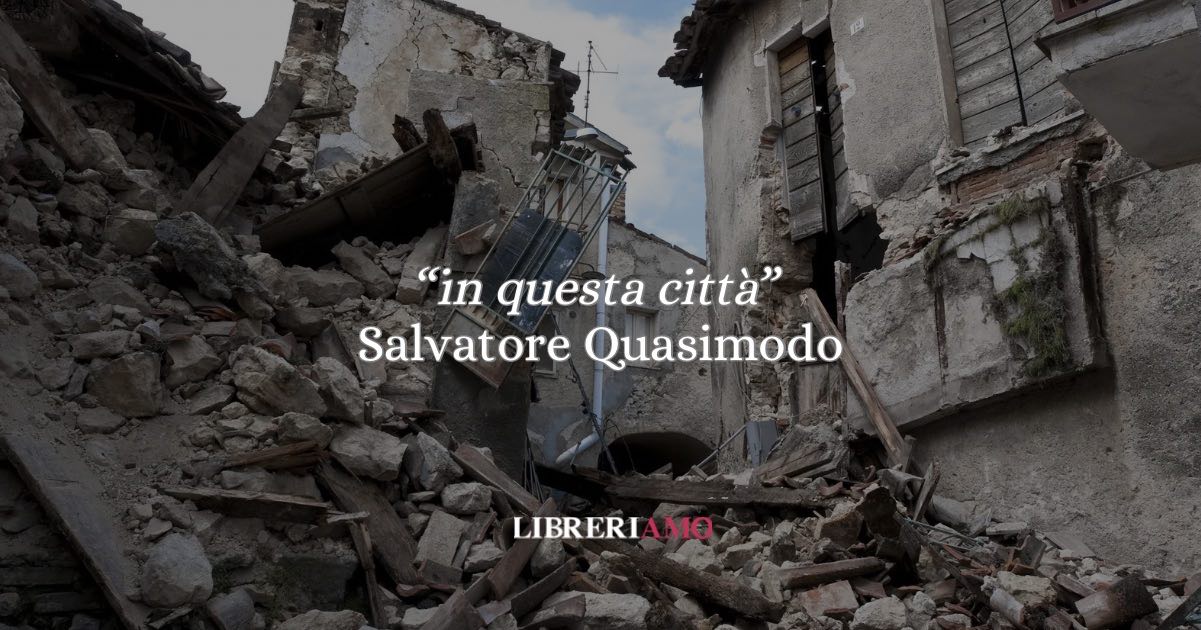
Salvatore Quasimodo, premio Nobel per la Letteratura nel 1959, è stato uno dei protagonisti della poesia italiana del Novecento: dapprima esponente dell’ermetismo, poi come poeta di versi liberi. “In questa città” appartiene alla seconda stagione poetica e riflette la tensione post-bellica narrata in un contesto urbano contemporaneo. In essa troviamo uno stacco netto con le poesie degli anni ’30 — intime e sospese; ora, la disillusione domina la scena con un linguaggio che si apre alla denuncia sociale, al senso di alienazione dell’uomo moderno.
La città e la disillusione
La “città” evocata nel titolo non è solo un luogo fisico, ma un simbolo della condizione esistenziale e collettiva dell’uomo del Novecento. Tanto quanto Pasolini lamentava il cambiamento, Quasimodo lo narra e nei versi trasforma l’esperienza urbana in una metafora di depersonalizzazione e perdita, restituendo al lettore immagini cupe e stranianti.
“In questa città” di Salvatore Quasimodo
In questa città c’è pure la macchina
che stritola i sogni: con un gettone
vivo, un piccolo disco di dolore
sei subito di là, su questa terra,
ignoto in mezzo ad ombre deliranti
su alghe di fosforo funghi di fumo:
una giostra di mostri
che gira su conchiglie
che si spezzano putride sonando.
È in un bar d’angolo laggiù alla svolta
dei platani, qui nella mia metropoli
o altrove. Su, già scatta la manopola.
La guerra e la città
La poesia sembra voler catturare l’essenza di un’esperienza alienante e industrializzata: la città come luogo che “stritola i sogni” attraverso i suoi ingranaggi invisibili, ma inarrestabili. E leggendo tra le righe, analizzando i versi, sarà più facile scorgere l’orrore della guerra tecnologica che di primo acchito sembra passare in sordina. Il “fosforo” e i “funghi di fumo” aprono infatti a una lettura drammatica, in cui il pericolo non è solo sociale, ma anche militare.
Quasimodo mostra come la modernità possa contenere, sotto la superficie di piccoli gesti, un potenziale di distruzione. La “macchina che stritola i sogni” si attiva con un gesto minimo — l’inserire un “gettone” o far scattare una “manopola” — ed è capace di trasformare la realtà in un incubo.
“Ombre deliranti su alghe di fosforo funghi di fumo”
È qui che si concentra l’ambiguità più forte. Il “fosforo” non è solo un’immagine luminosa, ma può alludere al fosforo bianco, arma chimica nota per bruciare al contatto e per il fumo tossico che sprigiona. “Funghi di fumo” è espressione che richiama visivamente il fungo atomico, ma anche le nuvole delle esplosioni incendiarie.
“Una giostra di mostri che gira su conchiglie che si spezzano”
La giostra, di solito associata al gioco e all’infanzia, qui è popolata di figure mostruose e si muove su elementi fragili e marci. È la metafora di un divertimento illusorio che si sgretola, ma anche di caos apocalittico, di persone in fuga.
“Su, già scatta la manopola”
Una chiusura secca, improvvisa, che suggerisce l’impossibilità alla via di fuga. Il meccanismo si mette in moto. In chiave civile è il meccanismo quotidiano che si avvia, in chiave militare è il momento in cui si lancia l’attacco: la mano che aziona il comando, il gesto irreversibile.
Nota biografica e interpretazione
Nato a Modica nel 1901 ha vissuto le due guerre mondiali e ha attraversato un secolo segnato da conflitti, dittature e innovazioni tecnologiche capaci di annientare intere città. Dopo un primo periodo ermetico, la sua poesia si è aperta a temi sociali e politici, diventando sempre più attenta alle tragedie collettive.
Nella sua esperienza di uomo e poeta, il trauma della guerra non è mai stato un ricordo distante: è materia viva, capace di riaffiorare sotto forma di immagini simboliche. In “In questa città”, la presenza del “fosforo” e dei “funghi di fumo” può essere letta come eco della memoria storica delle devastazioni belliche, dalla Seconda Guerra Mondiale alle tensioni della Guerra Fredda. La “macchina” è anche la modernità che ha reso la distruzione un processo industriale e anonimo: basta una “manopola” per passare dalla pace alla catastrofe.
Una poesia che parla anche al presente
“In questa città” è un testo che lascia il lettore in bilico tra due mondi: quello della metropoli alienante e quello della guerra, con i suoi scenari irreversibili. La poesia non sceglie una sola interpretazione, ma si muove su un doppio registro. Da un lato denuncia l’inerzia e l’indifferenza della vita moderna, dove i sogni si consumano nella routine; dall’altro lascia intravedere la minaccia concreta di una distruzione immediata, attivata da gesti minimi.
In questo senso, la forza del testo sta proprio nella sua ambiguità: la “macchina” può essere vista come una metafora universale del potere incontrollabile, che sia quello della tecnologia, della guerra o della società di massa. Il lettore, come il poeta, è posto davanti a un bivio di interpretazioni, ma in ogni caso resta con la sensazione che la “manopola” possa scattare in qualsiasi momento; proprio per questo deve riflettere sul suo ruolo nel mondo.