Ognissanti di Alessandro Manzoni, la poesia che svela la forza del bene silenzioso
Scopri “Ognissanti” di Alessandro Manzoni, la poesia che celebra la santità nascosta e la forza silenziosa del bene che illumina la vita di ogni giorno.
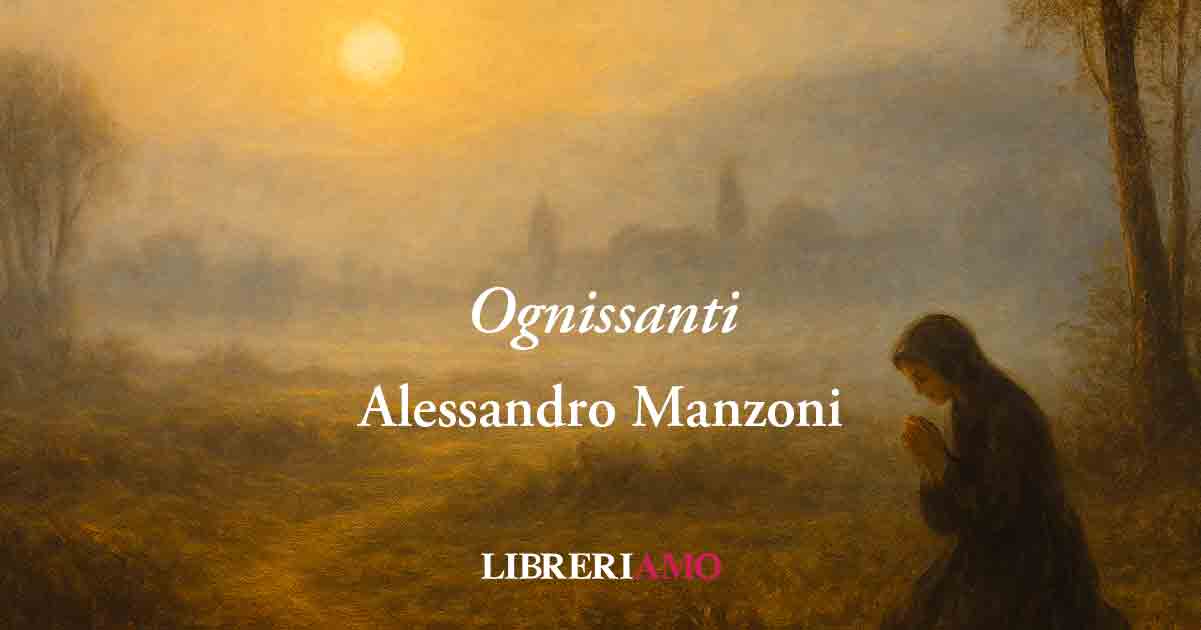
Ognissanti di Alessandro Manzoni è una poesia che sembra non appartenere alla terra ma a un luogo sospeso, dove la luce incontra la nebbia e la vita si fa preghiera.. È un inno scritto con voce umile e limpida, che guarda al cielo ma parla della terra, di chi vive nella fatica quotidiana senza mai rinunciare alla purezza.
Manzoni non canta i santi dei miracoli o delle statue, ma quelli nascosti, gli uomini e le donne che hanno scelto il bene quando nessuno li guardava. È una poesia che non celebra l’eroismo, ma la costanza, la forza silenziosa di chi resta fedele a un’idea di giustizia interiore.
Ognissanti è una poesia incompiuta, una delle opere più desiderate da Alessandro Manzoni e forse proprio per questo non riuscì a completare.
Leggiamo questa poesia di Alessandro Manzoni per scoprire com’è nata e qual è il significato.
Ognissanti di Alessandro Manzoni
Cercando col cupido sguardo,
tra il vel della nebbia terrena,quel Sol che in sua limpida
piena v’avvolge or beati lassù;il secol vi sdegna, e superbo
domanda qual merto agli altari
v’addusse; che giovin gli avari
tesor di solinghe virtù.A Lui che nell’erba del campo
la spiga vitale nascose,il fil di tue vesti compose,
de’ farmachi il succo temprò,che il pino inflessibile agli austri,
che docile il salcio alla mano,
che il larice ai verni, e l’ontano
durevole all’acque creò;a Quello domanda, o sdegnoso,
perché sull’inospite piagge,
al tremito d’aure selvagge,
fa sorgere il tacito fior,che spiega davanti a Lui solo
la pompa del pinto suo velo,
che spande ai deserti del cielo
gli olezzi del calice, e muor.E voi che gran tempo per ciechi
sentier di lusinghe funeste,
correndo all’abisso, cadeste
in grembo a un’immensa pietà;e, come l’umor, che nel limo
errava sotterra smarrito,
da subita vena rapito
che al giorno la strada gli fa,si lancia e, seguendo l’amiche
angustie, con ratto gorgoglio,
si vede d’in cima allo scoglio
in lucido sgorgo apparir,sorgeste già puri, e la vetta,
sorgendo, toccaste, dolenti
e forti, a magnanimi intenti
nutrendo nel pianto l’ardir,n timido ossequio non veli
le piaghe che il fallo v’impresse:
un segno divino sovr’esse
la man, che le chiuse, lasciò.Tu sola a Lui festi ritorno
ornata del primo suo dono;
Te sola più sù del perdono
l’Amor che può tutto locò;Te sola dall’angue nemico
non tocca né prima né poi;
dall’angue, che, appena su noi
l’indegna vittoria compiè,traendo l’oblique rivolte,
rigonfio e tremante, tra l’erba,
sentì sulla testa superba
il peso del puro tuo piè.
Una poesia dalla storia intrigante e che rimase incompiuta
Ognissanti è una delle ultime e più meditate poesie di Alessandro Manzoni, un testo che racchiude tutta la sua maturità spirituale e poetica. La sua genesi fu lunga e tormentata, come spesso accade per le opere che segnano la fine di un cammino.
L’idea di scrivere un inno dedicato alla festa di Tutti i Santi risale già al progetto originario degli Inni Sacri del 1812, ma solo nel dicembre del 1830 Manzoni ne fissò per iscritto il titolo e alcune epigrafi bibliche nel codice braidense. In quei versetti era già racchiuso il nucleo profondo della poesia: l’unità dei fedeli in Cristo, la santità come segno di comunione e non come trionfo individuale.
Tuttavia, il poeta non andò oltre un abbozzo. Le carte furono persino strappate, segno di un’inquietudine che non trovava pace.
Fu soltanto nell’ottobre del 1847 che Manzoni riprese in mano il progetto. In una lettera al figlio Pietro scrisse di averne già composto un terzo, ma confessò che l’ispirazione stava affievolendosi. Disse con malinconia che Ognissanti era stata “cominciata troppo tardi”, quando non era più la poesia a cercarlo ma lui a inseguirla.
Nel 1860, colpito dalla lettura di La Paysanne della poetessa francese Louise Colet, Manzoni trovò in quei versi la stessa intuizione che lo aveva guidato, ovvero la bellezza delle anime nascoste che vivono solo per lo sguardo di Dio. Le inviò dunque alcune quartine del suo inno, che lei pubblicò nello stesso anno in Francia.
Solo nel 1914 il testo completo venne dato alle stampe dal Pio Istituto pei Figli della Provvidenza di Milano, grazie all’autografo conservato alla Biblioteca Braidense e donato dal poeta alla moglie Teresa.
Ognissanti avrebbe dovuto far parte del ciclo degli Inni Sacri, ma ne rimase fuori perché incompiuta. Eppure ne condivide pienamente lo spirito: la stessa fede nella grazia, la stessa armonia tra linguaggio poetico e visione religiosa.
È scritto in quartine di novenari, con un ritmo lento e meditativo, e alterna immagini della natura a metafore spirituali che raccontano la santità come purezza interiore.
Un testamento spirituale sulla santità invisibile
Più che un inno religioso, Ognissanti è un testamento. È il canto di un uomo che non cerca più la gloria dei grandi gesti, ma la verità che si nasconde nella semplicità.
Alessandro Manzoni guarda ai santi come a un riflesso dell’umano, chi ha sbagliato, chi si è rialzato, chi ha saputo credere ancora nella bontà del mondo.
La santità, per lui, non è trionfo ma cammino. Non è luce che abbaglia, ma bagliore che resiste nella nebbia. È la voce silenziosa del bene che vive accanto a noi e che ogni giorno, senza rumore, tiene in vita la speranza del mondo.
Ognissanti celebra la purezza silenziosa e la forza nascosta del bene
Ognissanti di Alessandro Manzoni è una poesia che parla al cuore degli uomini comuni e invita a scoprire la santità che vive nella semplicità dei gesti e nella luce interiore dei cuori puri. L’inno si apre con l’immagine di anime che cercano Dio con sguardo ardente, “cercando col cupido sguardo, tra il vel della nebbia terrena, quel Sol che in sua limpida piena v’avvolge or beati lassù”. È il desiderio di oltrepassare la materia per raggiungere la luce divina, quel Sole che illumina i beati e che all’uomo resta ancora velato dalla nebbia.
Il poeta mostra come il mondo non riesca a comprendere questa tensione verso il cielo. “Il secol vi sdegna, e superbo domanda qual merto agli altari v’addusse”. Il secolo rappresenta la società terrena che misura il valore in base all’utilità e al successo e non comprende le virtù silenziose di chi vive appartato senza cercare gloria. Manzoni difende la purezza interiore dei santi che accumulano “tesor di solinghe virtù”, ricchezze invisibili che non si mostrano ma che rendono più umano e luminoso il mondo.
Il poeta invita allora a rivolgere lo sguardo al Creatore. “A Lui che nell’erba del campo la spiga vitale nascose, il fil di tue vesti compose, de’ farmachi il succo temprò”. Dio è presente in ogni cosa, nella spiga che nutre, nel lino che diventa veste, nei succhi delle piante che guariscono. L’armonia della natura è riflesso della sua sapienza e ogni creatura, anche la più fragile, ha una funzione perfetta. “Che il pino inflessibile agli austri, che docile il salcio alla mano, che il larice ai verni, e l’ontano durevole all’acque creò.” Nella varietà della creazione si manifesta l’amore divino che tutto dispone con misura.
Poi il poeta si rivolge a chi deride la vita contemplativa e chiede di interrogare Dio. “A Quello domanda, o sdegnoso, perché sull’inospite piagge, al tremito d’aure selvagge, fa sorgere il tacito fior.” Il fiore che nasce nel deserto è l’immagine più delicata e commovente della poesia. “Che spiega davanti a Lui solo la pompa del pinto suo velo, che spande ai deserti del cielo gli olezzi del calice, e muor.” È il simbolo della santità silenziosa che non ha spettatori ma vive solo per lo sguardo di Dio. È il fiore che muore dopo aver profumato il cielo e che rappresenta la bellezza nascosta del bene.
Nelle strofe successive Manzoni si rivolge ai santi che hanno conosciuto la caduta e la grazia. “E voi che gran tempo per ciechi sentier di lusinghe funeste, correndo all’abisso, cadeste in grembo a un’immensa pietà.” I santi non sono perfetti, ma redenti. La loro storia non è priva di errori, è segnata dal perdono e dalla misericordia divina. L’immagine dell’acqua che scorre nel fango e poi risale limpida rende visibile il miracolo della conversione. “Come l’umor, che nel limo errava sotterra smarrito, da subita vena rapito che al giorno la strada gli fa, si lancia e, seguendo l’amiche angustie, con ratto gorgoglio, si vede d’in cima allo scoglio in lucido sgorgo apparir.”
Il ritorno alla luce è faticoso ma pieno di forza. “Sorgeste già puri, e la vetta, sorgendo, toccaste, dolenti e forti, a magnanimi intenti nutrendo nel pianto l’ardir.” Qui Manzoni mostra la grandezza della sofferenza redenta. Il dolore diventa energia spirituale e le ferite del peccato diventano testimonianza della grazia. “Un timido ossequio non veli le piaghe che il fallo v’impresse. Un segno divino sovr’esse la man, che le chiuse, lasciò.” Quelle cicatrici sono il segno dell’incontro tra la fragilità umana e la misericordia divina.
Nella parte finale la poesia si illumina della figura della Vergine. “Tu sola a Lui festi ritorno ornata del primo suo dono. Te sola più sù del perdono l’Amor che può tutto locò.” Maria è la sola che non ha conosciuto la colpa. “Te sola dall’angue nemico non tocca né prima né poi.” Ella rappresenta la purezza assoluta, l’unione perfetta con l’amore divino e la vittoria definitiva sul male. L’immagine conclusiva del serpente vinto suggella la visione manzoniana della redenzione. “Traendo l’oblique rivolte, rigonfio e tremante, tra l’erba, sentì sulla testa superba il peso del puro tuo piè.”
In ogni immagine di questa poesia c’è un movimento ascendente. Dalla terra al cielo. Dalla colpa al perdono. Dalla nebbia alla luce. Ognissanti è un viaggio spirituale che insegna a riconoscere la grandezza nascosta del bene. Vive nelle anime semplici. Nei cuori silenziosi. Nella luce di chi fa il bene senza bisogno di essere visto.
E forse oggi, in un mondo che misura tutto con la visibilità e l’apparenza, il messaggio di Alessandro Manzoni risuona ancora più forte. Ci ricorda che la vera nobiltà dell’anima non sta nel rumore, ma nel silenzio. Che la bellezza non ha bisogno di essere mostrata per esistere. E che la santità più alta è quella che non si proclama, ma che ogni giorno, nel segreto, continua a rendere il mondo un po’ più giusto, un po’ più luminoso, un po’ più umano.