“Ode al vento occidentale”, una poesia di P. B. Shelley che parla di speranza
Nella poesia “Ode al vento occidentale” di P. B. Shelley si esalta natura, simbolo delle perdite del poeta e anche rinascita. Una visione avanguardista, scopri.
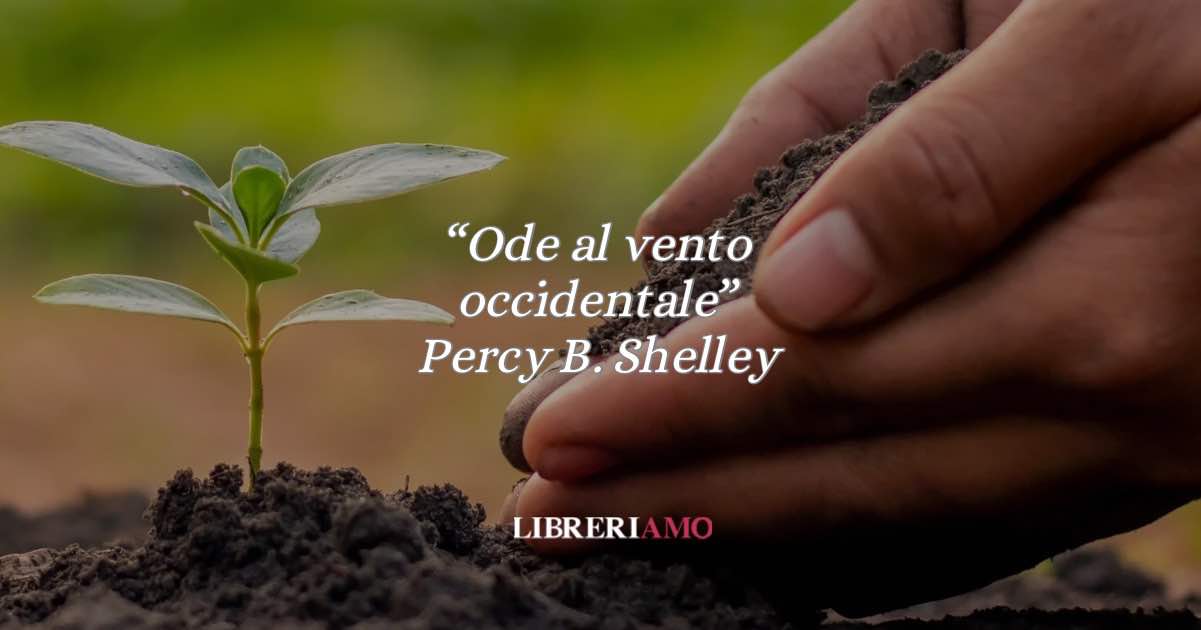
Una presenza invisibile, il vento occidentale che trascina le foglie morte in un autunno (V. 2) fatto di spettri in fuga (V. 3): ecco cos’è il respiro della natura per Percy Shelley. Ma non c’è solo rovina in quello Spirito Selvaggio (V. 14), e Shelley, che ha già conosciuto il dolore delle perdite familiari, sa trovare del buono anche nel tumulto.
Le perdite di Shelley
Nato nel 1792 e morto tragicamente annegato nel 1822, Percy Bysshe Shelley fu uno dei poeti principali del Romanticismo inglese. La sua vita fu breve — morì a soli trent’anni — e segnata da scelte scandalose per l’epoca: l’ateismo in primis, la sfida alle convenzioni sociali e gli amori liberi, che lo portarono a soffrire per la perdita della prima moglie, Harriet Westbrook, la quale si suicidò gettandosi in un laghetto a Londra, nel pieno della sua gravidanza, a causa del benservito di Shelley.
Il suo percorso ne fu segnato, ma questo avveniva prima della perdita dei figli con Mary Shelley —la famosissima autrice di Frankenstein. In questo orizzonte di inquietudine e ribellione, nel 1819 scrisse a Firenze la sua “Ode al vento occidentale”, che ancora oggi è considerata una delle vette assolute della poesia romantica e che molti traducono erroneamente come una poesia romantica nel vero senso della parola.
Un ritratto di Shelley
L’“Ode al vento d’autunno” è molto più di un inno alla Natura: è il ritratto di Shelley stesso. In essa il vento diventa metafora della Natura, della Storia, della Poesia stessa. Il vento che distrugge e protegge, che scuote mari e cieli, che solleva e incatena è immagine della sua vita segnata da ribellione, lutto, esilio e speranza. Nei versi più intimi troviamo il suo dolore personale, nei passaggi profetici la sua visione politica, e nel finale la sua fede nella rinascita.
“Ode al vento occidentale” di P. B. Shelley
I.
Oh tu Vento selvaggio occidentale, alito
della vita d’Autunno, oh presenza invisibile da cui
le foglie morte sono trascinate, come spettri in fugada un mago incantatore, gialle e nere,
pallide e del rossore della febbre, moltitudini
che il contagio ha colpito: oh tu che guidii semi alati ai loro letti oscuri
dell’inverno in cui giacciono freddi e profondi
come una spoglia sepolta nella tomba,finché la tua azzurra sorella della Primavera
non farà udire la squilla sulla terra in sogno
e colmerà di profumi e di colori vividiil colle e la pianura, nell’aria i lievi bocci
conducendo simili a greggi al pascolo; oh Spirito selvaggio,
tu che dovunque t’agiti, e distruggi e proteggi: ascolta, ascolta!II.
Tu nella cui corrente, nel tumulto
del cielo a precipizio, le nuvole disperse
sono spinte qua e là come foglie appassitescosse dai rami intricati del Cielo e dell’Oceano,
angeli della pioggia e del fulmine, e si spargono
là sull’azzurra superficie delle tue onde d’ariacome la fulgida chioma che s’innalza
sopra la testa d’una fiera Menade, dal limite
fioco dell’orizzonte fino alle altezze estreme dello zenit,capigliatura della tempesta imminente. Canto
funebre tu dell’anno che muore, al quale questa notte che si chiude
sarà la cupola del suo sepolcro immenso, sostenuta a voltada tutta la potenza riunita dei vapori
dalla cui densa atmosfera esploderà una pioggia
nera con fuoco e grandine: oh, ascolta!III.
Tu che svegliasti dai loro sogni estivi
le acque azzurre del Mediterraneo, dove
si giaceva cullato dal moto dei flutti cristalliniaccanto a un’isola tutta di pomice del golfo
di Baia e vide in sonno gli antichi palazzi e le torri
tremolanti nel giorno più intenso dell’onda,sommersi da muschi azzurri e da fiori dolcissimi al punto
che nel descriverli il senso viene meno!
Tu per il cui sentiero la possentesuperficie d’Atlantico si squarcia
e svela abissi profondi dove i fiori
del mare e i boschi fradici di fango, che indossanole foglie senza linta dell’oceano, conoscono
la tua voce e si fanno all’improvviso grigi
per la paura e tremano e si spogliano: oh, ascolta!IV.
Fossi una foglia appassita che tu potessi portare;
fossi una rapida nuvola per inseguire il tuo volo;
un’onda palpitante alla tua forza, e potessicondividere tutto l’impulso della tua potenza,
soltanto meno libero di te, oh tu che sei incontrollabile!
Potessi essere almeno com’ero nell’infanzia, compagnodei tuoi vagabondaggi alti nei cieli, come quando
superare il tuo rapido passo celeste
sembrava appena un sogno; non mi rivolgereia le con questa preghiera nella mia dolente
necessità. Ti prego, levami come un’onda, come
una foglia o una nuvola. Cadosopra le spine della vita e sanguino! Un grave
peso di ore ha incatenato, incurvato
uno a te troppo simile: indomito, veloce ed orgoglioso.V.
Fa di me la tua cetra, com’è della foresta;
che cosa importa se le mie foglie cadono
come le sue! Il tumultodelle tue forti armonie leverà a entrambi un canto
profondo ed autunnale, e dolcemente triste.
Che tu sia dunque il mio spirito, o Spirito tiero!Spirito impetuoso, che tu sia me stesso!
Guida i miei morti pensieri per tutto l’universo
come foglie appassite per darmi una nascita nuova!E con l’incanto di questi miei versi disperdi,
come da un focolare non ancora spento,
le faville e le ceneri, le mie parole tra gli uomini!E alla terra che dorme, attraverso il mio labbro,
tu sia la tromba d’una protezia! Oh, Vento,
se viene l’Inverno, potrà la Primavera esser lontana?
Versi principali
“…oh tu che guidi / i semi alati ai loro letti oscuri dell’inverno…”
In questi versi compare la Morte, ma con sé porta il seme di una nuova vita. Per Shelley, che aveva già conosciuto il dolore delle perdite familiari, questo era un pensiero fondamentale e importantissimo, al quale non poteva rinunciale.
Il vento, che simboleggia la distruzione, in questo caso simboleggia anche la rinascita attraverso un processo di semina naturale; e quindi protegge.
La seconda stanza della poesia ci racconta un cielo sconvolto dalle nubi.
“Tu nella cui corrente, nel tumulto / del cielo a precipizio, le nuvole disperse / sono spinte qua e là come foglie appassite…”
Le nuvole diventano “angeli della pioggia e del fulmine” (V. 23), simili alla chioma scomposta di una Menade. L’immagine è dionisiaca, frenetica, e ci restituisce il senso di un’energia primordiale e irresistibile. Shelley, ribelle espulso da Oxford e perseguitato per il suo ateismo, vedeva in se stesso lo stesso furore del vento: un’entità inarrestabile che scuote l’ordine costituito. È anche il suo modo di rispecchiare l’instabilità della propria vita, sempre segnata dal conflitto con le convenzioni.
La terza stanza della poesia ci parla di quando il poeta viveva in Italia.
“Tu che svegliasti dai loro sogni estivi / le acque azzurre del Mediterraneo…”
È lo sguardo rivolto al mare, al Mediterraneo, a ricordarlo: Shelley viveva allora in Italia e quello era l’ambiente tipo in cui perdeva le giornate; culla del suo esilio, ma anche scenario della sua morte prematura. La descrizione del golfo di Baia (V. 38), con i palazzi sommersi che tremolano tra le onde, ha una valenza visionaria e quasi premonitrice. È il mare che custodisce la bellezza, ma che sa anche diventare tomba…
“Fossi una foglia appassita che tu potessi portare… / Cado sopra le spine della vita e sanguino! / Un grave peso di ore ha incatenato, incurvato / uno a te troppo simile: indomito, veloce ed orgoglioso.”
La quarta stanza, la più drammatica e devastante: qui Shelley si abbandona alla confessione. Si paragona al vento, quello che distrugge, ma quello che spera, e sente di non avere più libertà. È piegato dal dolore e dalla fatica del vivere. La frase “spine della vita” (V. 50) è emblematica: i lutti, i conflitti, le disillusioni politiche lo avevano incatenato. Ma nello stesso tempo ribadisce la propria natura indomita.
È un momento di verità biografica e poetica insieme: un uomo ferito che però non smette di aspirare alla libertà assoluta.
“Fa di me la tua cetra, com’è della foresta; / che cosa importa se le mie foglie cadono come le sue! / Il tumulto delle tue forti armonie leverà a entrambi un canto…”
In questi versi Shelley chiede che i suoi pensieri morti diventino canto e si fa strumento del vento, voce di una forza superiore. Il suo desiderio non è personale: vuole che le sue parole diventino faville di un focolare, capaci di infiammare gli uomini e annunciare una rinascita collettiva. Per lui la poesia è missione politica e spirituale: trasformare il dolore individuale in energia universale.
Il verso finale è uno dei più celebri della letteratura romantica:
“Oh Vento, se viene l’Inverno, potrà la Primavera esser lontana?”
A discapito di quanto possa sembrare, non è solo un’immagine stagionale, ma un testamento spirituale. Con queste parole, Shelley ci dice che ogni dolore, ogni rovina, contiene già in sé la promessa di una rinascita — il semino iniziale.
È una dichiarazione di fede nella ciclicità della Natura, la sua, non una speranza. Per un uomo che avrebbe trovato la morte nel mare poco dopo, è anche un lascito personale: la certezza che la sua voce, affidata al “vento occidentale”, avrebbe sedimentato e sarebbe sbocciata come un fiore oltre il suo tempo.