Il tempo che il mio viaggio richiede (1910) di Tagore svela che il vero viaggio è dentro di sé
Scopri come ritrovare l’essenza dell’essere grazie ai versi “Il tempo che il mio viaggio richiede”, meravigliosa poesia Rabindranath Tagore.
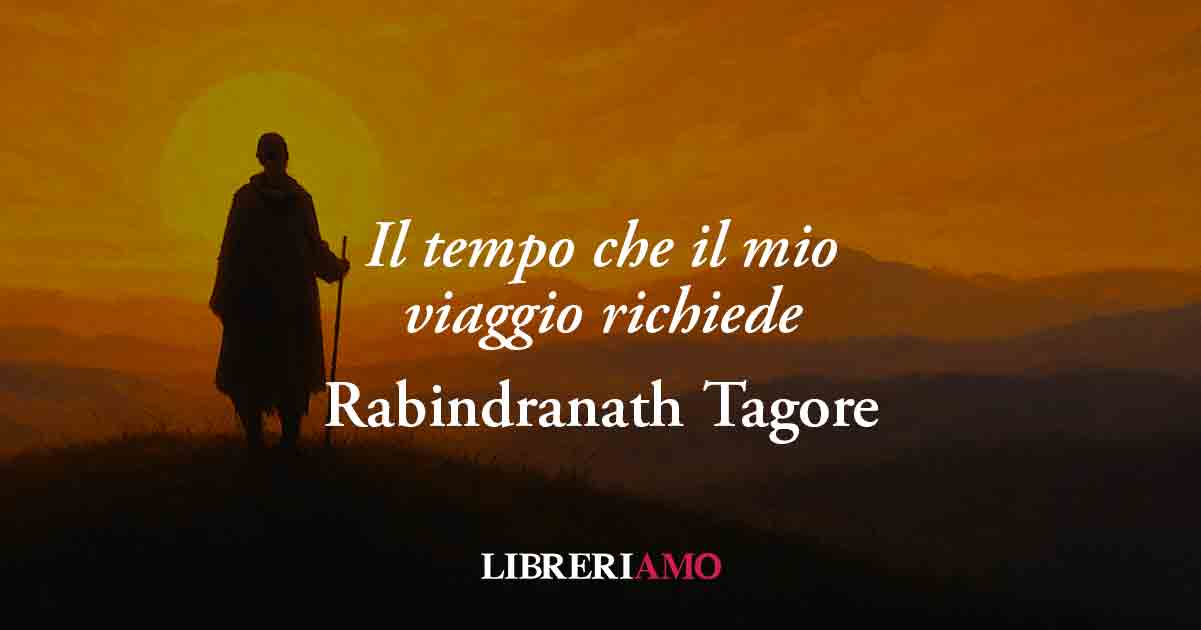
Il tempo che il mio viaggio richiede (Gitanjali 12) di Rabindranath Tagore è il percorso che ogni umano dovrebbe condurre nella vita per trovare la propria identità, il proprio essere interiore. Il lungo e tortuoso viaggio attraverso il mondo esterno è la via necessaria per trovare la verità più semplice e profonda all’interno di sé stessi.
Ognuno di noi ha la propria meta da raggiungere, seppur tra mille difficoltà, in un viaggio alla ricerca della propria identità. Tagore svela che la vita non è una distrazione dal cammino spirituale, ma è il cammino spirituale stesso. Ogni esperienza vissuta nel quotidiano è necessaria per condurre all’unico luogo che conta davvero: il santuario più intimo del nostro essere.
Il tempo che il mio viaggio richiede è il Canto 12 della raccolta di poesie Gitanjali (Song Offerings – in italiano Ghitangioli) di Rabindranath Tagore pubblicata per la prima volta nel 1910.
Leggiamo questa meravigliosa poesia di Rabindranath Tagore per scoprirne la profondità del si significato.
Il tempo che il mio viaggio richiede (Gitanjali 12) di Rabindranath Tagore
Il tempo che il mio viaggio richiede è lungo, e lunga è la via.
Uscii sul carro del primo raggio di luce, e seguii il mio cammino
tra i deserti dei mondi, lasciando la mia traccia su molte stelle e pianeti.È il cammino più lontano quello che più ti avvicina,
ed è l’apprendimento più complesso quello che conduce
alla semplicità perfetta di un canto.Il viandante deve bussare a ogni porta straniera
per giungere alla propria casa,
e deve attraversare tutti i mondi esteriori
per raggiungere il santuario più intimo, alla fine.I miei occhi errarono lontano e ovunque,
prima che li chiudessi dicendo: “Ecco, Tu sei qui!”La domanda e il grido — “Dove?” —
si sciolgono in lacrime di mille ruscelli
e inondano il mondo con il diluvio della certezza:
“Io sono!”
The time that my journey takes (Gitanjali 12), Rabindranath Tagore
The time that my journey takes is long and the way of it long.
I came out on the chariot of the first gleam of light, and pursued my voyage through
the wildernesses of worlds leaving my track on many a star and planet.It is the most distant course that comes nearest to thyself, and that training is the
most intricate which leads to the utter simplicity of a tune.The traveller has to knock at every alien door to come to his own, and one has to
wander through all the outer worlds to reach the innermost shrine at the end.My eyes strayed far and wide before I shut them and said “Here art thou!”
The question and the cry “Oh, where?” melt into tears of a thousand streams and
deluge the world with the flood of the assurance “I am!”
Il viaggio lungo quanto la vita
Il tempo che il mio viaggio richiede è una poesia di Tagore che avvicina l’umano al divino e in cui il cammino della vita con le sue molteplici difficoltà è l’esperienza fondamentale per scoprire sé stessi. Un Canto che assomiglia ad una preghiera laica che conduce alla scoperta di sé.
Il poeta inizia affermando che il suo viaggio è lungo e la via è lunga.
Non parla di un viaggio reale ma di quello spirituale che ogni essere umano compie per cercare la propria verità. Tagore immagina di essere salito sul carro del primo raggio di luce e di aver attraversato i deserti dei mondi lasciando la sua traccia su stelle e pianeti.
È un’immagine grandiosa. L’uomo che viaggia nel tempo e nello spazio esplora tutto ciò che esiste alla ricerca di qualcosa che sembra lontano ma che in realtà è sempre stato vicino.
Il poeta poi continua con immagini cosmiche e grandiose.
Uscii sul carro del primo raggio di luce, e seguii il mio cammino
tra i deserti dei mondi, lasciando la mia traccia su molte stelle e pianeti.
L’“uscire sul carro del primo raggio di luce” rappresenta l’alba della coscienza o della nascita spirituale: l’anima comincia a muoversi verso la conoscenza.
Le “wildernesses of worlds”, i “deserti dei mondi”, le “stelle e pianeti” bagnano l’idea che il cercatore attraversa più realtà: fisiche, psichiche, spirituali. La sua traccia su stelle e pianeti suggerisce molte vite, molte metamorfosi, un’impronta persistente nel cosmo: l’anima si muove oltre il visibile.
Così Tagore trasforma l’esperienza interiore in fantasia cosmica: ciò che è dentro è vasto come l’universo.
È il cammino più lontano quello che più ti avvicina,
ed è l’apprendimento più complesso quello che conduce
alla semplicità perfetta di un canto.
Per arrivare a sé stessi o a Dio (l’essenza ultima), bisogna intraprendere un percorso che sembra distante e complesso. Per conoscere veramente il proprio centro, bisogna esplorare l’esterno, sperimentare la vita, entrare in relazione con l’altrove.
L’analogia del musicista funziona così. Un brano semplice e puro è il risultato di anni di esercizio, errori, raffinamenti. Allo stesso modo, la verità interiore è semplice, ma arriva dopo un processo arduo.
Tagore vuole dire che la semplicità vera non è banale: è l’essenza raggiunta dopo aver lasciato il superfluo, aver vissuto, aver sperimentato.
Poi si rafforza l’idea del pellegrinaggio che conduce all’interno dell’essere.
Il “viandante” è l’anima, e “ogni porta straniera” rappresenta tutto ciò che appare estraneo, diverso, l’esperienza che non ci sembra nostra: culture, emozioni, situazioni sconosciute.
Solo passando per l’“altro” e l’“altrove” l’anima riconosce ciò che è proprio: la propria casa. E “attraversare tutti i mondi esteriori” significa non limitarsi al noto, all’abitudine, al comodo: è necessario andare oltre, per arrivare al “santuario più intimo”, quel luogo interiore di silenzio, verità, presenza. Così Tagore suggerisce che ritorno a sé non significa rimanere fermi, ma muoversi molto.
I versi successivi offrono un’immagine potente.
I miei occhi errarono lontano e ovunque,
prima che li chiudessi dicendo: “Ecco, Tu sei qui!”
Gli occhi del pellegrino hanno vagato per il mondo, hanno cercato in ogni direzione. Alla fine però chiude gli occhi, il gesto simbolico di introspezione, e pronuncia “Ecco, Tu sei qui!”
Questa frase dice che ciò che cercava all’esterno lo ha trovato all’interno. Il “viandante” scopre che la presenza divina o l’essenza del sé non è un oggetto distante, ma è già accanto a lui, dentro.
La chiusura degli occhi non è rinuncia, ma svolta: passaggio dalla visione esteriore alla visione interiore.
E alla fine si vive la scoperta del luogo misterioso tanto ricercato.
La domanda e il grido — “Dove?” —
si sciolgono in lacrime di mille ruscelli
e inondano il mondo con il diluvio della certezza:
“Io sono!”
Alla fine del Canto 12, la tensione della ricerca, la domanda “Dove sei?”, si trasforma. Le lacrime sono segno di emozione profonda, di liberazione. Il “diluvio della certezza” significa che la risposta non è una piccola luce ma una piena testimonianza: “Io sono!”
Questo “Io sono” non è solo affermazione individuale, ma fusione con l’essere universale. L’io che comprende che è parte del tutto. L’ansia del cercatore si trasmuta in pace e certezza. Tagore consegna così un messaggio di unità: la ricerca finisce nell’esperienza dell’essere.
In Il tempo che il mio viaggio richiede, Rabindranath Tagore utilizza un linguaggio poetico delizioso e unico, per esprimere un pensiero spirituale profondo: la vita intera è un cammino per trovare ciò che è già dentro di noi.
La poesia spinge a considerare che non è la meta distante a cambiare la vita, ma la trasformazione del viandante. La scuola della vita non è separata dalla spiritualità: è la strada verso il nostro sé autentico.