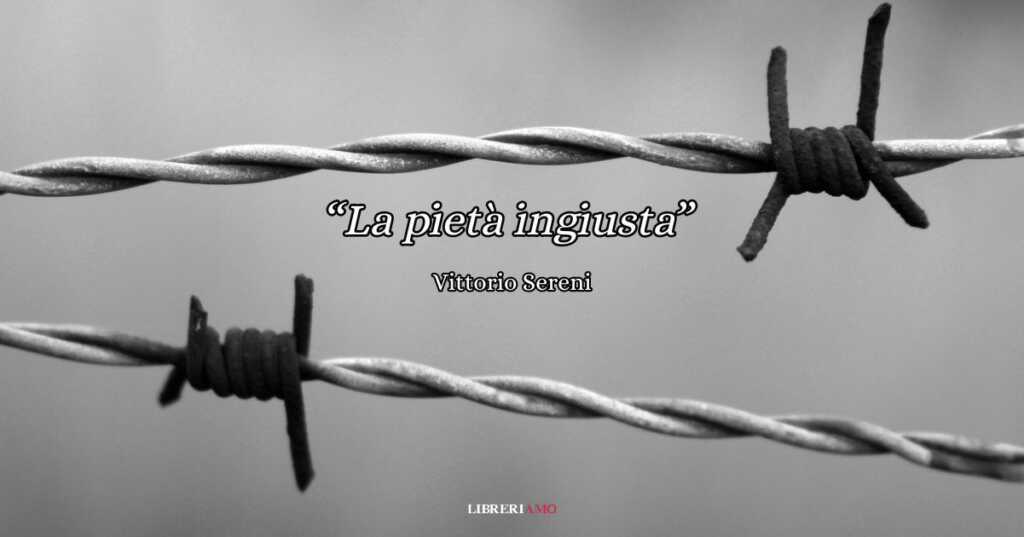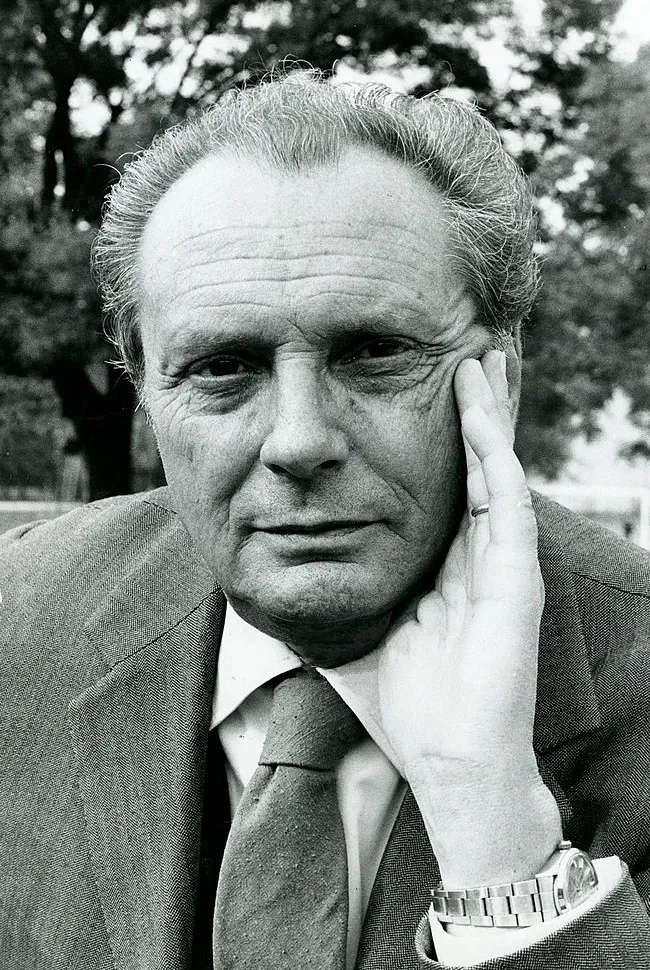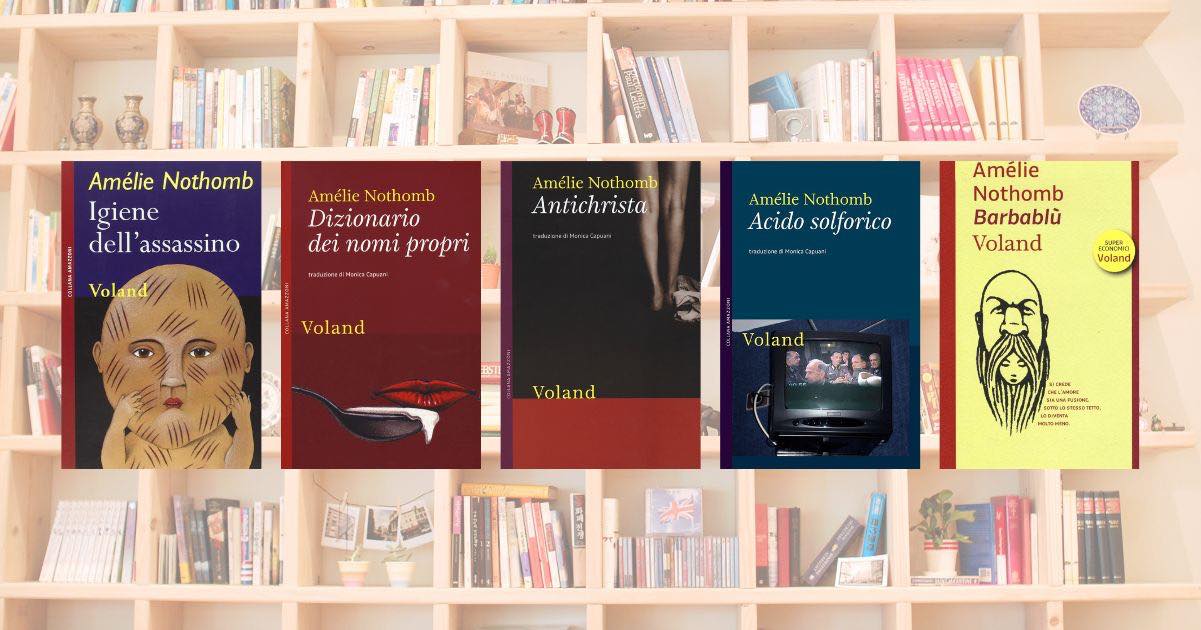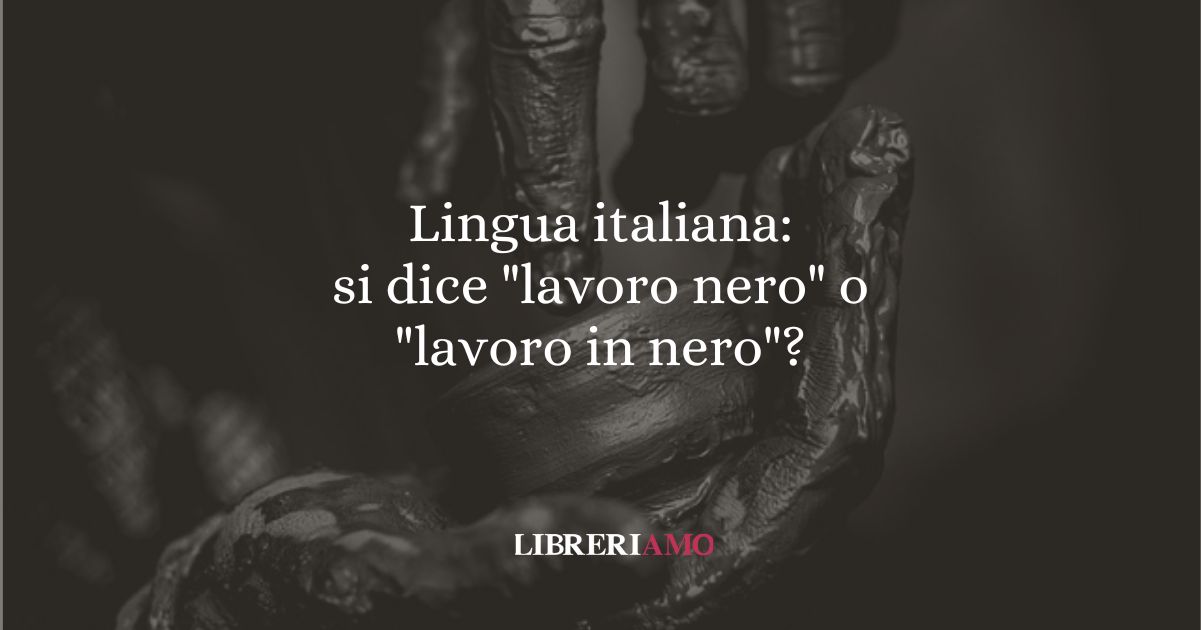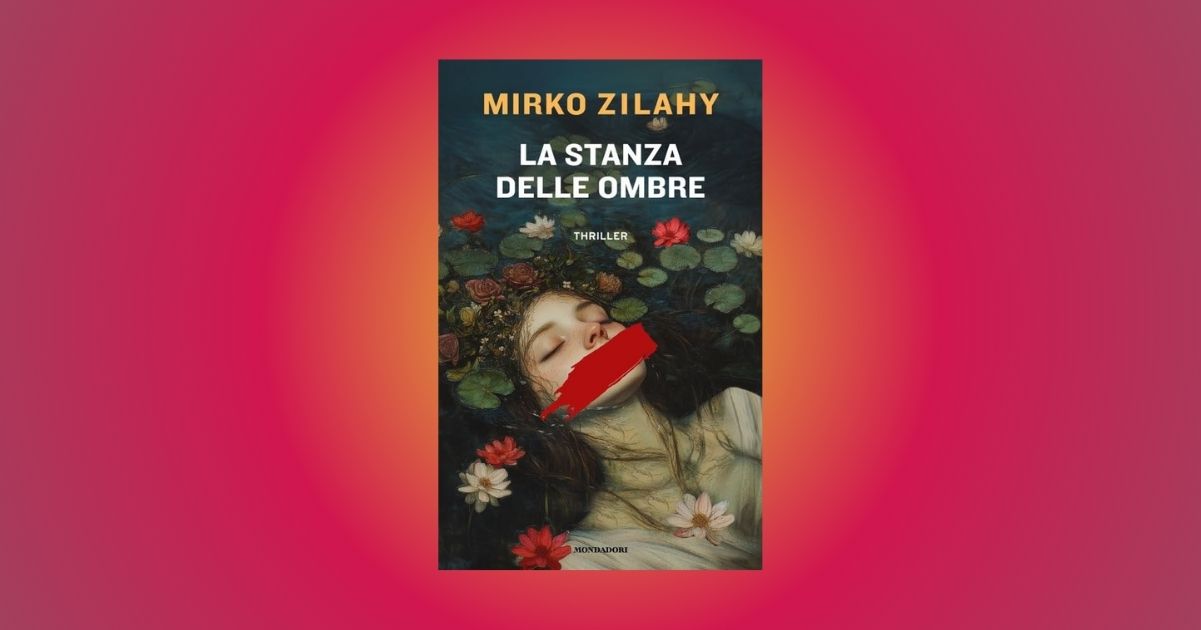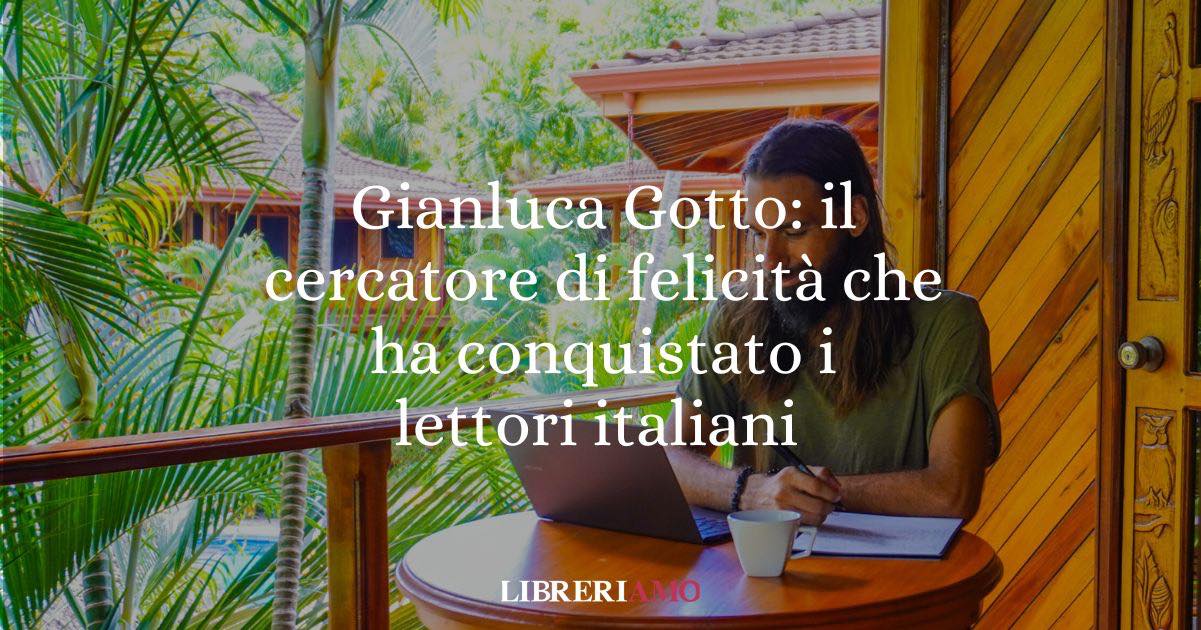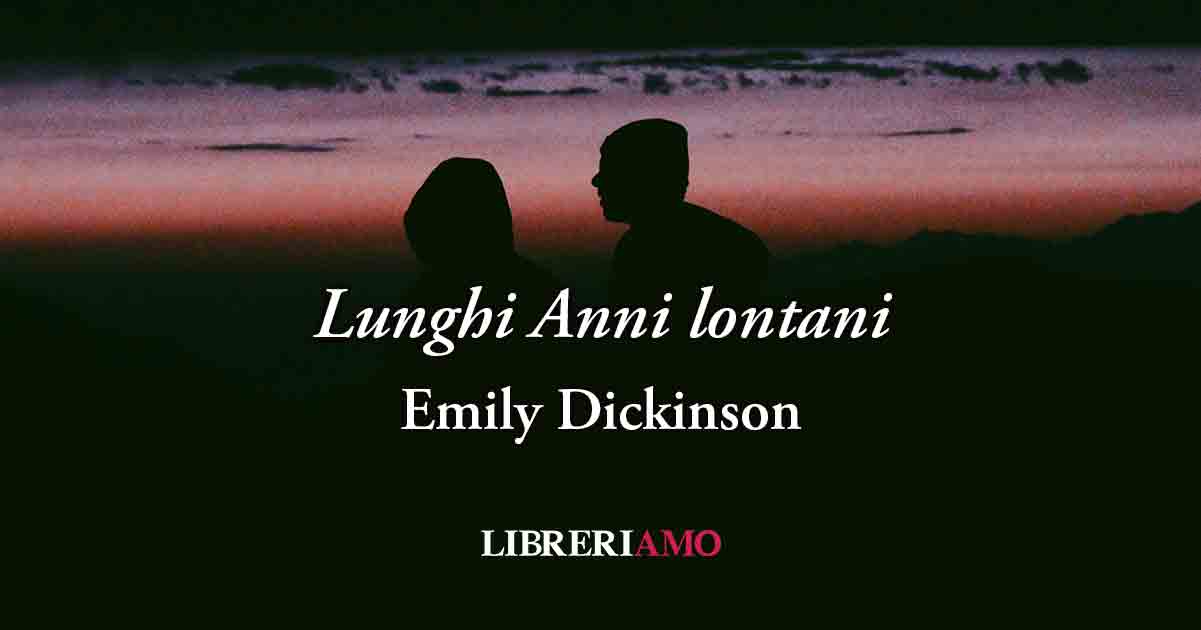Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria, per non dimenticare le vittime dell’Olocausto ma, soprattutto, per ricordarci che orrori come quello dei lager, delle leggi razziali e dei genocidi non devono mai più trovare spazio nel mondo in cui viviamo. Per l’occasione, scopriamo “La pietà ingiusta” di Vittorio Sereni, una poesia pubblicata nella raccolta Diario di Algeria.
Cosa significa “non dimenticare”
Quella della Giornata della Memoria dovrebbe essere un’occasione per ricordare e riflettere. Soprattutto per riflettere. Perché, nonostante movimenti orridi, turpi ed estesi come quello del nazismo nei confronti della comunità ebraica non siano più avvenuti, non sono pochi i casi di genocidio nel mondo.
Pensiamo agli Yazidi, ai Rohingya… alle pulizie etniche intenzionali e sistematiche portate avanti nei territori dell’Africa e dell’Asia… pensiamo a Gaza, dove muoiono centinaia di palestinesi e proprio oggi la Corte dell’Aja ha intimato a Israele di fare di tutto per “evitare il genocidio”.
Celebrare la Giornata della Memoria significa leggere passi del “Diario di Anna Frank”, poesie come quella di Vittorio Sereni, ricordare le vittime dell’Olocausto. Ma significa, soprattutto, non lasciare che gli stessi errori, od orrori, accadano ancora. Oggi. Sotto i nostri occhi ipocriti.
“La pietà ingiusta” per una Giornata della Memoria consapevole
Mi prendono da parte, mi catechizzano:
il faut
faire attention, vous savez.
Et surtout si l’affaire
Doit marcher jusq’au bout,
ne causez pas de ces choses bien passées.
Il paraît qu’il en fut un, un SS
qu’il a été même dans l’armée
quoique pas allemand…Ecco in cosa erano
forza e calma sospette
l’abnegazione nel lavoro, la
cura del particolare, la serietà
a ogni costo, fino in fondo…Intorno c’è aria di niente, mani
sulla tavola, armi (chi le avesse)
al guardaroba: solo adesso
si comincia a capire – e l’affare un pretesto
il pranzo un trucco, una messinscena
benché non esistano dubbi sulle portate
benché non ci siano orripilanti cataste sulla tavola né sotto
ma in cucina, chi può dirlo?
ah le dotte manipolazioni di cui furono capaci,
matasse, matassine innocue, oro a scaglie
da coprirne un deserto di sale, di nubi d’anime
esalanti-esulanti da camini
con la piena dolcezza degli stormi d’autunno
altre anche meno visibili spazzate da una raffica in un’ora di notteè una questione d’occhi fermi sul cammello che passa
e ripassa per la cruna in piena libertà
e con tocchi di porpora una città
d’inverno, una città di cenere si propaga
dentro una lente di mitezza.
Solo adesso si comincia a capire.Incredibile – dirò più tardi – le visioni
immotivate che si hanno a volte
(e pazienza per queste
ma esserne coinvolti al di là del giudizio
fino al tenero, fino all’indebita pietà …):
le giubbe sbottonate della disfatta, un elmo
ruzzolante tra i crateri, sugli argini maciullati
facce su facce lungo un canale a ridosso di un muro
un reparto in sfacelo che si sbraca, se ne fotte
della resa con dignità, ma su tutte
quella faccia d’infortunio, di gioventù in malora
con la sua vampa di dispetto di bocciato
di espulso dal futuro
nell’ora già densa della campagna
verso l’estate che verrà …Tra poco apparecchieranno, porteranno
le cartelle per la firma. Si firmerà.
Si firmerà la pace barattandola con la nostra pietà –
e lui rimesso in sesto, risarcito di vent’anni d’amaro
bene potus et pransus arbitro dell’affare.Non si vede più niente. Se non – per un incauto
pensiero, per quel momento di pietà – quella mano
quel mozzicone di mano sulla parete.
Ci conta ci pesa ci divide. Firma.
E tutti quanti come niente – come la notte
ci dimentica.
Il senso della poesia
“La pietà ingiusta” ci spiazza. Sia perché inizia con una strofa che non ci aspetteremmo, sia perché non è il tipo di componimento che ci aspetteremmo sul tema della Shoah e della Giornata della Memoria.
Il testo si apre in francese, lingua usata per scambi e diplomazia nel secolo scorso, in quella che ha tutta l’aria di essere una conversazione fra l’autore e un’autorità che cerca di spiegargli la linea da seguire con la persona che sta per incontrare a breve.
Si tratta di un ex SS, con cui Sereni deve condividere del tempo seduto al tavolo di un ristorante.
Per tutto il tempo della poesia, Vittorio Sereni si divide fra la realtà e le immagini allucinate che gli appannano gli occhi mentre guarda la persona che ha di fronte. Un criminale di guerra. Un genocida.
Un verme assassino di cui, comunque, non riesce a non provare pietà, perché ingranaggio di un sistema malato e degenere.
Oggi, per celebrare in modo degno la Giornata della Memoria, leggiamo questi versi, e ricordiamoci non solo del passato, ma di ciò che nel presente, indisturbato, continua ad accadere sotto ai nostri occhi.
Vittorio Sereni
L’autore di “La pietà ingiusta” è ricordato per essere stato un grandissimo poeta. Vittorio Sereni è nato il 27 luglio 1913 a Luino, piccola cittadina sulla riva lombarda del Lago Maggiore, paese natale di un altro grande esponente della poesia italiana, Piero Chiara.
I due strinsero un forte legame di amicizia. Un’influenza, quella letteraria, che ha coinvolto appieno Sereni, il quale è stato uno dei protagonisti della cultura del Novecento, prima come guida dei “Meridiani”, e poi come direttore letterario della casa editrice Mondadori.
Prima di lavorare nel campo dell’editoria, Sereni aveva lavorato presso la Pirelli. Fu per questo motivo che nel corso di tutta la sua vita ebbe sempre un’attenzione particolare al mondo della fabbrica. Era di carattere introverso e riservato. Preciso, ordinato ed elegante, aveva solo un grande vizio: il fumo.
Nonostante abbia vissuto soltanto l’infanzia a Luino, la terra natia è rimasta nel cuore del poeta. Qui faceva spesso ritorno, a trovare gli amici e a trarre ispirazione per i suoi scritti. Erano in particolar modo i luoghi di “arrivo e partenza” che piacevano ed affascinavano Sereni.
Fu proprio l’imbarcadero di Luino ad ispirargli i versi di una delle sue più belle poesie, “Terrazza“. Vittorio Sereni è scomparso a Milano il 10 febbraio 1983.
La poesia di Vittorio Sereni
La poesia di Vittorio Sereni è essenziale nel panorama della letteratura italiana del Novecento, e passa attraverso i cambiamenti epocali che hanno interessato il nostro Paese, dalle guerre al boom economico, approfondendo le tematiche esistenziali che ritroviamo, in piccola parte, anche in “Settembre”.
Nei versi di Vittorio Sereni, la fragilità degli esseri umani, il senso di precarietà, la paura dell’ignoto, il dolore della guerra non chiudono mai alla possibilità di un ritorno alla vita. La speranza c’è, e resiste agli sconquassi della terra.