“Gentilezza” (1963) di Sylvia Plath, poesia sul vero valore della dolcezza e dell’amore
Scopri cosa significa l’importanza della vera gentilezza grazie alla poesia”Kindness” di Sylvia Plath, scritta poco tempo prima di morire.
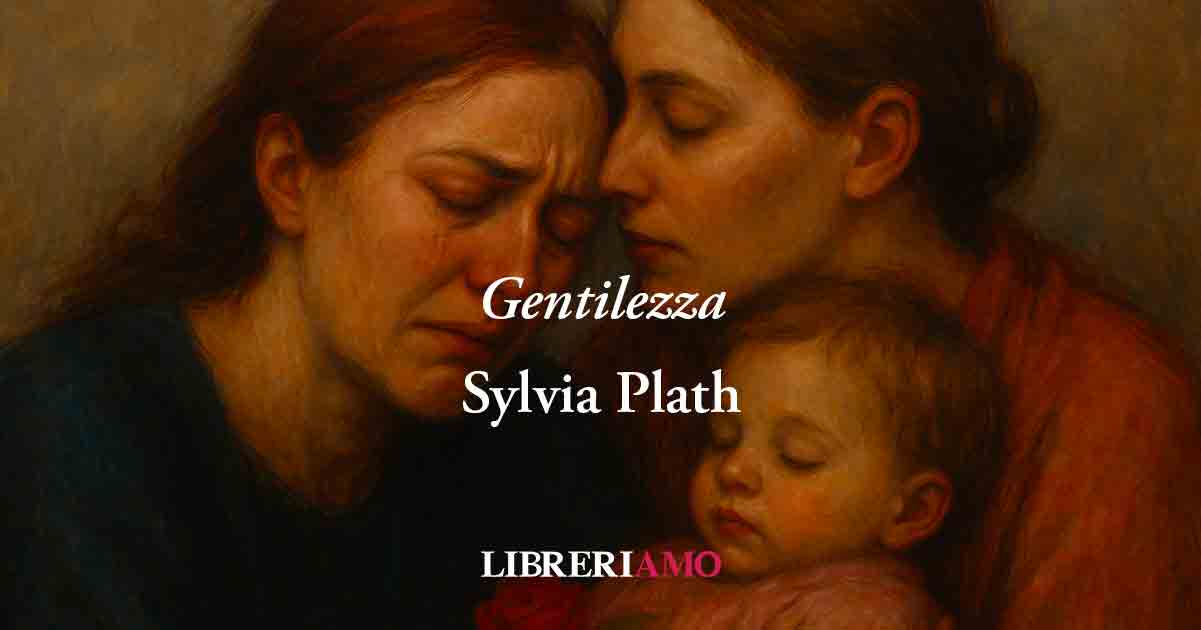
Gentilezza di Sylvia Plath è una poesia che gioca con la falsa dolcezza, con quell’essere gentili che, invece di consolare, finisce per opprimere. Perché prendersi cura dell’altro non significa riempire i silenzi con frasi buone o sorrisi di circostanza. La gentilezza autentica non addolcisce il dolore, ma lo riconosce, lo abbraccia, lo attraversa.
Essere gentili davvero non è un gesto estetico, ma un atto d’amore, un atto che richiede presenza, empatia, comprensione profonda. Sylvia Plath, con la sensibilità feroce che la contraddistingue, riesce in Kindness a mettere in scena il lato oscuro della dolcezza, quella che addormenta invece di risvegliare, che copre invece di curare.
Gentilezza è stata scritta l’1febbraio del 1963, pochi giorni prima della sua morte, e fa parte della raccolta postuma Ariel, pubblicata postuma nel 1965. Il testo italiano della poesia è stato curato da Anna Ravano e fa parte del volume Sylvia Plath. Tutte le poesie, pubblicato da Mondadori nel 2019.
Leggiamo questa stupenda poesia di Sylvia Plath per viverne la sensibilità e comprenderne il significato.
Gentilezza” di Sylvia Plath
Gentilezza s’insinua nella mia casa,
signora Gentilezza, è così premurosa!
Le pietre azzurre e rosse dei suoi anelli mandano vapori
alle finestre, gli specchi
si saturano di sorrisi.Cosa più è vero del pianto di un bambino?
Il grido del coniglio sarà forse più spaventato ma è senza anima.
Lo zucchero cura ogni cosa, così dice Gentilezza.
Zucchero è un fluido necessario
i suoi cristalli una sorta di cataplasma.O Gentilezza, Gentilezza
Che lievemente raccogli i pezzi!
Le mie sete giapponesi, farfalle disperate
possono essere infilzate quando vuoi, anestetizzate.Ed ecco arrivi con una tazza di thè
tra spire di vapore.
Lo zampillo di sangue è poesia
non c’è modo di arrestarlo.
E mi porgi due figli, due rose.
Kindness, Sylvia Plath (testo originale)
Kindness glides about my house.
Dame Kindness, she is so nice!
The blue and red jewels of her rings smoke
In the windows, the mirrors
Are filling with smiles.What is so real as the cry of a child?
A rabbit’s cry may be wilder
But it has no soul.
Sugar can cure everything, so Kindness says.
Sugar is a necessary fluid,Its crystals a little poultice.
O kindness, kindness
Sweetly picking up pieces!
My Japanese silks, desperate butterflies,
May be pinned any minute, anesthetized.And here you come, with a cup of tea
Wreathed in steam.
The blood jet is poetry,
There is no stopping it.
You hand me two children, two roses.
Il rumore assordante della falsa gentilezza
Gentilezza è una poesia di Sylvia Plath carica di significato. Non solo per il testo, che a breve andremo ad esplorare insieme, ma anche per le circostanze in cui essa è stata composta. Sylvia Plath ha scritto questi versi pochi giorni prima di togliersi la vita. Il componimento, quindi, ha un valore inestimabile. Sono tra le ultime parole che l’autrice ha voluto consegnare al mondo.
Leggendo i versi si avverte che C’è un rumore che non si sente, ma che riempie ogni stanza: è quello della gentilezza di facciata. Quella che parla, consola, offre zucchero e tazze di tè, ma non ascolta davvero. È la voce sommessa di chi vuole il silenzio, non la verità.
Sylvia Plath, in Kindness, svela la potenza distruttiva di questa dolcezza apparente: una cortesia che anestetizza, che trasforma la compassione in un rituale di controllo, la cura in un gesto automatico.
La sua “Dame Kindness” non è una figura materna, ma un fantasma gentile che aleggia per la casa come un’ombra sorridente. Tutto, intorno a lei, è luce e riflesso, gli specchi si riempiono di sorrisi, le finestre si colorano dei vapori dei suoi anelli. È un mondo perfetto, ma falso, perché non accoglie la realtà del dolore.
Zucchero e sangue: i due poli della vita
Plath contrappone due elementi simbolici: lo zucchero e il sangue.
“Lo zucchero è la dolcezza che cura tutto”, ma è una cura illusoria, un rimedio da infanzia, una consolazione superficiale che serve solo a nascondere la ferita. Il sangue, invece, è la vita nella sua forma più pura, viscerale e inarrestabile. È la verità che scorre, anche quando tutto intorno tenta di fermarla.
Lo zampillo di sangue è poesia
non c’è modo di arrestarlo.
Il getto di sangue è poesia, non c’è modo di arrestarlo.
Questo verso è il cuore pulsante della poesia e, in fondo, dell’intera opera di Sylvia Plath. La poesia, per lei, non è un rifugio, ma una ferita che non smette di sanguinare. È il segno della vita stessa, che continua nonostante tutto, o forse proprio a causa di tutto. Scrivere è vivere con intensità assoluta, anche quando il dolore diventa insopportabile.
La gentilezza che addormenta le farfalle
Nella strofa centrale, Plath si paragona a “sete giapponesi, farfalle disperate”, immagini delicate e splendide, ma anche fragili, destinate a essere “infilzate e anestetizzate”.
La gentilezza, in questo passaggio, diventa il gesto di chi immobilizza la vita nel tentativo di conservarla. È la società che pretende sorrisi anche nella sofferenza, è la famiglia che offre una tazza di tè quando il cuore brucia. È la mano che fissa la farfalla su una tavola di vetro, togliendole il battito d’ali per ammirarne la perfezione.
Sylvia Plath denuncia questa ipocrisia del conforto: una cultura che addolcisce ogni dolore fino a renderlo invisibile, una femminilità imposta che esige grazia anche nella disperazione.
Due figli, due rose: tra amore e destino
Nel finale, Gentilezza si chiude con un’immagine doppia, tenera e tragica:
E mi porgi due figli, due rose.
I due figli rappresentano la vita concreta, il legame che ancora la trattiene al mondo. Le due rose, simboli d’amore e di bellezza, evocano la promessa e la ferita insieme.
La gentilezza, o la vita stessa, le porge ciò che è prezioso ma anche doloroso: l’amore, la maternità, la responsabilità. È un gesto che racchiude il conflitto finale della poetessa: essere madre e artista, corpo e parola, vita e sangue.
Le rose, come la poesia, sono bellissime ma possono anche “pungere”, ferire. E in questa immagine, Sylvia Plath affida la sua ultima verità: la gentilezza può essere un dono, ma se non nasce dall’autenticità, rischia di soffocare ciò che è vivo.
La gentilezza per essere tale deve essere vera
Kindness non è una poesia contro la gentilezza ma contro la sua imitazione vuota.
Sylvia Plath conduce dentro un mondo dove la gentilezza ha perso consistenza e si è ridotta a gesto di superficie, a cortesia che maschera il silenzio. È la dolcezza che sfiora ma non tocca, che si compiace di sé senza entrare mai nel cuore delle cose.
La vera gentilezza non è un ornamento né un dovere. È un modo di esistere accanto all’altro con presenza, ascolto e coraggio. Non serve a cancellare il dolore ma a comprenderlo, a riconoscerlo come parte della vita.
Plath ci ricorda che solo chi accetta di guardare davvero, di sentire senza difese, può essere autenticamente gentile. La gentilezza di cui parla non è zucchero che copre l’amaro ma sostanza che lo attraversa. È empatia che nasce dalla verità, non dalla forma.
Essere gentili significa restare, anche quando non si hanno risposte. Significa non fuggire davanti al pianto, non sostituire le parole con sorrisi di convenienza, non temere la vulnerabilità dell’altro.
È un gesto che costa perché chiede autenticità, chiede di rinunciare al ruolo per tornare umani.
In Gentilezza la poetessa sembra dire che solo questa gentilezza, quella che nasce dalla comprensione e dal contatto profondo, può salvare davvero. Non la gentilezza che consola, ma quella che comprende. Non quella che addolcisce, ma quella che accompagna.
È la gentilezza che si fa verità, che non teme il sangue, che non cerca di guarire ciò che non va guarito ma di stare vicino finché la ferita trova da sé la propria forma di pace.
Questa è la gentilezza che salva, perché è viva, incarnata, reale. Quella che non recita, ma sente.
Sylvia Plath, una vita dolorosa
Sylvia Plath nasce a Boston il 27 ottobre del 1932. Dimostra passione e talento precoci per la scrittura, pubblicando la sua prima poesia all’età di otto anni. Nello stesso periodo, il padre subisce l’amputazione di una gamba e muore, in seguito alle complicazioni di un diabete mellito diagnosticato troppo tardi, il 5 ottobre 1940.
La perdita del padre lascia un segno indelebile nella vita della poetessa. Sylvia Plath soffre durante tutta la sua vita adulta di una grave forma di depressione che si alterna a periodi di intensa vitalità. Le sue poesie sono intrise, infatti, di elementi cupi e destabilizzanti frammisti a momenti di sincera meraviglia e forte dinamismo.
Il 26 Agosto del 1953 Sylvia Plath tenta per la prima volta il suicidio. A Cambridge, conosce il poeta inglese Ted Hughes, che sposa nel 1956. Dall’unione dei due autori nascono due figli, ma la separazione è dietro l’angolo: Sylvia e Ted divorziano infatti pochi anni dopo le nozze, nel 1962.
Dalle testimonianze rinvenute, sembra che Hughes avesse una relazione extraconiugale con la moglie di un suo amico e che, inoltre, avesse assunto diverse volte un comportamento molto violento nei confronti di Plath.
Sylvia Plath muore poco dopo il divorzio con il marito. Si suicida l’11 febbraio del 1963: dopo aver preparato la colazione per i figli, si chiude in cucina e mette la testa nel forno a gas.
Alcuni studiosi sostengono che la poetessa non avesse veramente intenzione di togliersi la vita, ma di attirare l’attenzione per chiedere un aiuto disperato.