“Felicità” (1971) di Pablo Neruda, la poesia-bilancio che racconta un modo diverso di essere felici
“Felicità” viene composta da Pablo Neruda in uno degli ultimi inverni della sua vita: è una poesia asciutta e stupefacente, che racconta un concetto diverso dell’essere felici.
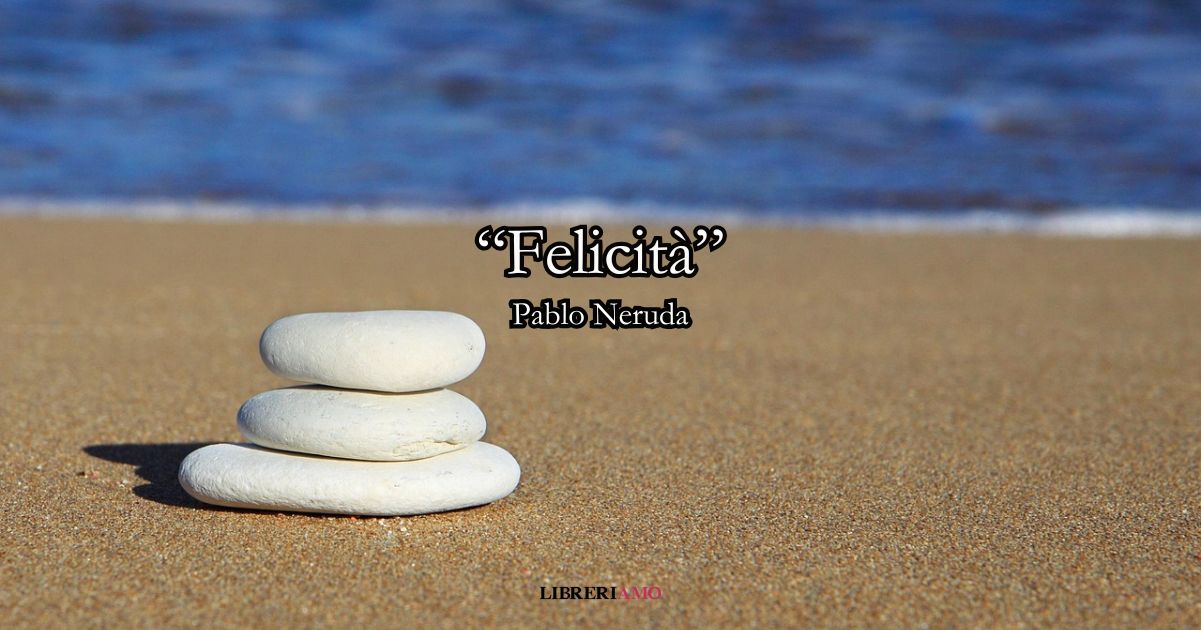
Qual è il segreto per essere felici? A conclusione della sua esistenza, Pablo Neruda compone una poesia che ce lo svela. Si intitola “Felicità”, ed è un componimento prezioso da custodire nel cuore.
“Felicità” di Pablo Neruda
Sicuro, sì, rispondo
Senza che nessuno chieda e mi chieda:
il bene è ormai rispondere
senz’obbligo e domande
all’ombra nostra lenta e successiva.Sì, in questo tempo mio, in questa storia
di porta personale, ho accumulato
non il delirio ma la nostalgia
e l’ho sepolta nella casa di cemento:
lutti o dolori di ieri non m’accompagnano
perché non muoiono solo le ossa,
la pelle, gli occhi, la parola, il fumo
ma anche il pianto divorato
dalle sessanta bocche della vita.Così di quello che da un luogo all’altro
ho conservato – tristezza o improvvisa amarezza –
come pesca tremante l’ho ridato
al mare, al mare e nudo mi sono disteso.È questo il segno della mia ventura:
possiedo il sonno duro della pietra.
Il significato di questa poesia
Dove leggere “Felicità”
Nel freddo e nei silenzi di una campagna normanna, in uno degli ultimi inverni della sua vita, Pablo Neruda compone il diario poetico che sarà poi raccolto in Geografia infruttuosa. È il 1971: da poco ha ricevuto il Premio Nobel per la Letteratura, ma insieme all’onore giunge anche la scoperta della malattia che lo accompagnerà fino alla fine.
In questa stagione estrema, dove la mente si volge indietro e la memoria si fa terreno di scavo, il poeta cileno ripercorre la sua vita con una lucidità nuova.
Geografia infruttuosa è un viaggio a ritroso, una mappa disegnata senza più l’urgenza della conquista, ma con la dolcezza della resa. In questa cornice si colloca la poesia “Felicità”, che ha l’aspetto quieto di un bilancio, e la voce serena di chi ha deposto le armi, anche quelle interiori.
Non c’è esaltazione in questi versi, né l’enfasi delle grandi dichiarazioni. C’è una risposta calma, un’affermazione nuda – “Sicuro, sì, rispondo” – che sembra nascere nel silenzio.
Nessuno interroga il poeta, ma lui risponde lo stesso, perché la felicità è forse proprio questo: saper parlare anche quando non c’è domanda, saper riconoscere un senso nell’ombra che ci accompagna. Il viaggio non è più verso l’esterno: è un lento ritornare alla propria casa, al proprio corpo, alla propria storia.
Lo stile e le immagini
Nel tempo della sintesi, anche la lingua si raccoglie. I versi di “Felicità” hanno l’andamento basso, meditativo, proprio delle ultime raccolte di Neruda. Non c’è la musicalità ridondante del Canto generale, né l’estasi amorosa delle Veinte poemas de amor. Qui la parola è asciutta, come levigata dal vento.
Neruda procede per immagini forti ma controllate: il pianto “divorato / dalle sessanta bocche della vita”, la tristezza “come pesca tremante” restituita al mare, la casa di cemento dove si seppellisce la nostalgia. Sono metafore concrete, visive, ma sempre capaci di un doppio livello. Il linguaggio è quello di un uomo che conosce il peso delle cose, e che ora le vuole alleggerire.
C’è anche, nello stile, una sorta di pudore. I sentimenti non esplodono, ma vengono nominati con discrezione: “lutti o dolori”, “tristezza”, “pianto”, parole che scivolano nei versi senza dramma, ma con una gravità sottile. E poi c’è il silenzio: tra le parole, nei versi spezzati, in quel finale che giunge con la stessa solennità di una pietra posata sulla terra.
Il significato di “Felicità”
Intitolare questa poesia “Felicità” è, forse, il gesto più poetico di tutti. Perché la felicità di cui parla Neruda non è quella della giovinezza, né quella delle vittorie o delle passioni accese.
È una felicità spoglia, conquistata a caro prezzo, fatta di assenza e di resa. L’io lirico ha sepolto la nostalgia, ha lasciato che i dolori si dissolvessero, ha restituito al mare ciò che la vita aveva fatto pesare. Ora, finalmente, può stendersi nudo, senza finzioni, senza maschere.
Il mare – immagine ricorrente nella poesia nerudiana – qui non è più impetuoso, ma luogo del ritorno, dell’oblio e della pace. L’ultima immagine è la più potente: “possiedo il sonno duro della pietra”.
È il sonno che non trema, che non sogna, che non teme. Una metafora della morte, certo, ma anche della piena accettazione del proprio destino.
La felicità, allora, è questo: dormire come una pietra, non più agitarsi, non più resistere. È un lasciar andare che somiglia a una vittoria. Dopo una vita spesa nel desiderio, nell’impegno civile, nell’amore e nella lotta, Neruda giunge a questa poesia come si giunge alla riva dopo una lunga traversata. Non resta che il silenzio, la terra, e un senso profondo di quiete. È lì che abita, per lui, la vera felicità.