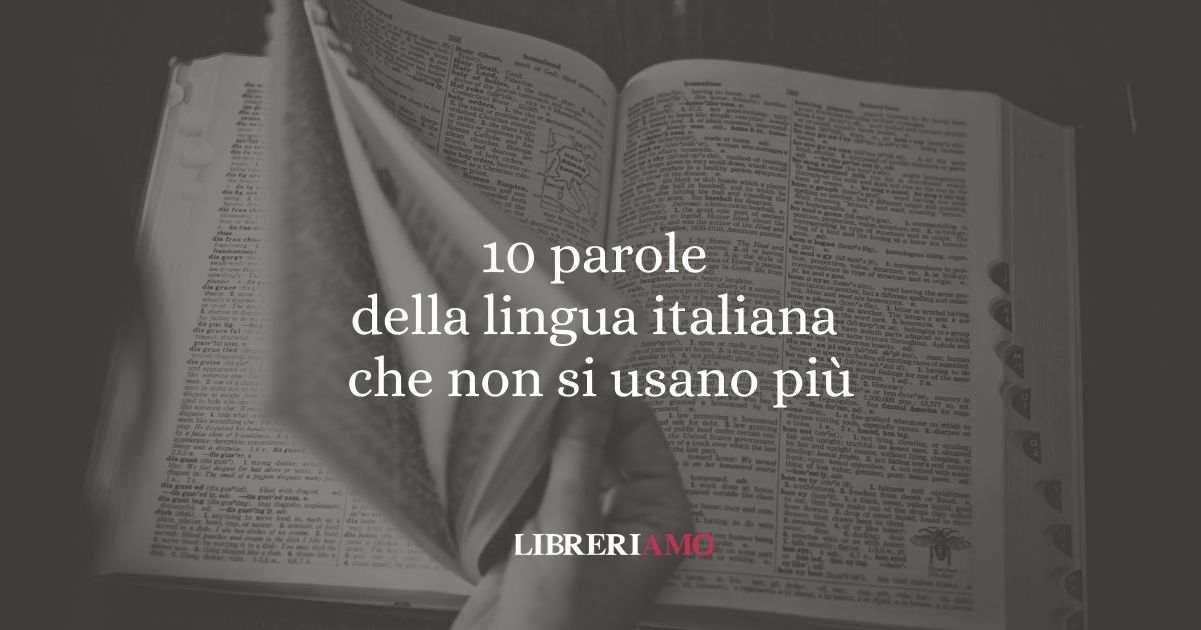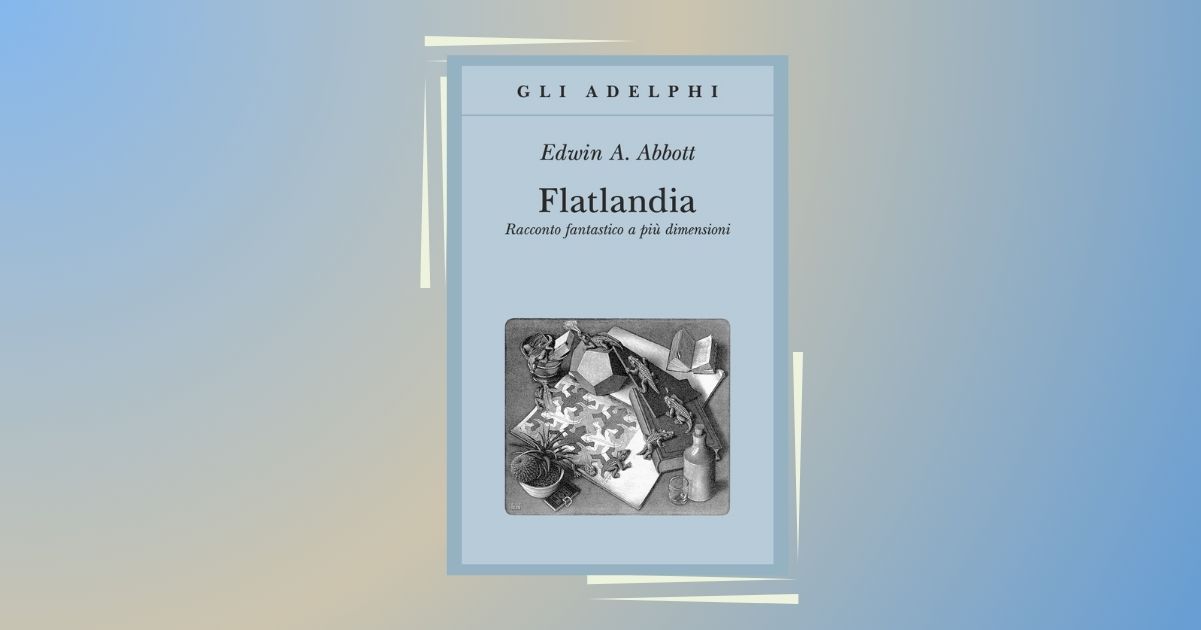“E quindi uscimmo a riveder le stelle” è uno dei versi più celebri della Divina Commedia, diventato nel tempo un inno di rinascita, metafora della voglia di rivalsa dopo momenti bui.
Oggi ricorre l’anniversario di nascita di Dante Alighieri, databile probabilmente il 29 maggio del 1265 secondo quanto riportato da diverse fonti. Sono passati oltre 700 anni dalla nascita del Sommo Poeta, ma i suoi versi non hanno mai smesso di parlare al presente.
E’ incredibile, infatti, come versi scritti secoli fa risultino ancora così attuali. Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno dei suoi versi più celebri.
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”
Si tratta dell’ultimo verso dell’Inferno di Dante e probabilmente uno dei versi più conosciuti al mondo del poeta fiorentino.
Una delle più importanti simmetrie testuali della Divina Commedia è la scelta di chiudere ognuna delle tre cantiche con il medesimo lemma, “stelle”. Questo espediente strutturale serve – secondo Gianfranco Contini – a garantire la perifericità rispetto all’aiuola che si calpesta.
Dopo essersi inabissato negli Inferi ed aver raccontato le turpitudini più inumane, il poeta si lascia alle spalle la profonda notte infernale e si prepara a scalare la montagna della speranza e della redenzione, la montagna del Purgatorio.
Questo passaggio è segnato dall’immagine senza tempo di un cielo stellato, una visione di speranza e rinascita dopo le pene del viaggio infernale.
E quindi uscimmo a riveder le stelle
Il firmamento che Dante ritrova è quello che permette ai marinai di orientare la rotta della navigazione, impedendo loro di smarrirsi nel grande mare dell’essere. Il significato del verso “e quindi uscimmo a riveder le stelle” sta proprio qui. Nei momenti di sconforto, tutti accarezziamo questo verso come un talismano. Nella speranza di poter superare quegli ostacoli esistenziali che ci impediscono di proseguire il nostro itinerario nei giorni e negli anni.
Lo stesso capitò a Dante personaggio quando – all’inizio dell’Inferno – tre fiere gli sbarrarono la strada facendolo arretrare. Sempre più lontano da quel colle luminoso e alto che rappresentava la liberazione dal male. Nel De vulgari eloquentia il poeta aveva scritto che proprio grazie alla dolcezza della poesia era riuscito a gettarsi alle spalle ( « postergamus » ) l’esilio.
La rinascita secondo il Sommo poeta
Il firmamento che Dante ritrova è quello che permette ai marinai di orientare la rotta della navigazione, impedendo loro di smarrirsi nel grande mare dell’essere. Il significato del verso “e quindi uscimmo a riveder le stelle” sta proprio qui. Nei momenti di sconforto, tutti accarezziamo questo verso come un talismano. Nella speranza di poter superare quegli ostacoli esistenziali che ci impediscono di proseguire il nostro itinerario nei giorni e negli anni.
Lo stesso capitò a Dante personaggio quando – all’inizio dell’Inferno – tre fiere gli sbarrarono la strada facendolo arretrare. Sempre più lontano da quel colle luminoso e alto che rappresentava la liberazione dal male. Nel “De vulgari eloquentia” il poeta aveva scritto che proprio grazie alla dolcezza della poesia era riuscito a gettarsi alle spalle (“postergamus”) l’esilio.
Il “riveder le stelle” nella letteratura
Quando era ragazzo, uno dei passatempi preferiti di Giacomo Leopardi era sedersi e alzare gli occhi al cielo: contare le stelle, numerarle ad una ad una. Nei suoi dialoghi monologanti con gli astri, il poeta rivolgeva ai suoi muti interlocutori tutti gli interrogativi intorno al senso del nascere e del morire. L’eco della nostra umanità finiva così per smarrirsi nella vastità infinita delle costellazioni, indifferenti, nel loro remoto baluginare, al doloroso gioco di esistere.
Qualche tempo dopo, Giovanni Pascoli – in una delle sue poesie più famose – aprirà allo sguardo dei lettori un cielo che inonda di un pianto di stelle quest’atomo opaco del male che è il nostro mondo, già descritto dal poeta di Recanati come un oscuro granel di sabbia / il qual di terra ha nome.
Sia Leopardi sia Pascoli devono aver a lungo meditato su quell’endecasillabo della Commedia di Dante (Paradiso, c. XXII, v. 151) che raccoglie l’emozione del turista dell’oltretomba nel momento in cui osserva la terra da una sconfinata lontananza ed essa gli appare come l’aiuola che ci fa tanto feroci.
Noi uomini siamo stipati in questa nave azzurra sospesa nello spazio, una favilla nell’immenso incendio galattico, e trascorriamo l’esistenza – sempre secondo Leopardi – a infelicitarci e distruggerci scambievolmente, ignari che il nostro transito esistenziale è un frego effimero sulla lavagna della storia dell’Universo: una traccia che la spugna del tempo cancella.
La nascita di Dante
Il 29 maggio 1265 è la presunta data di nascita del Sommo Poeta. Questa data è stata scelta convenzionalmente dalla comunità degli amanti di Dante Alighieri come quella di nascita, tanto che anche la Società “Dante Alighieri”, dal 2016, ha deciso di dedicare questa giornata ad una serie di attività e di eventi in onore dell’autore della Commedia.
Sta di fatto che non si sa con assoluta certezza quando sia nato Dante Alighieri e probabilmente non si saprà mai. La data presunta è comunque compresa tra maggio e giugno. Certo è che Dante Alighieri nasce a Firenze.
La Divina Commedia
Diceva Pessoa che “la letteratura, come tutta l’arte, è la prova che la vita non basta.” La Divina Commedia è una contro – creazione che vuole riparare gli uomini e ricucire quella ferita di esistere aperta dentro di loro. Nel firmamento della poesia universale, l’astro di Dante è il più luminoso, quello che più rifulge nella solitudine e nel buio che circonda la vita, quello che meglio potrebbe orientare la nostra navigazione nell’oceano dell’esistenza. Voglio chiudere con una breve lirica di Sandro Penna: ognuno è solo, ma con vario cuore / riguarda sempre le solite stelle.