“Autunno” (1932) di Salvatore Quasimodo, poesia sulla fragilità e la rinascita
Scopri Autunno (1932) di Salvatore Quasimodo, una poesia ermetica che trasforma la stagione in simbolo della fragilità umana e della rinascita.
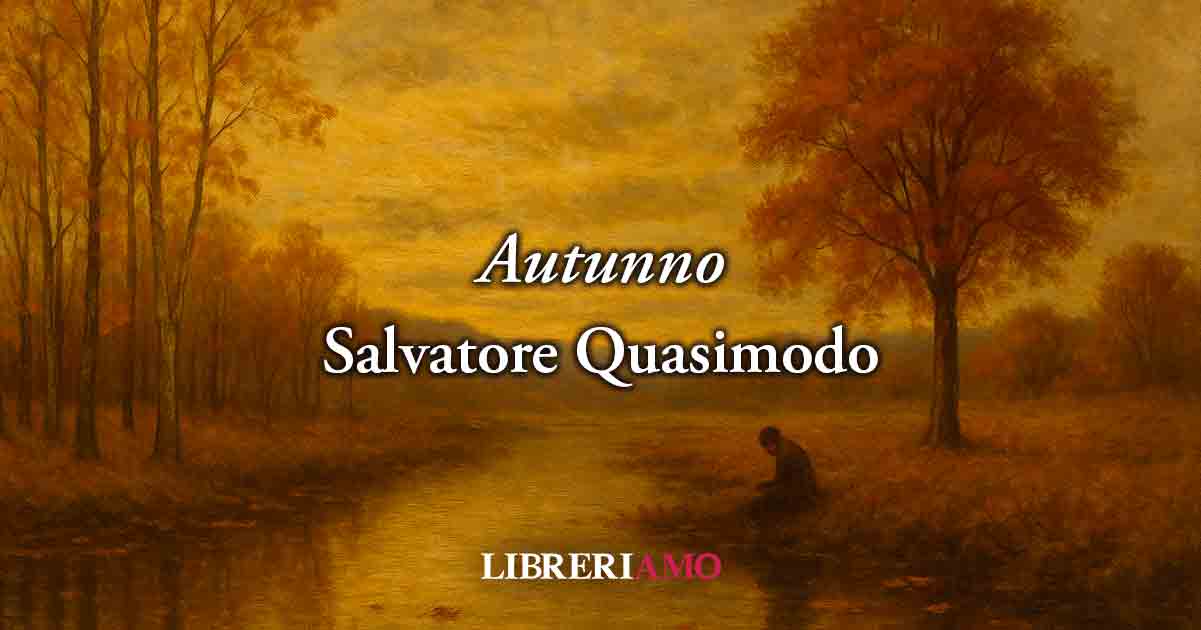
Autunno di Salvatore Quasimodo è un testo breve, essenziale e folgorante, che appartiene alla stagione ermetica dell’autore. Pochi versi bastano al poeta siciliano per trasformare il paesaggio autunnale in una metafora della condizione umana: fragilità, caduta, dolore, ma anche possibilità di rinascita e consolazione.
Ci sono stagioni che non appartengono solo al calendario, ma all’anima. L’autunno, con le sue luci che si spengono presto e le foglie che scivolano a terra, è da sempre il tempo della malinconia e della riflessione. Nella breve e folgorante lirica Autunno, il poeta siciliano condensa in pochi versi una meditazione universale sul dolore di vivere e sulla possibilità di ritrovare pace proprio nell’accettazione del ciclo naturale.
Autunno è contenuta nella raccolta di poesie Oboe sommerso di Salvatore Quasimodo, pubblicata per la prima volta nel 1932. Serve sottolineare che questa raccolta rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso del poeta verso l’Ermetismo più maturo. Se Acque e terre (1930) già mostrava un distacco dalla tradizione e una ricerca di un linguaggio più intimo e personale, è con quest’opera che Quasimodo definisce con maggior forza la sua adesione a quella corrente.
Leggiamo questa breve ma intensa poesia di Salvatore Quasimodo per coglierne il profondo significato.
Autunno di Salvatore Quasimodo
Autunno mansueto, io mi posseggo
e piego alle tue acque a bermi il cielo,
fuga soave d’alberi e d’abissi.
Aspra pena del nascere
mi trova a te congiunto;
e in te mi schianto e risano:
povera cosa caduta
che la terra raccoglie.
L’autunno come specchio dell’esistenza
Nella poetica di Salvatore Quasimodo l’autunno non è una semplice stagione, ma un simbolo capace di riflettere le contraddizioni dell’animo umano. È il tempo della malinconia e del raccoglimento, in cui la natura stessa diventa specchio del dolore di vivere e, al tempo stesso, promessa di rinnovamento.
Con Autunno, il poeta ermetico riesce a racchiudere in pochissimi versi una meditazione universale: la vita è segnata da fragilità e caduta, ma la natura offre consolazione trasformando ogni fine in un nuovo inizio. La lirica, parte della raccolta Oboe sommerso (1932), rappresenta uno dei momenti più intensi della prima produzione di Quasimodo, quella in cui la parola poetica si fa essenziale, simbolica, capace di dire molto con pochissimo.
È in questa prospettiva che va letta la poesia: non come descrizione paesaggistica, ma come allegoria metafisica dell’esistenza, un intimo colloquio con la natura che si traduce in riflessione sull’uomo e sul suo destino.
Il paesaggio come specchio dell’anima
La poesia di Salvatore Quasimodo si apre definendo la stagione delle foglie cadenti.
Autunno mansueto, io mi posseggo
e piego alle tue acque a bermi il cielo,
fuga soave d’alberi e d’abissi.
L’autunno è “mansueto”. La stagione non è aspra o minacciosa, ma dolce e accogliente. Per “mansueto” intendiamo pure gestibile, controllabile. Il poeta vi riconosce un rifugio interiore, un luogo in cui “si possiede”, ovvero ritrova sé stesso.
L’immagine delle acque che riflettono il cielo diventa simbolo di introspezione e fusione cosmica: un gesto di umiltà e sete spirituale. La “fuga soave” degli alberi e degli abissi non è semplice descrizione paesaggistica, ma rappresentazione di un dissolversi lento, dolce, in cui la natura e l’animo umano sembrano confondersi.
La pena del nascere
Nella seconda terzina emerge il cuore drammatico della poesia, la fonte che stimola la riflessione.
Aspra pena del nascere
mi trova a te congiunto;
e in te mi schianto e risano:
La vita è segnata dalla “pena del nascere”, una condanna originaria che porta con sé la certezza della morte. Eppure nell’autunno il poeta riconosce un compagno di destino. Si sente “congiunto”, unito da una sorte comune. La tensione tra dolore e rigenerazione è racchiusa nel verso “mi schianto e risano”. Emerge il crollo e la guarigione, la frattura e la catarsi, due movimenti che si susseguono come parte inevitabile del vivere.
Questi versi sono meravigliosi perché diventano espressione della poetica di Salvatore Quasimodo e offrono l’idea di una mancanza di scelta alla nascita. Un pensiero filosofico di grande significato, perché riesce ad esprimere il senso che la vita è qualcosa che viene imposta e dalla quale bisogna saper trovare la strada per ritrovare la libertà di esistere. Non ho deciso di nascere, ma ho deciso di vivere, è questo il senso.
Liberarsi dal dolore e rinascere, equivale ad una liberazione vera e propria.
La volontà di liberarsi dal dolore e rinascere
La chiusura della poesia sembra anticipare la riflessione precedente.
povera cosa caduta
che la terra raccoglie.
Il finale della poesia di Salvatore Quasimodo concentra il senso dell’intera lirica in un’immagine semplice ma folgorante. L’uomo è una foglia che cade, fragile e priva di orgoglio, ma non abbandonata. La terra lo raccoglie, lo custodisce, gli offre le giuste possibilità di trovare la propria armonia, di liberarsi, di rigenerarsi a nuova esistenza.
Non è la disperazione dell’annientamento, ma l’opportunità di un ritorno. La fine si trasforma in ricongiungimento con l’origine. In questa prospettiva, la morte appare non come tragedia assoluta, ma come parte di un ritmo cosmico che tutto accoglie e rinnova.
Autunno e la lezione di Salvatore Quasimodo
Ciò che rende importante e originale Autunno non è la descrizione di una stagione, ma la rivelazione che ogni caduta porta con sé un senso nascosto. Salvatore Quasimodo non ci parla della morte come annientamento, ma come ritorno, come ricongiungimento con una terra che non giudica, non respinge, ma raccoglie. In questi versi la fragilità non è debolezza, ma condizione che lega a tutto ciò che vive: alberi, foglie, acqua, cielo.
La grandezza della poesia sta nel trasformare l’esperienza più intima, la paura della fine, in un’immagine capace di consolare senza illudere. L’uomo, povera cosa caduta, scopre di non essere solo. La Terra lo custodisce, lo assorbe, lo trasforma. È un pensiero che attraversa i secoli e le culture, ma che in Quasimodo si condensa in parole essenziali, spoglie, taglienti come la verità.
Per questo Autunno è ancora attuale. Invita a guardare la fragilità tipica degli umani non come un difetto, ma come il segno più autentico della loro appartenenza al mondo. È una poesia che non offre risposte facili, ma che lascia un’immagine da custodire: la terra che raccoglie, silenziosa e pietosa, ogni caduta.
In Autunno la voce di Salvatore Quasimodo non è solo quella di un poeta, ma quella di chi ha osato guardare il tempo senza veli. L’autunno non è semplice stagione, ma figura del destino umano: ricorda che ogni vita nasce con una ferita originaria, il sapere che finirà, e che tuttavia questa ferita è la condizione stessa che lega al mondo.
Non c’è malinconia nei versi della poesi, ma una rivelazione. Ogni caduta è parte di un ritmo più grande, in cui il dissolversi non coincide con il nulla, ma con un ritorno, con una continuità che trascende la stessa vita. La terra che raccoglie è il simbolo ultimo di questa verità. Gli umani non dono soli nella loro fragilità, ma immersi in un ordine che custodisce.
Così Salvatore Quasimodo consegna ai posteri una visione radicale e universale. Il tempo non va considerato come il nemico, ma come la trama che ricongiunge all’infinito. Autunno diventa allora un invito a riconciliarci con fine, che non è perdita, ma passaggio. In questa prospettiva, la poesia si fa filosofia del vivere. Un frammento di saggezza che, nella sua essenzialità, riesce a toccare l’enigma più antico, quello del rapporto con il tempo, la morte e la possibilità di rinascere.